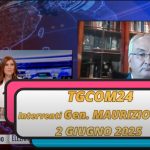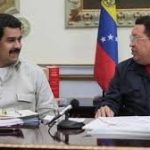Il punto sulla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha introdotto un paradigma militare inedito, dove la tecnologia ridefinisce le regole del gioco. La Russia ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento a un campo di battaglia in cui la dissimulazione è diventata quasi impossibile.
Grazie al supporto massiccio di intelligence satellitare ed elettronica fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina, ogni concentrazione o movimento di truppe è sotto costante monitoraggio. In questo contesto, i droni – di tutte le portate e carichi utili – si sono affermati come strumenti economici e letali, capaci di distruggere il potenziale nemico con precisione chirurgica. La guerra elettronica, combinata con l’uso massiccio di droni, ha permesso alla Russia di compensare le sfide iniziali e di consolidare la sua superiorità tattica.
Tuttavia, la tecnologia non risolve tutto. L’Ucraina si trova a fronteggiare una crisi umana senza precedenti. Con una popolazione di circa 35 milioni di abitanti – quattro volte inferiore a quella russa, stimata in 140 milioni – l’esercito ucraino, composto in gran parte da coscritti, è stremato dopo tre anni di conflitto. Le perdite sul campo, le diserzioni e le fughe all’estero (testimoniate da numerosi video circolanti sui social media) hanno reso la mobilitazione di nuove leve un problema insormontabile.

Molti giovani ucraini, costretti al fronte contro la loro volontà, cercano di evitare il combattimento, mentre altri tentano di nascondersi o di lasciare il Paese. Al contrario, la Russia dispone di un esercito professionale, composto prevalentemente da volontari attratti da salari elevati, con circa 30.000 nuove reclute ogni mese. Questo flusso costante di uomini garantisce a Mosca una riserva di forze fresche, senza i problemi di reclutamento che affliggono Kiev.
La strategia russa: aggiramenti e comando rinnovato
Sul piano operativo, la Russia ha affinato una strategia che privilegia l’efficienza e minimizza le perdite. Di fronte a città ucraine trasformate in fortezze, come Pokrovsk, con oltre 5.000 abitanti, il comando russo evita gli assalti frontali, preferendo tattiche di accerchiamento. Le forze russe tagliano le linee di rifornimento nemiche, isolando le postazioni ucraine, e colpiscono con un arsenale combinato di bombe plananti, missili, artiglieria e droni kamikaze. Una volta indebolite le difese, piccoli commando di forze speciali vengono inviati per neutralizzare le ultime resistenze.
Questa strategia ha permesso un’accelerazione impressionante: nel 2025, la Russia avanza a una media di 30 km² al giorno, rispetto ai 30 km² al mese registrati nel 2024. Le recenti offensive a Kursk, nel Donbass e attorno a Kherson testimoniano l’efficacia di questo approccio.

Un altro fattore determinante è il rinnovamento della catena di comando russa. Vladimir Putin, a differenza di Volodymyr Zelensky, non interferisce direttamente nelle operazioni militari, limitandosi a orientamenti strategici generali.
Un esempio emblematico è la sua decisione, durante l’assedio di Mariupol, di evitare un assalto diretto all’acciaieria Azovstal per preservare le vite dei soldati russi. Putin si concentra invece sulla selezione di comandanti capaci, promuovendo una nuova generazione di generali.
Tra questi spicca Andreï Mordvitchev, nominato a soli 49 anni capo di stato maggiore delle forze terrestri, una enorme responsabilità per un esercito con 14 divisioni operative, dieci volte più grande di quello francese. Mordvitchev, che dal febbraio 2023 ha guidato le forze del distretto militare centrale – dove i russi hanno registrato le maggiori avanzate, avvicinandosi ai confini dell’oblast di Donetsk – è stato sostituito dal colonnello generale Valeri Solodtchouk, 54 anni, artefice della riconquista di Kursk. Queste nomine riflettono un ringiovanimento strategico, che ha dato nuovo slancio alle operazioni russe.
Zelensky in difficoltà, NATO e UE in affanno
A differenza di Putin, Zelensky utilizza le operazioni militari come strumento di comunicazione politica, cercando di mantenere il sostegno degli alleati occidentali. Questa strategia, però, ha avuto costi umani devastanti.
Tra gli esempi più eclatanti, l’ordine di resistere a oltranza in posizioni insostenibili, come il ponte di Bakhmut, dove i soldati ucraini sono stati lasciati morire; l’offensiva dell’estate 2023, che ha decimato 12 brigate senza ottenere risultati significativi; e l’incursione a Kursk, costata la perdita di tre delle migliori brigate ucraine. Queste scelte, spesso criticate anche da fonti occidentali, hanno indebolito ulteriormente l’esercito ucraino, minando la fiducia dei soldati e della popolazione.

L’Unione Europea, da sola, non ha la capacità di sostenere l’Ucraina a lungo termine. Anche con il supporto della NATO, l’Occidente fatica a tenere il passo con la produzione militare russa. Un esempio lampante è la superiorità di Mosca nella produzione di munizioni da 155 mm, un’arma cruciale per il conflitto.
Come evidenziato da un commodoro britannico in pensione, nessun grande Paese NATO si è mobilitato industrialmente per la guerra. Se l’Europa temesse davvero un’espansione russa, avrebbe già riconvertito le sue industrie, ma ciò non è avvenuto.
In un’ipotetica escalation, le vulnerabilità occidentali sarebbero evidenti. Gli Stati Uniti dovrebbero trasportare truppe e rifornimenti attraverso l’Atlantico, esponendosi agli attacchi dei sottomarini russi, contro cui l’Europa non dispone di adeguate difese navali o aeree.
Le infrastrutture chiave – porti, aeroporti, basi logistiche – sarebbero bersagli facili per missili balistici come l’Oreshnik, che viaggia a Mach 10+ e contro cui le difese NATO sono praticamente inesistenti. Inoltre, l’Europa dipende fortemente dalle importazioni di idrocarburi (petrolio e GNL), e un’interruzione di queste forniture metterebbe in ginocchio la sua economia.

Le forze NATO, addestrate per conflitti asimmetrici, mancano di esperienza nei combattimenti di attrito tra pari, mentre l’esercito russo, con tre anni di esperienza sul campo, si è dimostrato il più resiliente al mondo. Infine, il processo decisionale della NATO, che richiede il consenso di molteplici Paesi, è troppo lento per rispondere efficacemente a una crisi.
Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca aggiunge ulteriori incognite. La sua amministrazione sembra orientata a ridurre l’impegno diretto in Ucraina, spingendo per negoziati che potrebbero ridisegnare gli equilibri del conflitto. Questo cambio di rotta mette in discussione la strategia occidentale, che finora si è basata su un sostegno militare massiccio ma non sempre efficace.
Prospettive diplomatiche
Con l’avvicinarsi dell’estate, il conflitto si trova a un bivio cruciale. Le discussioni dirette tra Trump e Putin lasciano intravedere la possibilità di un accordo. La Russia potrebbe limitare le sue ambizioni ai quattro oblast annessi nel settembre 2022 (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson), utilizzando i territori conquistati a Sumy e Kharkiv come moneta di scambio per le porzioni di questi oblast ancora sotto controllo ucraino. La proposta di Putin di creare una zona cuscinetto di 100 chilometri lungo il confine nord dell’Ucraina sembra mirata a impedire a Kiev di acquisire missili a medio raggio, garantendo a Mosca un margine di sicurezza strategica.

Questo suggerimento, avanzato in un’ottica di negoziato, potrebbe anche servire a rafforzare la posizione di Trump, mostrando che senza pressioni su Zelensky il costo per l’Ucraina sarà ancora più alto nel 2026.
Tuttavia, la Francia e parte dell’Unione Europea sembrano riluttanti ad accettare un compromesso. Escluse dai negoziati, queste voci trovano eco nei media e nei circoli democratici americani, ancora ostili a Trump. La retorica bellicosa di Bruxelles, però, non è sostenuta da una reale capacità militare.
La Bundeswehr tedesca è notoriamente a corto di risorse, mentre la Francia, pur dotata di una credibile dissuasione nucleare, dispone di forze convenzionali limitate. La proposta di Emmanuel Macron di “condividere” l’arsenale nucleare francese appare più come un gesto simbolico che una strategia concreta, tanto più che la sua credibilità internazionale è in declino, sia in Francia che all’estero.
Per gli Stati membri più moderati, come Ungheria e Slovacchia, il margine di manovra è ristretto. La retorica bellicosa dell’UE non è supportata da una forza militare credibile, e la dipendenza dagli Stati Uniti per armamenti e decisioni strategiche limita l’autonomia europea.

La reintegrazione della Francia nella struttura militare della NATO sotto Nicolas Sarkozy ha ulteriormente ridotto la sovranità strategica di Parigi, lasciando le decisioni chiave a Washington. In questo contesto, i movimenti sovranisti, spesso etichettati come “estrema destra” in Europa, stanno guadagnando terreno, trovando sponde nel movimento MAGA di Trump. Leader come Giorgia Meloni, accolti con favore a Washington, rappresentano un’alternativa a chi continua a vedere nella Russia la principale minaccia, ignorando questioni interne come l’immigrazione incontrollata e l’islamismo.
Cessate il fuoco o escalation?
Lo scenario più probabile per il 2025 è un cessate il fuoco basato sui confini amministrativi dei quattro oblast annessi dalla Russia nel 2022. I russi potrebbero evacuare Sumy e Kharkiv, usandoli come moneta di scambio per consolidare il controllo sui territori contesi. La proposta di una zona cuscinetto di 100 km potrebbe servire a garantire la sicurezza russa e a limitare le capacità offensive ucraine.
Un tale accordo, se raggiunto, rappresenterebbe un compromesso pragmatico, ma porrebbe l’Europa di fronte a una scelta cruciale: continuare a inseguire una vittoria militare irrealistica o accettare una soluzione negoziata che preservi la stabilità continentale.

I rischi di un’escalation, però, non sono trascurabili. Senza un aumento massiccio degli investimenti militari, l’Europa e la NATO non saranno in grado di colmare le loro lacune strategiche per almeno un decennio. La dipendenza dagli Stati Uniti, unita alla fragilità economica e infrastrutturale del continente, rende l’Europa vulnerabile in un conflitto prolungato.
D’altro canto, un cessate il fuoco potrebbe aprire opportunità per una ridefinizione della sicurezza europea, spingendo i Paesi membri a investire in una maggiore autonomia strategica e a riconsiderare le priorità interne, come la gestione dell’immigrazione e la lotta al radicalismo.

Nonostante le difficoltà, c’è spazio per l’ottimismo. Un cessate il fuoco entro il 2025, basato su un compromesso territoriale e su garanzie di sicurezza, potrebbe porre fine alla fase più acuta del conflitto. Tuttavia, ciò richiederà un cambio di mentalità da parte dell’Europa, che dovrà abbandonare la retorica bellicosa e accettare la realtà di un mondo multipolare. La strada della negoziazione, per quanto complessa, resta l’unica via praticabile per garantire la stabilità a lungo termine.
Foto TASS e Ministero Difesa Ucraino

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.