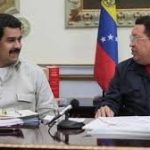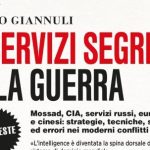La guerra che non finisce mai

Il 13 giugno scorso Israele ha lanciato un’offensiva militare aperta contro l’Iran, convinta di poter colpire in modo rapido e decisivo le strutture nevralgiche militari ed economiche del regime di Teheran. L’obiettivo era chiaro: decapitare la leadership iraniana attraverso una campagna simultanea di assassinii mirati contro scienziati del programma nucleare, eliminare il vertice politico e destabilizzare i centri di potere. Una strategia fondata sull’idea che una combinazione di panico interno, pressione militare e crisi istituzionale avrebbe provocato il collasso della Repubblica islamica in tempi brevi.
Nella visione israeliana e americana, l’Iran veniva ridotto a un regime retrogrado, sostenuto solo da una cerchia di mollah odiati dalla popolazione e considerati incapaci di resistere a una pressione coordinata. Gli agenti dormienti infiltrati negli anni avrebbero dovuto completare l’opera. Il risultato atteso era la caduta del regime come un castello di carte, coronata da un cambio di potere favorevole a Tel Aviv e Washington. È la logica della “guerra preventiva” spinta al massimo: eliminare la minaccia prima che possa diventare reale, sostituendo un nemico con un governo più accondiscendente.
Ma l’euforia non porta necessariamente al trionfo. L’Iran non è caduto. Anzi, ha risposto con forza, dimostrando che il mito dell’invincibilità israeliana non è intoccabile. Gli attacchi iraniani massicci, con droni e missili, hanno messo a dura prova le difese di Israele, costringendo Washington a intervenire direttamente per evitare un disastro a Tel Aviv. Per anni il governo israeliano aveva sognato di trascinare gli Stati Uniti in una guerra permanente contro l’Iran. Quel sogno si è realizzato solo in parte, e non senza un prezzo altissimo.
La tregua di Trump: un cessate il fuoco fragile
In questo quadro, la recente mediazione internazionale promossa da Donald Trump, con la firma di un cessate il fuoco tra Israele, Iran ed Egitto, Turchia e Qatar come garanti regionali, rappresenta una svolta tanto clamorosa quanto fragile. La Casa Bianca ha scelto di capitalizzare politicamente l’escalation per ottenere un accordo che eviti un ulteriore logoramento della posizione americana in Medio Oriente. Washington ha fatto pressione su Tel Aviv per congelare l’offensiva e ha offerto a Teheran una via d’uscita negoziale, in cambio di garanzie sulla non proliferazione nucleare e di limiti al supporto a gruppi armati regionali.

Tuttavia, la pace firmata non ha lo spessore di un trattato strutturale: è un equilibrio precario, fondato sulla convergenza temporanea di interessi più che su una vera riconciliazione strategica. Da un lato Israele ottiene un rallentamento delle tensioni che le consente di evitare un conflitto prolungato; dall’altro Teheran preserva la sua architettura di deterrenza e rafforza il proprio status internazionale come attore che non può essere piegato con la forza. Trump, da parte sua, incassa un successo politico immediato, presentandosi come “pacificatore” in un conflitto che rischiava di degenerare.
Ma l’assenza di un accordo sulle questioni strutturali — come il ruolo regionale dell’Iran, la sicurezza israeliana e la ridefinizione degli equilibri tra grandi potenze — rende questa tregua potenzialmente effimera. Si tratta, più realisticamente, di una pausa tattica in una guerra strategica molto più lunga.
Il costo di un azzardo strategico
L’offensiva israeliana si è trasformata rapidamente in un boomerang. La distruzione mirata delle strutture nucleari iraniane non ha raggiunto i risultati sperati, mentre Teheran ha reagito rafforzando la propria legittimità interna. L’idea che la pressione militare avrebbe paralizzato la popolazione si è rivelata fallace. L’Iran ha mostrato una capacità di resilienza politica, tecnologica e militare che i pianificatori occidentali avevano colpevolmente sottovalutato.
Per Washington e Tel Aviv il bilancio è pesante: le speranze di annientare l’infrastruttura nucleare iraniana si sono infrante contro i limiti operativi e contro la realtà geopolitica di un mondo sempre meno unipolare. L’Iran non solo ha resistito, ma ha rilanciato rafforzando le sue difese aeree, stringendo nuove collaborazioni militari e tecnologiche con Mosca e Pechino. L’offensiva si è trasformata in un’occasione per consolidare un asse strategico alternativo a quello occidentale.

Il regime iraniano ha inoltre capitalizzato politicamente l’attacco, alimentando un nazionalismo difensivo che ha unito l’opinione pubblica. Se l’obiettivo israeliano era fratturare il Paese, l’effetto è stato opposto: Teheran ha rafforzato la propria posizione interna e internazionale, ponendo i leader occidentali di fronte a una realtà scomoda.
La “guerra preventiva” che non finisce mai
Il vero nodo della questione va ben oltre il programma nucleare. L’attacco israeliano all’Iran non è stato solo una mossa militare: è stato il tentativo di riaffermare una supremazia strategica in declino. Israele e Stati Uniti si muovono dentro una logica che considera il controllo della regione mediorientale come una condizione imprescindibile per mantenere la propria centralità geopolitica. Ma questa logica si scontra oggi con la crescente assertività di potenze come Russia e Cina, decise a non lasciare campo libero all’Occidente.
L’operazione israeliana, lungi dall’indebolire l’Iran, ha accelerato processi già in atto. Teheran ha intensificato i propri legami con Mosca e Pechino, aprendo canali di cooperazione più ampi sul piano militare e tecnologico. La retorica della “guerra preventiva” si è scontrata con la realtà di un sistema internazionale multipolare in cui l’Iran non è più isolato come in passato.
L’asse Iran–Russia–Cina come sfida strategica
Per Washington la posta in gioco è enorme. L’Iran non rappresenta solo una minaccia regionale, ma una sfida sistemica: è uno dei pilastri dell’asse con Russia e Cina, un blocco che si propone come alternativa politica, economica e strategica all’Occidente. Questa alleanza si inserisce nei corridoi di connettività che uniscono l’Eurasia, creando un tessuto infrastrutturale e commerciale che riduce la centralità americana e europea.

In questo contesto, Israele è usato come punta di lancia per contenere l’espansione di questo asse. Ma l’operazione militare non ha fatto che rafforzare il legame tra Teheran, Mosca e Pechino, consolidando il fronte opposto. La risposta iraniana ha dimostrato che questo triangolo non è un’alleanza di facciata, ma una vera e propria architettura di resistenza globale.
La crisi della strategia occidentale
Le potenze occidentali si trovano così di fronte a una crisi di strategia. Non basta più la forza militare per mantenere il controllo di aree chiave. L’idea di poter determinare il destino di Paesi terzi con campagne di bombardamenti chirurgici si è infranta contro la resilienza delle potenze emergenti. L’Iran non è l’Iraq né la Libia: è una potenza regionale di 87 milioni di abitanti, con un alto livello tecnologico e una solida rete di alleanze. Un attacco limitato, pensato per indebolire, rischia di provocare invece una controffensiva duratura e destabilizzante.
Gli strateghi statunitensi e israeliani hanno ignorato un elemento fondamentale: la guerra preventiva non è più un’opzione priva di costi. In un mondo multipolare, ogni attacco diventa un acceleratore di alleanze alternative. La risposta iraniana ha reso evidente che il costo politico e militare per l’Occidente sarà altissimo, e che la vittoria rapida è ormai un’illusione.
Un equilibrio sempre più fragile
L’escalation tra Israele e Iran non è solo un conflitto bilaterale. È un tassello di un confronto globale tra potenze, in cui si giocano i futuri equilibri strategici. L’attacco israeliano, lungi dall’aprire la strada a una “vittoria preventiva”, ha rivelato l’esaurimento di un paradigma geopolitico: quello in cui l’Occidente decideva unilateralmente, e gli altri subivano. Oggi la realtà è diversa: le controparti sanno colpire, sanno resistere e dispongono di alleati.

La tregua mediata da Trump offre una pausa ma non risolve nulla. Dietro le firme e le foto di rito restano intatti gli obiettivi strategici contrapposti. E per questo la guerra tra Israele e Iran rischia di trasformarsi in una guerra senza fine. Una spirale di provocazioni, ritorsioni e alleanze contrapposte che può travolgere non solo il Medio Oriente ma l’intero equilibrio globale. E la vera domanda, a questo punto, non è se Israele vincerà, ma quanto a lungo l’Occidente sarà disposto a sostenere una guerra che ha perso la capacità di decidere da sola l’esito finale.
Foto Casa Bianca

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.