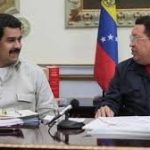Sanae Takaichi e la nuova “linea dura” di Tokyo nell’Asia-Pacifico

Con l’arrivo di Sanae Takaichi alla guida del governo giapponese, la continuità con l’eredità di Shinzo Abe non è solo ideologica, ma strategica. Conservatrice di ferro, da anni vicina ai settori più nazionalisti del Partito Liberal Democratico, Takaichi ha sempre considerato Taiwan non come un “dossier sensibile” da trattare con discrezione, ma come un tassello centrale dell’architettura di sicurezza del Giappone. Prima da ministra e poi da premier, ha visitato Taipei, parlato apertamente di cooperazione sulle “sfide difensive” e legato la sicurezza dell’isola alla sopravvivenza stessa del Giappone.
Sul piano interno, ha anticipato al 2% del PIL l’obiettivo di spesa militare, comprimendo i tempi di un riarmo già in atto, e ha messo mano alla Strategia di Sicurezza Nazionale e ai documenti collegati, con un orizzonte di revisione entro il 2027. Ufficialmente si tratta di “rafforzare la postura difensiva” in un contesto regionale più instabile. In pratica, significa preparare il paese a uno scenario in cui un conflitto su Taiwan non è più un’ipotesi remota, ma una possibilità per la quale va costruita una risposta politico-militare credibile.
Taiwan come “linea rossa” della sicurezza giapponese
Le parole pronunciate in parlamento il 7 novembre segnano un salto di qualità. Dire che un attacco cinese a Taiwan, o un blocco dell’isola, potrebbe configurare una “situazione che minaccia la sopravvivenza del Giappone” significa collegare direttamente il destino di Taipei alla dottrina elaborata con le leggi del 2015 sulle Forze di Autodifesa. In quel quadro, Tokyo può intervenire militarmente non solo per difendere il proprio territorio, ma anche per soccorrere un alleato, in primo luogo gli Stati Uniti, se la propria sopravvivenza è in gioco.
Non è più solo la consueta formula diplomatica su “pace e stabilità nello stretto di Taiwan” come interesse vitale: è l’indicazione, sia pure avvolta nel linguaggio delle ipotesi, che blocchi navali, attacchi a navi americane o una chiusura dello stretto avrebbero conseguenze dirette sulla sicurezza, sull’economia e sui collegamenti marittimi giapponesi. In un paese che importa la maggior parte dell’energia via mare e dipende da rotte che passano a ridosso di Taiwan e del Mar Cinese Meridionale, il messaggio è chiaro: toccare Taiwan significa stringere la gola al Giappone.

A Taipei, le dichiarazioni di Takaichi sono state accolte come la conferma di ciò che molti dirigenti taiwanesi speravano: un Giappone meno cauto, più disposto a esporsi, più allineato alla dottrina statunitense di contenimento della Cina. Il presidente Lai Ching-te ha definito la premier una “amica ferma di Taiwan”, mettendo sul tavolo il vocabolario dei “valori condivisi” – democrazia, libertà, stato di diritto – che negli ultimi anni è diventato il codice comune delle intese non ufficiali tra Tokyo e Taipei.
Dietro le parole, c’è un’agenda concreta: cooperazione in tecnologia, catene di approvvigionamento dei semiconduttori, prevenzione dei disastri, coordinamento sulle rotte marittime e, sullo sfondo, una più stretta consultazione in materia di sicurezza. Per Taiwan, accerchiata militarmente da Pechino e diplomaticamente isolata, avere un Giappone più esplicito significa rafforzare il fronte delle democrazie dell’Indo-Pacifico, anche senza trattati formali.
La reazione di Pechino: ritorno della retorica sul “militarismo giapponese”
Se Taipei festeggia, Pechino reagisce. Definire un intervento giapponese a sostegno di Taiwan come passibile di “sconfitta schiacciante” non è solo una minaccia militare: è un messaggio politico all’intera regione. Il ministero della Difesa cinese rimette in campo l’accordo del 1972 – quello con cui Tokyo riconobbe la Repubblica Popolare come unico governo legittimo della Cina – e accusa il Giappone di violarne lo spirito, interferendo negli “affari interni” cinesi.
Si riaccende così la retorica della “diplomazia del guerriero lupo”: post aggressivi di diplomatici sui social, giornali di Stato che evocano il ritorno del militarismo giapponese, richiami alle atrocità della guerra in Cina e alle ferite mai rimarginate del massacro di Nanchino. È una doppia operazione: verso l’esterno, per delegittimare la nuova linea di Tokyo; verso l’interno, per ricordare ai cittadini cinesi chi è il “nemico storico” in Asia nordorientale e saldare consenso attorno alla leadership di Pechino.
Memoria storica, opinione pubblica e rischio di escalation
Il contesto dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale aggiunge peso simbolico alle parole. Ogni volta che in Giappone si parla di “normalizzazione” militare, in Cina si riapre il catalogo dei torti storici: invasioni, occupazione, crimini di guerra. L’idea che il Giappone possa tornare ad avere un ruolo militare attivo fuori dai propri confini viene presentata come una minaccia alla stabilità regionale.
Per Takaichi, questo è il prezzo da pagare per emancipare il Giappone da un pacifismo che molti, nella destra conservatrice, considerano ormai irrealistico. Per Pechino, è un’occasione per spingere il mondo a diffidare di un riarmo giapponese che, combinato con la presenza degli Stati Uniti e il sostegno a Taiwan, rischia di configurare un fronte ostile lungo tutto il fianco orientale della Cina.

Dietro il linguaggio della sicurezza, rimane un dato fondamentale: Giappone e Cina sono le due maggiori economie dell’Asia, con catene del valore profondamente intrecciate. Un irrigidimento frontale su Taiwan non avrebbe solo effetti militari, ma colpirebbe commercio, investimenti e tecnologie. L’aggiornamento della strategia di sicurezza giapponese punta, tra le altre cose, a ridurre le vulnerabilità economiche: diversificazione delle forniture, protezione delle tecnologie sensibili, controllo degli investimenti strategici cinesi in settori chiave.
Questo è il lato geoeconomico della svolta: mentre si parla di scenari di guerra, i governi lavorano per rendere meno doloroso, per le proprie economie, un eventuale decoupling parziale da Pechino. Ma nessuno, né a Tokyo né a Pechino, può permettersi un taglio netto. Il risultato è una relazione ambivalente: competizione strategica e cooperazione economica che avanzano in parallelo, con Taiwan come punto più sensibile di attrito.
Le ambiguità di Tokyo tra APEC e parlamento
Non va dimenticato che Sanae Takaichi, poche settimane prima delle dichiarazioni su Taiwan, ha incontrato Xi Jinping al vertice APEC in Corea del Sud, parlando di “relazione mutuamente benefica” e sollevando sì le preoccupazioni sul Mar Cinese Orientale, ma in un linguaggio misurato. È il doppio registro tipico del Giappone: messaggi rassicuranti nei contesti multilaterali, toni più franchi in parlamento e nel dibattito interno.
Quando le parole su Taiwan hanno provocato il contraccolpo cinese, la premier ha precisato che si trattava di scenari “ipotetici” e ha promesso di evitarli nelle sedute future. È il tentativo di rientrare nei margini dell’ambiguità, senza smentire la sostanza della sua linea. Non a caso, figure come l’ex premier Shigeru Ishiba hanno criticato la scelta di esporsi così direttamente, non tanto nel merito quanto nei tempi e nei modi.

L’aggiornamento della strategia di sicurezza entro il 2027 sarà il banco di prova per capire se le parole di Takaichi resteranno un segnale politico o diventeranno dottrina codificata. Se Taiwan verrà definita implicitamente, o esplicitamente, come interesse vitale del Giappone, l’intero assetto regionale cambierà: le Forze di Autodifesa dovranno essere pronte a operare in scenari di conflitto ad alta intensità; l’alleanza con gli Stati Uniti assumerà una dimensione ancora più integrata; i rapporti con la Cina entreranno in una fase di fredda ostilità strutturale.
Per ora, la premier cammina sul crinale: rassicura gli alleati, manda segnali a Taipei, provoca la reazione di Pechino ma torna, almeno nelle forme, dentro il lessico tradizionale della prudenza giapponese. È il segno di un paese che sente di non poter più restare spettatore, ma che non ha ancora deciso fino a che punto è disposto a pagare il prezzo – militare, economico, storico – di questa nuova centralità.
Foto: Governo Giapponese

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.