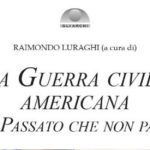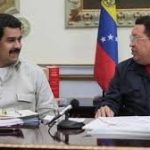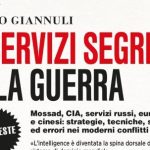Un accordo di pace che ridisegna l’Europa

Il piano in 28 punti elaborato dall’amministrazione di Donald Trump per fermare la guerra in Ucraina non è solo una proposta di cessate il fuoco. È un progetto di ridisegno degli equilibri europei in cui Stati Uniti e Russia tornano attori centrali e Kiev viene ricondotta in una condizione di sovranità limitata.
La sovranità ucraina viene “confermata” sulla carta, ma a prezzo del riconoscimento di fatto dell’annessione russa della Crimea e delle regioni di Donetsk e Luhansk, mentre le aree di Kherson e Zaporizhzhia verrebbero congelate lungo la linea del fronte. L’Ucraina dovrebbe rinunciare per sempre all’ingresso nell’Alleanza Atlantica, e la stessa alleanza sancirebbe nei propri documenti che Kiev non ne farà parte.

In cambio, Washington offrirebbe una garanzia di sicurezza bilaterale, condizionata al comportamento ucraino, mentre la Russia si impegnerebbe a non aggredire Ucraina e Paesi europei e a iscrivere nella propria legislazione una dottrina di non aggressione. Le forze armate ucraine sarebbero limitate a seicentomila uomini, con un tetto che compromette la capacità di sostenere una guerra di logoramento prolungata contro una potenza come la Russia.
Il cuore geoeconomico del piano è la creazione di un gigantesco dispositivo di ricostruzione dell’Ucraina, gestito e controllato in larga misura dagli Stati Uniti. Cento miliardi di attività russe congelate verrebbero investiti in progetti guidati da Washington per infrastrutture, energia, centri di elaborazione dati, intelligenza artificiale, estrazione di minerali strategici. L’Europa aggiungerebbe altri cento miliardi, mentre il resto dei fondi russi congelati confluirebbe in uno strumento di investimento congiunto tra Stati Uniti e Russia, pensato per legare le due economie e scoraggiare un ritorno al confronto aperto.

Al tempo stesso, la Russia verrebbe progressivamente riammessa nell’economia mondiale, con la graduale revoca delle sanzioni, un accordo di cooperazione economica di lungo periodo con Washington e il rientro nel gruppo degli otto. In altri termini: un sistema che compensa Mosca per l’accettazione del cessate il fuoco e offre agli Stati Uniti un ruolo dominante nella ricostruzione ucraina, mentre l’Unione Europea viene relegata al ruolo di contributore finanziario e di mercato di sbocco.
La partita militare e strategica
Sul piano militare il progetto congela la situazione a vantaggio di Mosca. I territori occupati vengono riconosciuti di fatto, una fascia della regione di Donetsk diventa zona cuscinetto smilitarizzata considerata territorio russo, dalla quale le forze ucraine devono ritirarsi. L’Ucraina rinuncia alla prospettiva di un ombrello collettivo dell’Alleanza Atlantica e viene legata a una garanzia americana bilaterale, revocabile in caso di “violazioni” come un attacco missilistico su Mosca o San Pietroburgo.

Per la Russia significa consolidare le conquiste territoriali e ottenere al tempo stesso una riduzione strutturale delle capacità militari ucraine. Per gli Stati Uniti significa trasformare l’Ucraina in un protettorato di fatto: dipendente dall’aiuto militare americano, vincolato a non cercare alternative di sicurezza e privo di autonomia piena nella definizione della propria dottrina difensiva. Per l’Europa, infine, vuol dire vedere confermata sul terreno una nuova linea di divisione che sancisce la sconfitta della sua pretesa di “ordine europeo basato sul diritto internazionale”.
Pressioni su Kiev e resistenze europee
Secondo le rivelazioni, Washington avrebbe minacciato di ridurre o interrompere la condivisione di informazioni e forniture di armi per spingere Zelensky ad accettare il quadro d’intesa. Il presidente ucraino ha parlato di “uno dei momenti più difficili” della storia del Paese: o perdita di dignità, accettando condizioni percepite come umilianti, o il rischio di perdere il principale alleato in un inverno segnato da bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche e da una situazione militare complessa al fronte.

Kiev ha fissato le proprie “linee rosse”: nessun riconoscimento formale di territori ucraini come russi e nessun limite esterno imposto alla consistenza delle proprie forze armate. Alcuni governi europei hanno appoggiato questa posizione, insistendo che qualsiasi accordo deve partire dalle attuali linee del fronte e preservare la capacità dell’Ucraina di difendere la propria sovranità. È lo scontro tra una logica di chiusura rapida del conflitto, anche al prezzo di una pesante revisione territoriale, e una linea che teme l’effetto domino di una pace basata sulla forza.
Implicazioni di lungo periodo
Se attuato, il piano segnerebbe una svolta: sancirebbe il principio secondo cui una potenza nucleare può modificare i confini con la forza e, dopo una fase di isolamento, essere riaccolta nel sistema economico globale a condizioni relativamente favorevoli. Invierebbe un segnale a tutte le potenze revisioniste: chi ha la forza negozia da una posizione di vantaggio, soprattutto se offre spazi di affari e cooperazione alle grandi economie.

Sul piano geoeconomico, l’Ucraina diventerebbe un grande cantiere di ricostruzione sotto regia statunitense, un laboratorio per nuove catene del valore nell’energia, nei minerali critici e nelle tecnologie avanzate. La Russia, reintegrata, potrebbe usare l’accesso a tali catene per rafforzare la propria autonomia strategica, mentre l’Europa resterebbe dipendente da decisioni prese a Washington e da equilibri bilaterali tra Stati Uniti e Federazione Russa.
È questo il vero cuore del progetto: non solo fermare una guerra, ma fissare le gerarchie del prossimo ordine europeo. Per l’Ucraina la scelta è tra accettare una pace che cristallizza la perdita di territori e sovranità o continuare una guerra in condizioni sempre più difficili, nel tentativo di evitare di diventare il terreno di scambio di un nuovo grande accordo tra potenze.
Foto TASS. Presidenza Ucraina, Casa Bianca e Forze Armate Ucraine

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.