Geoeconomia: il conflitto che inghiotte tutto

C’è un mondo che continua a raccontarsi come se fosse rimasto quello di trent’anni fa, intrappolato nella retorica del “villaggio globale”, convinto che i commerci portino la pace, che la tecnologia sia un ponte e non un’arma, che la finanza sia un meccanismo neutrale e non un centro di comando geopolitico.
È un mondo che non vuole vedere ciò che ha davanti agli occhi: le relazioni internazionali sono entrate in una fase in cui la distinzione fra pace e guerra è evaporata. Lo scontro tra potenze non si manifesta più con fronti, invasioni e ultimatum, ma attraversa le reti digitali, i tubi dei gasdotti, le piattaforme tecnologiche, le valute internazionali, i colli di bottiglia delle supply chain.
Questo è il punto di partenza del libro di Francesco Frasca, e al tempo stesso la sua intuizione più evidente: la geoeconomia non è una disciplina accademica, ma la forma reale e quotidiana del conflitto globale contemporaneo.
In questa trasformazione, la geografia non è scomparsa: è migrata. Le mappe non segnano più solo confini e montagne, ma corridoi energetici, snodi logistici, cavi sottomarini, hub digitali, centri dati, fabbriche di semiconduttori, standard normativi. Le nuove frontiere non sono linee sulla terra, ma regole scritte a Bruxelles, chip prodotti a Taipei, infrastrutture installate da Pechino, server ospitati in California. Il potere abita i nodi, non i territori. Chi controlla i nodi può decidere chi sopravvive, chi prospera, chi fallisce.
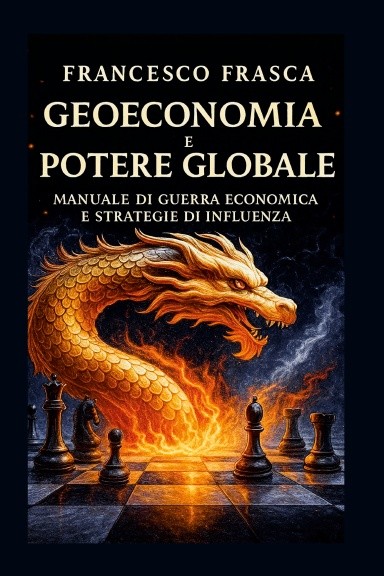
E sono proprio gli Stati Uniti ad aver capito per primi che, nel mondo dell’interdipendenza, il dollaro è una portaerei, la Federal Reserve è un carro armato, il Dipartimento del Tesoro è un nuovo Pentagono. Quando Washington decide di escludere una banca dal sistema dei pagamenti internazionali, quell’istituto entra in blackout come un paese bombardato. Quando impone restrizioni sull’export di chip avanzati, sta colpendo il cuore tecnologico di un avversario più di quanto potrebbe fare qualsiasi attacco convenzionale.
Le sanzioni alla Russia lo hanno dimostrato con chiarezza: in poche settimane Mosca ha visto congelati i propri asset sovrani, bloccate le filiere di approvvigionamento, paralizzati investimenti fondamentali. Una forma di strangolamento silenzioso, senza navi né bombardieri, ma dagli effetti geopolitici devastanti.
La Russia non è però l’unico laboratorio di questa nuova logica. Per anni l’Europa ha coltivato l’illusione che l’interdipendenza economica con Mosca potesse sostituire la diplomazia e garantire stabilità. La realtà si è incaricata di smentire questa visione: la dipendenza energetica si è rivelata una vulnerabilità strategica che ha esposto l’intero continente a uno shock devastante. Alla prima crisi, i prezzi sono saltati, le industrie hanno rallentato, i governi sono entrati in panico. Un decennio di scelte politiche basate sull’idea che il mercato fosse una garanzia di sicurezza si è sgretolato in poche settimane.
E mentre l’Europa cercava disperatamente nuovi fornitori, un’altra guerra – apparentemente incruenta, in realtà totale – avanzava nel silenzio: quella per il dominio tecnologico. Gli Stati Uniti e la Cina hanno trasformato i semiconduttori, le reti digitali e l’intelligenza artificiale nel terreno più sensibile dello scontro. Gli USA hanno eretto muri invisibili ma invalicabili: divieti di esportazione, liste nere, controllo sugli investimenti stranieri nelle tecnologie critiche. La Cina ha risposto sviluppando piani industriali di lungo periodo, fortificando la propria capacità produttiva, assicurandosi l’accesso alle materie prime strategiche e costruendo reti di alleanze nei Paesi emergenti.
In mezzo, l’Europa ha scoperto di non avere né la forza industriale per competere né la volontà politica per emanciparsi dal dominio tecnologico esterno. La sua autonomia strategica si riduce a slogan ripetuti nelle conferenze, ma mai tradotti in fabbriche, investimenti o capacità. Si parla di sovranità digitale, ma i server sono americani; si parla di resilienza industriale, ma i chip arrivano da Taiwan; si parla di autonomia strategica, ma le decisioni fondamentali dipendono dalle scelte di Washington o Pechino.
Eppure, la tecnologia non è l’unico campo di battaglia invisibile. Il libro insiste su una dimensione più profonda, più inquietante: la guerra cognitiva. Viviamo in un’epoca in cui la capacità di influenzare ciò che le persone credono, temono, desiderano è diventata un asset strategico fondamentale. Gli algoritmi che regolano i social, i motori di ricerca, le piattaforme di streaming non si limitano a consigliare contenuti: plasmano la percezione della realtà, orientano i conflitti politici interni, amplificano polarizzazioni.
La manipolazione informativa non è più una questione di propaganda di Stato, ma un ecosistema in cui attori privati, Stati e gruppi non statali possono intervenire con una potenza mai vista. La guerra cognitiva è permanente, capillare, sofisticata. Non si limita a diffondere menzogne: modifica l’ambiente informativo stesso.
Questo scenario rende evidente un problema che l’Europa fatica ad affrontare: la sua vulnerabilità strutturale. Non possiede un ecosistema tecnologico paragonabile a quello americano o cinese, non controlla le infrastrutture digitali critiche, non ha una politica industriale coerente.
Fa affidamento su piattaforme esterne per comunicare, per lavorare, per gestire i dati pubblici. E mentre parla di sovranità, la delega quotidiana alle Big Tech si espande. Il risultato è un’ambiguità che l’autore coglie con precisione: l’Europa è un attore normativo, ma un soggetto fragile; un continente ricco, ma strategicamente spoglio; un gigante commerciale, ma un nano tecnologico.
La geoeconomia però non si misura soltanto nei rapporti tra grandi potenze. Il libro mette in luce l’ascesa degli attori non statali, che costituiscono un pezzo sempre più importante del puzzle. Le grandi aziende tecnologiche possiedono capitali, dati e capacità di analisi paragonabili a quelli degli Stati. I fondi di investimento controllano pezzi fondamentali dell’economia globale. Le ONG influenzano l’opinione pubblica, le piattaforme digitali detengono il monopolio dell’attenzione. In questo ambiente il potere è diffuso, fluido, poroso: gli Stati devono affrontare concorrenti che non rispondono ad alcun vincolo politico, ma che influenzano la sicurezza collettiva più di qualunque ministero della difesa.
È qui che entra in gioco un’altra intuizione centrale del libro: la necessità di costruire una cultura dell’intelligence economica. Non una struttura segreta, ma una rete capace di analizzare scenari, proteggere tecnologie, anticipare rischi, coordinare le scelte industriali, connettere imprese, università e istituzioni. Nessun Paese può affrontare la complessità della competizione globale senza strumenti di conoscenza adeguati. Non si tratta più di difendere un segreto industriale o di prevenire una fuga di informazioni: si tratta di leggere il mondo prima che il mondo travolga gli Stati. Una democrazia senza intelligence economica è come un esercito senza radar: può avere ottimi soldati, ottime armi, ottimi comandanti, ma non vede arrivare il pericolo.
Il libro insiste su un’idea fondamentale: la sovranità, oggi, è la capacità di proteggere i nodi critici. Non i confini, ma le infrastrutture. Non il territorio, ma le reti. Non la popolazione in astratto, ma la capacità della popolazione di resistere a shock energetici, informativi, tecnologici. La resilienza diventa il nuovo nome della forza. Un Paese è sovrano non perché possiede un esercito, ma perché può assorbire una crisi senza crollare. La pandemia, la crisi energetica, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, i sabotaggi ai gasdotti e alle reti elettriche hanno mostrato quanto sia fragile il sistema globale e quanto sia essenziale costruire strutture di protezione che vadano oltre la retorica politica.
Alla fine, il libro ci restituisce l’immagine di un mondo in cui la guerra non è né dichiarata né riconosciuta, ma onnipresente. Un mondo che continua a raccontarsi come pacifico, mentre combatte battaglie economiche, tecnologiche, cognitive e normative ogni giorno. Un mondo in cui il potere non si manifesta con l’occupazione di territori, ma con l’occupazione delle dipendenze. Un mondo in cui la pace non è un dato, ma un intervallo tra una pressione e l’altra.
E soprattutto un mondo in cui chi non capisce la geoeconomia non capisce il proprio tempo. Perché il potere, oggi, non sta dove si guarda, ma dove non si pensa di guardare. È fatto di infrastrutture, di codici, di nodi finanziari, di trattati commerciali, di norme tecniche, di algoritmi, di filiere industriali, di sanzioni, di dati. È un potere senza divise, senza bandiere, senza parate, ma infinitamente più determinante di quello che un tempo si presentava con fanfare e stendardi.
Nel mondo che si prepara, la forza sarà la capacità di prevedere, connettere, proteggere e adattarsi. È questa la lezione più profonda del libro: le guerre del futuro sono già cominciate, ma non tutti se ne sono accorti.
Geoeconomia e Potere Globale
Francesco Frasca
Pagine 394
Dimensioni 152 x 229 mm
- ISBN 9781291940480
Prezzo Euro 32
Acquistalo qui

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.










