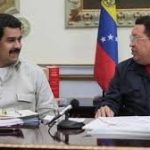La guerra commerciale tra USA e Cina sta riscrivendo la sovranità economica dell’Europa

È una guerra che non si combatte con i carri armati ma con i dazi, le restrizioni tecnologiche e le ritorsioni valutarie. Ma i suoi effetti sono altrettanto devastanti e profondi. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ormai entrata nella sua seconda fase con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, non è soltanto il confronto tra le due principali potenze economiche del pianeta. È lo specchio della crisi sistemica della globalizzazione e dell’impossibilità, per l’Europa, di restare al tempo stesso alleata di Washington e partner commerciale di Pechino. Un’ambiguità che diventa ogni giorno più insostenibile.
Tutto inizia nel 2017, con le prime bordate protezionistiche lanciate da Trump: dazi fino al 50% su pannelli solari e lavatrici cinesi. L’“America First” prende forma. E prosegue, ininterrottamente, anche sotto l’amministrazione Biden. L’ostilità verso Pechino diventa il solo punto di convergenza bipartisan a Washington. I dazi non solo restano, ma si ampliano. La lista nera delle aziende cinesi “strategiche” si allunga: Huawei, China Mobile, China Telecom, e poi il gigante petrolifero CNOOC. Il messaggio è chiaro: spezzare la catena tecnologica sino-occidentale, anche a costo di ferire gli alleati europei.
Parallelamente, gli Stati Uniti rafforzano il proprio fronte interno con il CHIPS Act, 52,7 miliardi di dollari per rilocalizzare la produzione di semiconduttori, ridurre la dipendenza asiatica e militarizzare l’industria dell’elettronica. Non è solo una misura economica, ma una scelta di sicurezza nazionale. Lo stesso vale per le restrizioni all’export verso la Cina: divieto su 24 categorie di macchinari, obbligo di licenze BIS per le imprese statunitensi. Una vera e propria cortina di ferro digitale.
Pechino risponde: restrizioni sugli investimenti esteri, rilocalizzazione dei capitali, stimoli fiscali alle amministrazioni locali e difesa delle sue filiere critiche. Il risultato è un rallentamento del flusso degli IDE (investimenti diretti esteri), ma anche una maggiore autonomia finanziaria e industriale. Le esportazioni cinesi verso gli USA scendono dal 19% al 14% del totale tra il 2018 e il 2023. E viceversa, la quota degli USA nel commercio cinese cala inesorabilmente. Il disaccoppiamento non è uno slogan, è già realtà.
Ed è in questo scenario che si inserisce l’Europa. Un continente ancora legato a doppio filo alla NATO, ma sempre più dipendente dalla Cina per le sue importazioni strategiche: minerali rari, componenti elettronici, farmaci. Nel 2024, Pechino rappresenta il 14,6% delle importazioni europee. Eppure, sotto la pressione statunitense, Bruxelles è costretta a riposizionarsi. Ma con quali strumenti? Quale visione? Quale autonomia?
Per ora, la risposta è timida. L’UE tenta di trarre vantaggio dal disaccoppiamento sino-americano: le esportazioni europee verso la Cina, in alcuni settori, colmano il vuoto lasciato da quelle statunitensi. Le imprese europee, soprattutto tedesche e italiane, mantengono una presenza forte nel mercato cinese. Ma Washington non gradisce. Il 2 aprile 2025, Trump lancia una nuova offensiva: 20% di dazi sui prodotti europei. Non è solo una misura economica, ma una pressione strategica. L’obiettivo è doppio: costringere l’Europa a comprare gas e petrolio americani, e a firmare contratti militari vincolanti con il complesso industriale statunitense.
Così l’Europa si trova in un cul-de-sac: se si avvicina alla Cina, irrita gli Stati Uniti; se si piega a Washington, rinuncia alla sua base manifatturiera, ai suoi scambi, alla sua voce autonoma nel mondo. E il progetto di “autonomia strategica” voluto da Macron diventa sempre più retorico, sempre meno realistico.
Nel frattempo, la guerra commerciale ridefinisce le regole del commercio globale. Si moltiplicano le barriere non tariffarie, le sanzioni tecnologiche, le guerre valutarie. Si affermano nuovi blocchi geopolitici e si frammentano le catene del valore. L’Asia sud-orientale, l’India, l’Africa diventano nuove piattaforme per la delocalizzazione di capitali europei. Ma il prezzo da pagare è la fine dell’universalismo commerciale. Niente più WTO, niente più multilateralismo: solo geometrie variabili, accordi bilaterali e regole ad hoc.
In questo contesto, l’Europa rischia di diventare irrilevante. Non ha un’unica voce politica, non ha un’industria strategica comune, non ha una difesa tecnologica integrata. Dipende dagli USA per la sicurezza, dalla Cina per l’economia, dalla Russia per l’energia. Una tripla dipendenza che, nel lungo termine, mina la sua sovranità.
La guerra commerciale non è una tempesta passeggera. È il nuovo paradigma del XXI secolo. E l’UE, se non costruisce ora un’architettura autonoma di potere economico, rischia di essere solo il campo di battaglia degli altri.
Giuseppe Gagliano è presidente del Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (CESTUDEC

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.