Unione Europea e difesa tra crisi e opportunità

Sino ad ora tutto quello che il Presidente Trump sta facendo per spegnere i più grandi e pericolosi dei vari incendi bellici che da qualche anno divampano in aree del mondo a noi sempre più prossime, non ha prodotto alcun risultato positivo.
Putin, invitato al dialogo, formula vaghe promesse durante il giorno per poi bombardare furiosamente l’Ucraina nel corso della notte. Nethanyau, dal canto suo, continua imperterrito la pulizia etnica di quello che i partiti religiosi del suo governo considerano come il “grande Israele “destinato per diritto divino a tornare integralmente in mano ebraica.
Nel far questo è confortato dal fatto di sapere che da Washington potranno arrivargli al massimo moderate espressioni di condanna, mentre il governo americano continuerà a rimanere pronto ad intervenire immediatamente se l’amico israeliano fosse confrontato a difficoltà realmente serie.
Agli antipodi del mondo poi la Cina continua a chiedersi se, visto come vanno adesso le cose, questo non sia per caso veramente il momento migliore per fare definitivamente i conti con Taiwan.
A sud infine una Africa del tutto dimenticata tranne che da chi vuole sfruttarla – in primo luogo cinesi, russi e turchi – piange sugli orrori di due guerre spaventose che continuano ad insanguinare la regione del Sudan ed il bacino del Congo.
Non è comunque che in questo pessimistico quadro la nostra Unione Europea goda di una condizione di favore.
Le pesanti espressioni nei riguardi della inutilità della NATO nonché degli europei, più volte qualificati come “scrocconi incapaci “nel settore della sicurezza, hanno chiarito come le garanzie americane che avevamo considerato per più di ottant’anni quale il pilastro fondamentale della difesa collettiva in ambito Atlantico siano soltanto carta straccia.
E del resto si tratta di una cosa di cui già da tempo avremmo dovuto accorgerci da soli, sempre che avessimo voluto renderci conto della regolarità con cui, almeno dopo la sua sconfitta in VietNam, Washington abbandonava immediatamente ogni alleato alla sua sorte non appena il gioco rischiava di farsi pesante.
Alla nostra difesa quindi siamo tenuti adesso a pensarci da soli, mentre il Presidente Trump ci tempesta di accuse di aver fatto ricadere per decenni sugli USA una percentuale eccessiva del costo della comune sicurezza.
Un’accusa che in termini rigorosamente ed unicamente budgetari è probabilmente vera, ma che non tiene conto di un’infinità di altri fattori che dovrebbero invece pesare sulla bilancia, primo fra tutti il fatto che il nostro continente ha vissuto per lunghi decenni nell’incubo che le due superpotenze fossero si pronte a combattere eventualmente una guerra nucleare, purché essa rimanesse confinata al nostro solo territorio e rispettasse invece Russia e Stati Uniti.
Avrà bene avuto un suo costo, o per lo meno un valore, un fatto del genere…..

il risultato di questa complessiva situazione è che dal punto di vista della sicurezza e della difesa noi ci troviamo ora pressoché completamente scoperti, considerato soprattutto come la NATO – l’unico nostro strumento disponibile nel settore – stia attraversando una crisi profonda da cui forse si risolleverà soltanto se e quando al suo interno potranno interagire un pilastro americano ed uno europeo più o meno fra loro equivalenti.
Succederà mai? Forse si, considerato anche come la paura la frustrazione e la sensazione di impotenza che hanno pervaso l’UE in questo periodo in cui gli USA scivolavano dal ruolo di “Grande e tradizionale alleato “sin quasi a quello di nemico imprevisto, abbiano se non altro avuto il merito di riavviare il dibattito sulla nostra sicurezza continentale.
Un dibattito estremamente difficile, considerato come l’Europa si sia per più di ottanta anni crogiolata nella radicata convinzione che gli orrori della guerra non avrebbero mai più superato le sue frontiere e che quindi fosse possibile e doveroso rispondere sempre e soltanto “Burro“ a chiunque ti chiedesse di scegliere fra “Burro e cannoni”.
Si tratta poi di una convinzione che risulta in Italia particolarmente radicata, grazie da un lato al pacifismo presente in buona parte della sinistra, e dall’altro alla convivenza del nostro Paese con una Chiesa Cattolica che non ragiona nei medesimi termini di uno Stato ed è guidata da un Pontefice che ha abbondantemente chiarito come per lui la pace sia un bene tanto elevato da giustificare anche eventuali rese vergognose ed ingiuste pur di porre termine ai conflitti.
Tutto questo con buona pace della dottrina tomistico agostiniana nonché del Cardinale Biffi che aveva a suo tempo trovato il modo di quadrare il cerchio, dichiarando che “Il pacifismo è la visione profetica della Chiesa”. Visione profetica, si badi bene, e quindi non centrata su di un oggi ma piuttosto su un ipotetico futuro che potrebbe anche rivelarsi lontano……
Detto questo vi è però da constatare come dal punto di vista pratico i progressi fatti in Europa siano stati sino ad ora ben pochi, salvo che nei paesi ove la contiguità alla Russia fa sentire il pericolo come più immediato.
Ad ogni piè sospinto allorché si cerca di procedere sulla strada di un accordo ci si continua ad urtare con posizioni nazionali consolidate e divergenti mentre nell’aria risuona sempre la abituale obiezione, vale a dire che non ci potranno essere sicurezza e difesa comune se non verrà prima concordata una politica estera comune.
Obiezione che forse risponde al vero. O forse no: se avessimo oltre la moneta anche la spada in comune sarebbe infatti probabilmente la necessità di condividere l’oro ed il ferro che costringerebbe gli Stati membri della UE a partorire anche una politica estera comune.
Si tratta, tra l’altro di un processo che verrebbe enormemente accelerato dal fatto che uno strumento di difesa europeo efficace dovrebbe disporre oltre che della componente convenzionale anche di quella nucleare. E con il nucleare non si scherza!
Anche se ufficialmente siamo ancora tutti contrari alla idea di uscire dal Trattato di Non Proliferazione dalle dichiarazioni rilasciate di tanto in tanto e dai vertici politici della Unione e da quelli dei singoli stati traspare chiaramente di tanto in tanto la voglia che si possa disporre in un giorno non lontano di un armamento nucleare comune che ci conferisca un potere di deterrenza ben superiore a quello che potremmo conseguire con una “dissuasion partagee” dei limitati potenziali inglesi e francesi.

C’è solo da sperare che qualcuno trovi il coraggio di parlarne apertamente prima di essere costretti a renderci conto di come la proliferazione segretamente già in atto in parecchie delle sponde islamiche del Mediterraneo allargato, ci abbia già posto in condizioni di subire soltanto, privandoci tra l’altro di ogni capacità di reazione.
Quando poi dal nucleare passiamo al convenzionale la materia, almeno a prima vista, appare ancora più ingarbugliata benché in pratica il problema che ci ha travagliato per anni cioè quello di limitare la nostra difesa alle zone contermini del continente o conferirle capacità di proiezione mondiale si sia in pratica risolto da solo.
Se vuole contare e contribuire a fare la storia anziché limitarsi a subirla, la UE deve infatti essere in condizione di muoversi sullo stesso piano con quelle che sono e saranno le altre grandi potenze.
Il respiro della sua politica è quindi obbligato ad essere globale. Fissato un obiettivo come questo riuscire a districarsi nella giungla delle aspirazioni personali e delle diffidenze reciproche di ogni protagonista umano o statale della potenziale costruzione dovrebbe (o forse è meglio dire potrebbe?) divenire molto più facile.
Tra l’altro ci sarebbe anche modo di sfruttare tutto il colossale lavoro che, almeno in campo industriale, è già stato effettuato nel corso degli anni più recenti.
Non disponiamo però di molto tempo. Il nostro avamposto ucraino sta infatti cadendo, altri poteri si sono divisi Africa nera e Sahel ed Israele, un tempo avamposto dell’Occidente in Medio Oriente, si è chiaramente trasformato in una semi teocrazia molto più prossima a quelle analoghe dell’area sunnita della regione che alle ormai distanti democrazie europee.
Troppo corto il periodo a disposizione perché ci sia possibile cambiare? Forse, ma possiamo sempre sperare che abbia ragione il Parkinson, maestro dell’organizzazione negli anni 50 del secolo scorso, allorché sosteneva come nelle grandi strutture “il tempo necessario per fare una cosa sia sempre eguale al tempo disponibile per fare quella cosa“.
Immagini: Commissione Europa, Alberto Scafella e Maga
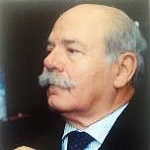
Giuseppe CucchiVedi tutti gli articoli
Entrato alla Scuola Militare di Napoli nel 1955, il Generale Cucchi ha avuto una lunghissima carriera conclusa nel 2008 come Direttore Generale dell'Intelligence Nazionale. Dopo il definitivo pensionamento ha lavorato due anni per le Nazioni Unite come esperto nell'ambito della crisi del Mali/Sahel. Ha insegnato management alla Università LUISS di Roma ed alla Business School della Università di Bologna.










