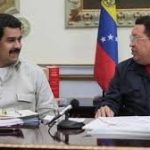Trump, Putin e il nodo che stringe l’Europa

Il prossimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin non è soltanto un evento mediatico: è un passaggio strategico che può ridisegnare gli equilibri tra Stati Uniti, Russia e il resto del mondo. Le anticipazioni fornite da Dmitrij Suslov, vice direttore del Centro di studi europei e internazionali di Mosca, delineano una proposta russa “migliorativa” rispetto a tentativi precedenti. Mosca si ritirerebbe da Dnipro, Sumy e Khar’kiv, mantenendo il controllo del Donbass e congelando l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Un cessate il fuoco rapido completerebbe l’intesa.
Non è un’offerta priva di spigoli: per Kiev significherebbe cedere territori, e il presidente Zelensky con ogni probabilità la respingerebbe. Ma il malcontento interno cresce. Il sindaco di Kiev, Vitalyj Klitchko, ha dichiarato che “la gente è stanca di questa guerra”. Il terreno politico è più fluido di quanto appaia.
I Brics nel mirino della Casa Bianca
La parte più interessante della riflessione di Suslov riguarda però il legame tra il negoziato e la pressione economica americana sui Brics. L’amministrazione Trump ha imposto dazi punitivi del 50% a Brasile e India, accusati di continuare a commerciare con la Russia e, di fatto, di alimentarne l’economia di guerra. L’India, ad esempio, importa da Mosca il 45% del proprio greggio.

L’obiettivo non è solo Mosca: colpire i Brics significa minare l’architettura di un’economia alternativa al dollaro, uno degli obiettivi dichiarati del gruppo. Ma Brasile, India e Russia, fondatori dell’alleanza, hanno risposto con un secco rifiuto alle pressioni statunitensi. È un segnale di compattezza che riduce lo spazio di manovra della Casa Bianca.
Secondo Suslov, Trump ha allungato troppo il passo: attaccare economicamente Brasile, India, Russia e contemporaneamente negoziare con la Cina è una strategia ad altissimo rischio. Pechino, lungi dall’essere intimidita, tratta con Washington da posizione di forza, forte della propria capacità di risposta commerciale e tecnologica.
In questa cornice, Putin offrirebbe a Trump una via d’uscita: un accordo che riduca la necessità di mantenere sanzioni secondarie pesanti e impopolari, alleggerendo il conflitto commerciale con India e Brasile e preservando, almeno in parte, il prestigio della presidenza americana.
L’Europa tra fastidio e marginalità
L’elemento di frizione è l’Europa. Diversi leader, come il cancelliere tedesco Merz, hanno già espresso opposizione a qualsiasi accordo che escluda Kiev o che venga “imposto dall’alto”. Questo atteggiamento, se da un lato difende formalmente l’Ucraina, dall’altro rischia di irritare Trump, soprattutto mentre è ancora aperta la disputa sui dazi tra Washington e Bruxelles.

In un contesto di crescente subalternità strategica dell’UE verso gli Stati Uniti, la postura europea rischia di trasformarsi in un ostacolo, più che in un contributo, alla definizione di un equilibrio geopolitico.
Il negoziato non è un confronto tra valori, ma tra interessi. L’Europa che oggi invoca la fermezza verso Mosca è la stessa che ha esitato due anni prima di condannare le stragi di Gaza e che ha avallato guerre preventive in Siria e Iran. È la logica cinica della politica internazionale: indignazioni selettive e compromessi dietro le quinte.
Per Trump, la trattativa con la Russia ha una doppia valenza: garantirsi il trofeo del “pacificatore” e chiudere un fronte commerciale e diplomatico che, se mantenuto, potrebbe costargli più di quanto renda. Per Putin, significa congelare il conflitto a condizioni favorevoli e incrinare il fronte occidentale.
Se l’intesa andrà in porto, il prezzo lo pagheranno soprattutto Kiev e, indirettamente, l’Europa, che vedrà ulteriormente ridimensionata la propria capacità di incidere negli equilibri globali. Ma in uno scenario in cui la guerra logora tutti e le tensioni economiche si moltiplicano, il compromesso potrebbe essere la via più realistica.
Non sarebbe un trionfo per nessuno, ma un passo indietro calcolato per evitare il collasso di un equilibrio già precario. E, come spesso accade nella storia, la pace non arriverebbe per giustizia, ma per necessità.
Foto: TASS

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.