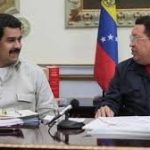Gli “effetti collaterali” della demonizzazione dell’avversario

Dalla fine della Guerra fredda a oggi, la narrazione occidentale sui conflitti internazionali ha assunto un carattere sempre più manicheo: da una parte il bene, incarnato dall’Occidente e dai suoi alleati; dall’altra il male, rappresentato da leader e regimi trasformati in incarnazioni del “diavolo”. È un meccanismo antico, certo, ma che negli ultimi trent’anni si è radicalizzato fino a diventare sistematico: da Saddam Hussein a Mu’ammar Gheddafi, fino a Vladimir Putin, il catalogo dei “nuovi Hitler” si è arricchito di volta in volta per sostenere interventi militari e sanzioni economiche.
La logica della demonizzazione risponde a una doppia esigenza: mobilitare le opinioni pubbliche interne, sempre più diffidenti verso guerre lontane e costose, e conferire una legittimità morale a decisioni che, in realtà, hanno motivazioni geopolitiche ed economiche precise.
Una legittimazione fragile
Se guardiamo alla prima guerra del Golfo (1991), l’invasione dell’Iraq da parte di una coalizione guidata dagli Stati Uniti fu presentata come la necessaria risposta al “nuovo Hitler” Saddam Hussein. Eppure lo stesso Saddam, pochi anni prima, era stato sostenuto da Washington e da varie capitali europee nella sua guerra contro l’Iran. Lo schema si è ripetuto con Gheddafi, da accolto interlocutore dell’Occidente a tiranno da abbattere nel 2011, e oggi con Putin, passato in pochi anni da partner strategico — soprattutto sul piano energetico — a simbolo del male assoluto.

Questo rovesciamento continuo genera un effetto perverso: la perdita di credibilità. Il mondo extra-occidentale osserva la selettività con cui vengono attribuiti i titoli di “criminale” o “tiranno”, notando come le violazioni commesse da alleati dell’Occidente vengano minimizzate o giustificate. L’Occidente si presenta come custode dei valori universali, ma appare sempre più come arbitro interessato e di parte.
Effetti geopolitici
La demonizzazione dell’avversario non è solo un esercizio retorico. Essa produce conseguenze geopolitiche concrete. In primo luogo, irrigidisce i conflitti: se l’altro è il male assoluto, non è possibile negoziare, ma solo abbatterlo. Ciò complica ogni prospettiva diplomatica e rende più probabile il protrarsi delle guerre.
In secondo luogo, rafforza il campo opposto. Leader accusati e demonizzati tendono a consolidare il consenso interno proprio grazie all’attacco esterno. L’immagine di “vittime del complotto occidentale” diventa un potente strumento di mobilitazione nazionale. Così accadde con Milosevic negli anni ’90, così avviene oggi con Putin.
Una dinamica economica
Dietro la costruzione del “diavolo” si intravedono anche logiche economiche. La demonizzazione prepara l’opinione pubblica a tollerare misure drastiche come le sanzioni, che non solo colpiscono il Paese bersaglio ma riorientano i flussi energetici, le forniture di materie prime, i contratti industriali. In altre parole, la guerra morale legittima la guerra economica.
L’Iraq, la Libia e oggi la Russia hanno offerto esempi chiari: guerre e sanzioni hanno ridisegnato i mercati del petrolio e del gas, aperto spazi per le compagnie occidentali o, al contrario, favorito l’ascesa di nuovi attori come Cina e India. La demonizzazione diventa dunque una chiave per trasformare conflitti geopolitici in occasioni di redistribuzione delle risorse globali.
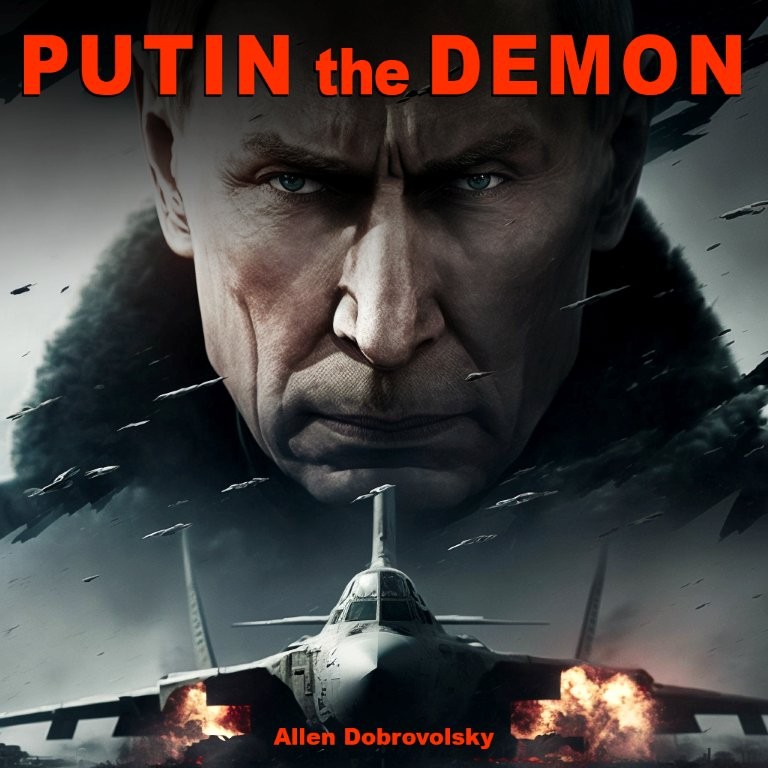
Una strategia che si ritorce contro chi la applica
Eppure, questa strategia mostra segni di logoramento. Il resto del mondo, dal Sud globale alle potenze emergenti, non accetta più di buon grado le narrazioni occidentali. La pretesa di dividere il mondo tra “democrazie” e “autocrazie” non convince più, tanto che Paesi come l’India, il Brasile o il Sudafrica mantengono rapporti bilaterali con la Russia nonostante le pressioni di Washington e Bruxelles.
Inoltre, l’uso inflazionato della demonizzazione rischia di svuotare di senso le categorie morali stesse. Se ogni avversario è il nuovo Hitler, la memoria storica viene banalizzata e il linguaggio politico perde credibilità.
Conclusione
La demonizzazione dell’avversario, lungi dall’essere un’arma neutrale, produce un effetto boomerang: indebolisce la capacità dell’Occidente di porsi come mediatore credibile, rafforza i regimi che intende colpire e riduce la possibilità di soluzioni politiche. È l’illusione di vincere la guerra delle idee, mentre si perdono progressivamente i capitali di fiducia e di legittimità internazionale.
Immagini: AP, AFP e IssueWire,

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.