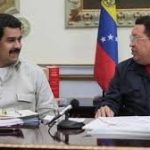I confini del caos. Andrea Muratore e la geografia instabile del mondo contemporaneo

C’è un filo rosso che attraversa il nuovo libro di Andrea Muratore, I confini più pericolosi del mondo (Newton Compton, 2025): la consapevolezza che la globalizzazione, anziché dissolvere le barriere, le ha moltiplicate.
L’autore, tra i più lucidi analisti italiani della geopolitica contemporanea, parte da un paradosso che oggi nessuno può più ignorare: viviamo in un mondo dove gli scambi commerciali, i flussi di dati e le connessioni digitali toccano vertici mai raggiunti, ma allo stesso tempo le frontiere — fisiche, politiche e mentali — si moltiplicano. Muratore chiama in causa la storia, la teoria e l’attualità per costruire un mosaico che è insieme riflessione strategica e diagnosi del disordine mondiale.

Il libro si apre con una lunga introduzione che da sola vale un saggio di geopolitica. Muratore parte dal concetto romano di limes — il confine come linea di difesa ma anche di connessione — per dimostrare che i confini sono da sempre specchio delle tensioni tra potere e vulnerabilità.
L’antica Roma consolidava la sua forza proprio laddove finiva il suo dominio: lungo le frontiere del Reno e del Danubio, nei forti e nelle strade che segnavano la distanza tra ordine e caos. Oggi, osserva l’autore, le grandi potenze si comportano allo stesso modo. Gli Stati Uniti con le loro basi militari, la Cina con le sue rotte commerciali e infrastrutture digitali, la Russia con le sue sfere d’influenza: tutti ridisegnano confini visibili e invisibili, non per abbatterli ma per piegarli ai propri interessi.
Muratore non indulge nelle nostalgie della Guerra Fredda né nell’illusione di un ordine multipolare stabile. Parla piuttosto di un “mondo multicaotico”, dove la forza sostituisce la regola, la propaganda sostituisce la diplomazia e la tecnologia diventa campo di battaglia. È una visione dura ma lucida, coerente con l’idea di un “interregno gramsciano” in cui il vecchio muore e il nuovo non riesce a nascere.
Le guerre locali si moltiplicano — dal Donbass a Gaza, dal Sahel al Mar Cinese Meridionale — e ciascuna scava un solco che ridefinisce non solo i confini geografici ma anche quelli morali e politici dell’umanità.
Il pregio del libro è la capacità di fondere l’analisi teorica con la cronaca più viva. Nel capitolo dedicato al Donbass, Muratore mostra come la guerra tra Russia e Ucraina non sia una semplice contesa territoriale ma un esperimento di geopolitica applicata: il tentativo russo di sovvertire l’ordine nato nel 1991 e di riaffermare la logica delle sfere d’influenza.
Il Donbass non è solo carbone e acciaio, è anche un laboratorio di guerra economica, dove il controllo delle miniere, dei corridoi logistici e dei metalli rari diventa una posta in gioco globale. E dietro ogni trincea, scrive l’autore, c’è la lotta per il potere sul futuro: chi possiede le risorse critiche, possiede la capacità di dettare le regole del mondo.
Muratore dedica poi un capitolo densissimo a Israele e al Medio Oriente, definendo i “confini (in)finiti” dello Stato ebraico. La sua lettura è impietosa ma equilibrata. Israele, osserva, è una democrazia senza confini dichiarati e con un’espansione territoriale permanente, sostenuta da una percezione di minaccia che diventa strumento politico. La guerra di Gaza del 2023-2025 diventa così un mezzo per ridisegnare la mappa del Levante e consolidare un’egemonia regionale che non conosce limiti geografici. Ma Muratore non si ferma alla denuncia: mostra come la logica israeliana della sicurezza preventiva sia ormai adottata, con altre forme, anche da Stati Uniti, Cina e Turchia. Tutti agiscono sulla base dello stesso principio: chi controlla lo spazio, fisico o digitale, controlla la narrazione del potere.
Dietro ogni analisi geografica si nasconde, nel libro, un interrogativo morale. Muratore si chiede cosa rimanga del diritto internazionale, dei trattati di sicurezza, delle istituzioni nate per evitare che la forza tornasse ad essere l’unica legge. L’ONU, scrive, è divenuta un’arena sterile; le alleanze come la NATO o i BRICS non garantiscono più stabilità ma competizione; e il mercato globale, che doveva unire, oggi divide. Persino l’intelligenza artificiale e la corsa alle risorse rare sono lette come nuove forme di frontiera: non separano Stati, ma civiltà tecnologiche. L’autore parla di “securitizzazione” dell’economia, dove ogni settore — dai semiconduttori all’energia — diventa terreno di scontro strategico. In questo contesto, i confini digitali sono i nuovi muri di Berlino.
La prosa di Muratore, pur densa di riferimenti, resta accessibile e incisiva. Ricorda quella di certi grandi divulgatori geopolitici europei, capace di intrecciare il lessico della strategia con la concretezza del giornalismo. Il suo è un linguaggio che non consola: denuncia la miopia delle élite occidentali, la retorica vuota del “mondo piatto” di Friedman, la fine dell’universalismo liberal che prometteva libertà e ha prodotto nuove forme di dominio. Non c’è spazio per la neutralità, perché l’autore si muove dentro la storia, non sopra di essa. L’idea che il pianeta possa tornare a una “governance globale” condivisa è, per lui, una pia illusione: le potenze agiscono ormai secondo logiche di sopravvivenza, e ogni tregua è solo una pausa tra due conflitti.
La forza del libro sta anche nel suo respiro storico. Muratore mette in relazione l’antico e il moderno, Roma e Washington, il limes e la NATO, costruendo una genealogia del potere che attraversa i secoli. Così come Roma proteggeva i suoi confini attraverso strade e fortezze, oggi gli Stati Uniti li difendono con basi e reti digitali; così come l’Impero cinese si definiva “Paese di Mezzo”, la Cina di Xi Jinping costruisce una nuova centralità fatta di rotte marittime e satelliti. Tutto ritorna, ma in forma tecnologica. E in questo eterno ritorno il mondo sembra oscillare tra il desiderio di globalità e la paura del contatto.
Nel tratto più intenso della sua analisi, Muratore affronta la dimensione psicologica del confine. Parla di “frustrazione securitaria”, il sentimento collettivo di vulnerabilità che alimenta populismi e nazionalismi. Dalla Brexit al muro tra Ungheria e Serbia, dalle guerre identitarie ai social network, l’autore vede una stessa dinamica: la ricerca di protezione in un mondo che non offre più certezze. Ogni frontiera diventa così una risposta emotiva a un’insicurezza sistemica. Ma dietro le paure individuali si nascondono strategie precise: chi controlla la paura, controlla il potere. Ed è qui che la geopolitica torna a coincidere con la psicologia collettiva.
Come Fulvio Scaglione, Muratore invita a diffidare delle narrazioni semplificate. Non c’è un “bene” occidentale contrapposto a un “male” orientale: ci sono solo interessi, potenze, debolezze, illusioni. La guerra in Ucraina, la crisi di Gaza, la corsa alle materie prime in Africa, il riarmo del Pacifico: tutti frammenti di una stessa “terza guerra mondiale a pezzi”, come la definiva Papa Francesco. Ma se Scaglione tende spesso a cercare nel passato una bussola morale, Muratore preferisce scavare nel presente per mostrare la logica spietata delle forze in campo. È un approccio più strategico che etico, ma altrettanto inquietante.
Alla fine della lettura resta una domanda sospesa: è ancora possibile un mondo senza confini? Muratore non lo crede. E forse ha ragione. Ma nel suo disincanto affiora anche un invito alla responsabilità. Se i confini tornano a essere il cuore della politica, allora serve una nuova cultura del limite, capace di riconoscere l’altro senza distruggerlo. “Abbiamo bisogno di decisori dotati di senso del limite”, scrive. È una conclusione che suona quasi come una preghiera laica in un tempo di hybris.
Il libro di Muratore non offre soluzioni, ma una mappa. E in un mondo che ha perso l’orientamento, anche una mappa può essere un atto di coraggio.

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.