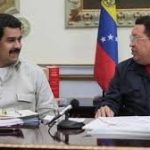La realtà dietro all’illusione: Macron, Zelensky e i 100 Rafale che non voleranno

La politica internazionale conosce momenti in cui l’immagine travolge la sostanza. L’annuncio di un presunto accordo tra Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky per la fornitura di 100 aerei da combattimento Rafale, oltre ad armi per i velivoli, droni e 8 sistemi di difesa aerea e antimissile SAMP/T di nuova generazione.
Una dichiarazione che fa effetto, riempie le prime pagine, dà l’impressione che la Francia e l’Europa stiano compiendo un salto strategico decisivo. Ma dietro il sipario, tra vincoli economici, limiti industriali e una situazione militare ucraina che peggiora settimana dopo settimana, l’accordo appare per quello che è: un gesto simbolico più utile alla comunicazione che alla guerra.

Il primo nodo è finanziario. Acquistare cento Rafale significa non solo pagare i velivoli, ma sostenere costi colossali per armamento, manutenzione, addestramento e logistica. Le stime variano dai 19 ai 30 miliardi di euro. Una cifra incompatibile con le capacità ucraine, soprattutto considerando un deficit pubblico equivalente al venti per cento del PIL e un’economia in guerra, dipendente da aiuti esterni per le spese più elementari.
Kiev non può permettersi una flotta d’élite e Parigi lo sa bene. Non a caso, Macron ha lasciato intendere che i fondi arriverebbero da contributi francesi ed europei: in altre parole, dai contribuenti. Il paradosso è evidente. Mentre in Francia si chiedono sacrifici ai cittadini e si tagliano servizi pubblici, il governo propone di finanziare, direttamente o indirettamente, un programma miliardario per uno Stato terzo. Una scelta politicamente esplosiva.

Ma anche ammesso che le risorse esistessero, ci sarebbe il problema industriale. Dassault Aviation ha un carnet di ordini già saturo: più di venti aeromobili consegnati nel 2024 e una lunga lista di clienti, a partire dalle stesse forze aeree francesi. Inserire 100 Rafale per Kiev significherebbe saturare completamente le catene di montaggio per anni, togliendo priorità a commesse già firmate e a esigenze nazionali.
Anche spingendo al massimo la produzione, servirebbero almeno due anni solo per iniziare le consegne, e poi un altro ciclo di addestramento e integrazione. In pratica, nessun velivolo operativo prima del 2027. Troppo tardi per un’Ucraina che fatica oggi a mantenere il fronte, con forze ridotte, mobilitazioni forzate, unità esauste e tattiche contestate.

C’è poi il contesto politico-militare ucraino, che smentisce la narrativa ottimista del duo Macron-Zelensky. L’esercito ucraino affronta diserzioni crescenti, perdite territoriali, difficoltà nel reclutamento e uno sfiancamento progressivo delle sue brigate migliori.
La controffensiva del 2023 è stata un fallimento; quella del 2024 non è mai realmente iniziata; il 2025 è segnato dalla perdita di iniziativa e da posizioni che cedono con regolarità. Pensare che cento Rafale – tra alcuni anni – possano ribaltare una situazione che si deteriora mese dopo mese significa ignorare la realtà della guerra.

Tutto questo porta a una conclusione chiara: l’annuncio serve più ai protagonisti che al conflitto. Zelensky può presentarsi come leader capace di ottenere sostegno da una potenza militare avanzata; Macron può mettersi in scena come difensore dell’Ucraina e promotore dell’industria francese. Ma è comunicazione, non strategia.
Il punto più delicato, tuttavia, è quello etico e politico. L’Ucraina sta attraversando una nuova ondata di scandali di corruzione, molti dei quali riguardano proprio il settore della difesa: appalti gonfiati, forniture inesistenti, dirigenti rimossi, fondi spariti. Finanziarie un mega-contratto in questo contesto non è solo imprudente, è irresponsabile.

Perché il rischio non è astratto: destinare miliardi europei a un sistema amministrativo indebolito significa esporsi a sprechi, inefficienze e opacità che i contribuenti, soprattutto in un periodo di austerità, non sarebbero disposti a perdonare.
Infine c’è la questione strategica. Anche se i Rafale arrivassero davvero, rischierebbero di essere abbattuti nel giro di poche settimane da un sistema di difesa russo ancora intatto e sempre più adattato alla guerra reale. L’investimento militare non cambierebbe il rapporto di forze e quello politico potrebbe essere un boomerang, alimentando divisioni interne in Francia e in Europa.

L’immagine del contratto come svolta storica svanisce così alla luce dei fatti. Il progetto Macron-Zelensky non è una strategia, ma una narrazione utile a nascondere fatiche, stalli e dubbi. E sotto la patina delle promesse resta la domanda essenziale: quanto realismo c’è ancora nella politica europea verso l’Ucraina? La risposta, per ora, è semplice: troppo poco.
Foto: Presidenza Ucraina

Giuseppe GaglianoVedi tutti gli articoli
Nel 2011 ha fondato il Network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con la finalità di studiare in una ottica realistica le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali ponendo l'enfasi sulla dimensione della intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot fondatore e direttore della Scuola di guerra economica (Ege). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.