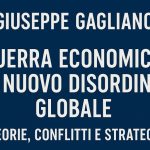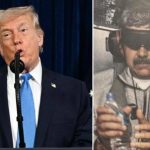La sfida nel Pacifico Occidentale

Mentre gli Stati Uniti della nuova amministrazione Trump tentano, alternando messaggi concilianti a minacce non troppo severe, di favorire la fine della guerra in Ucraina per riavvicinare la Russia all’Occidente e spezzare il gruppo BRICS isolando la Cina, nella regione dell’Indo-Pacifico, e in particolare nel settore del Pacifico Occidentale direttamente a contatto con l’arco di isole e penisole asiatiche che possono ostacolare l’accesso della flotta di Pechino all’oceano aperto, si intensificano esercitazioni e moniti contro la crescita della forza aeronavale del Dragone. Anche se la maggior parte delle nazioni della regione temono la Cina e tendono a collaborare con gli USA, la dirigenza di Pechino reagisce a sua volta, riallacciando rapporti con alcuni stati della regione per assicurarsi trampolini sicuri, oltre a incrementare senza posa l’arsenale missilistico e nucleare.
Sebbene il presidente americano Donald Trump da mesi le stia tentando tutte per blandire la Russia, pur alternando a cordiali aperture a vaghi “ultimatum” per un cessate il fuoco in Ucraina, minacciando ulteriori sanzioni che, per sua stessa ammissione “non so se funzioneranno”, il tentativo di Washington di staccare Mosca da Pechino, per il momento, non sembra funzionare.
Rinnovando quindi negli americani la paura di un confronto di lunga durata su due fronti, l’Europa e il Pacifico, con un asse eurasiatico i cui giganti si coprono le spalle reciprocamente nel cuore della massa continentale più mastodontica del mondo, dove la potenza anfibia del mondo anglosassone non può arrivare.

La Cina seguita a crescere militarmente e ad appoggiarsi alla Russia per perseguire i suoi obbiettivi strategici, in primis la futura annessione di Taiwan, l’isola ribelle dove i nazionalisti sconfitti dai comunisti edificarono fin dal 1949 una piccola “Cina alternativa” de facto indipendente, ma anche il controllo delle acque della regione indo-pacifica a tutela delle rotte di approvvigionamento e a proiezione di influenza politico-militare sui vicini.
Un nuovo monito è arrivato alla Casa Bianca il 1° agosto 2025, quando sono cominciate le esercitazioni navali congiunte fra Russia e Cina dette “Interazione marittima-2025”, iniziate con l’arrivo alla base russa di Vladivostok dei cacciatorpediniere cinesi Shaoxing e Urumqi, della classe Type-052D, o classe Luyang III, da 7500 tonnellate, armati con 64 celle di lancio per missili antinave e antiaerei.
Le manovre si sono svolte fino al 5 agosto nel Mar del Giappone, avendo come tema, stando al Ministero della Difesa di Mosca, “azioni congiunte di ricerca e soccorso, esercitazioni antisommergibile, di difesa aerea e di tiro d’artiglieria”. La Shaoxing guidava la squadra cinese, mentre quella russa, che comprendeva anche sottomarini, era capeggiata da un vecchio, ma ancora efficiente, cacciatorpediniere antisommergibile della classe Udaloy risalente agli ultimi anni dell’era sovietica, l’Admiral Tributs da 7900 tonnellate.
Il comando delle manovre era affidato a livello paritetico al vice ammiraglio russo Denis Berezovskij e al vice ammiraglio cinese Liu Zizhu. Una sinergia perdurante fra Russia e Cina fa temere da tempo, fra le altre cose, che anche i militari cinesi si facciano vedere nell’Oceano Glaciale Artico, entrandovi dal Pacifico mediante lo Stretto di Bering, già sfruttato dalla marina mercantile cinese per una sorta di “via della seta artica”.
Il che significa anche la possibilità che, sotto la copertura dell’interminabile costa settentrionale della Russia, parte della flotta di Pechino, subacquea o di superficie, arrivi fino all’Europa e all’Atlantico, con tutto ciò che comporta anche per la NATO, che vi vedrebbe la risposta al crescente impegno militare di nazioni europee nel Pacifico.

In questo contesto, suona provocatoria, ma interessante, la proposta, fatta il 28 luglio con un articolo su Breaking Defense, da un ufficiale americano, il colonnello Jeffery Fritz dell’US Army, volta a spingere il governo USA a comprare dalla Russia le piccole Isole del Commodoro, al margine occidentale dell’arcipelago delle Aleutine, per farne una base di sorveglianza dei sottomarini cinesi eventualmente diretti verso lo Stretto di Bering.
Nello specifico, egli afferma che sbarrare il passo verso Bering servirebbe a scongiurare il pericoloso arrivo nell’Artico, e poi nell’Atlantico, dei sottomarini cinesi classe Jin e Tang salpanti dalla base di Jianggezhuang, vicino Qingdao, i cui missili SLBM nucleari Julang-3 potrebbero minacciare il territorio degli Stati Uniti se lanciati in immersione da punti così vicini, in modo da far calare il tempo di volo, e quindi di preavviso delle difese, a meno di 15 minuti.
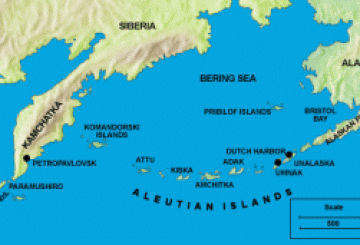
Secondo Fritz, Washington potrebbe offrire alla Russia fino a 15 miliardi di dollari per l’acquisto delle “Komandorskie Ostrova”, come si dicono in russo, ma sembra quasi impossibile che Mosca accetti di cedere territori, ancorché piccoli, così vicini alla penisola della Kamchatka, teatro peraltro il 30 luglio di un potente terremoto con tsunami da 8,8 gradi Richter, dove hanno sede basi segrete come la “città chiusa” costiera di Vilyuchinsk, “nido” di sottomarini lanciamissili balistici nucleari, e il poligono di Kura, tipica area-bersaglio per le testate inerti dei missili ICBM in collaudo.
Secondo il colonnello statunitense Mosca potrebbe almeno valutare l’ipotesi di frapporre un ostacolo ai sottomarini di Pechino per evitare che un giorno la presenza militare cinese nell’Artico possa diventare ingombrante. E’ chiaro che, politicamente, una mossa del genere, qualora andasse in porto, si inquadrerebbe nell’auspicio di Trump di ricucire con la Russia per allontanarla, almeno un po’, dalla Cina.

Ciò riecheggia fra l’altro l’acquisto dell’Alaska da parte degli americani nel 1867, quando lo comprarono dalla Russia dello Zar Alessandro II. Ma per il momento la storica rivalità e diffidenza fra russi e cinesi, altalenante a seconda del contesto strategico mondiale, resta soffocata di fronte al comune avversario americano.
Del resto, da una delle nazioni filoamericane più in prima fila nel Pacifico, l’Australia, è giunto il 1° agosto il monito del direttore del servizio di controspionaggio di Canberra, l’Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Mike Burgess (nella foto qui sopra) che in un discorso tenuto all’università di Adelaide ha riferito sulla pericolosità dello spionaggio russo e cinese, ma anche iraniano, ai danni del Paese dei Canguri. Ha quantificato in 24 grandi operazioni di intelligence, dal 2022 a oggi, culminate con l’espulsione di un numero imprecisato di sospette spie avversarie, l’impegno australiano nel confronto segreto con Mosca e Pechino.
Flotte e missili
L’Australia, con la sua massa continentale, è fra i maggiori bastioni che si frappongono all’espansione aeronavale cinese. Sulle sue coste e nelle isole vicine dal 13 al 28 luglio 2025 s’è svolta l’ultima edizione delle grandi manovre biennali Talisman Sabre, che fin dal 2005 Stati Uniti e Australia conducono col contributo di un numero variabile di alleati.
L’ultima sessione è stata la maggiore di sempre, con un dispiegamento totale di ben 43.000 uomini di 19 nazioni diverse. Oltre a paesi dell’area, fra i quali Nuova Zelanda, India, Giappone, Thailandia, Sud Corea e Singapore, per citare i principali, fra le nazioni che vi hanno partecipato c’erano anche Francia, Germania, Olanda, Norvegia, in omaggio al crescente impegno della NATO anche nello scacchiere dell’Indo-Pacifico.

La US Navy era impegnata, oltre che con la grande portaerei Washington, di classe Nimitz, che imbarcava tre Squadron di F-18 e uno di F-35C, con due cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke, lo Shoup e l’Higgins, un incrociatore classe Ticonderoga, il Robert Smalls, la nave da sbarco America e altre unità d’appoggio, non ultimo uno squadron del corpo aereo dei Marines montato su F-35B.
Se l’Australia, fra le sue unità navali, sfoderava i cacciatorpediniere Brisbane e Sidney, il sottomarino Fanrcomb e navi da sbarco, la Gran Bretagna era in prima fila con la portaerei Prince of Wales, di classe Queen Elizabeth II, recante due squadron di F-35B, e altre 4 navi tra cui il sottomarino Astute.
Nutrita anche la presenza giapponese, con vari cacciatorpediniere classe Takanami e Mogami, mentre la Germania si è distinta con l’impiego dei parà del 1° Reggimento Fallschirmjaeger.
In questo quadro, quasi al termine delle manovre, il 27 luglio, il segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha visitato la Prince of Wales, appena arrivata al porto di Darwin, insieme al vicepremier australiano Richard Marles e ha dichiarato che Londra è pronta alla guerra contro la Cina, se necessario: “Se dobbiamo combattere, come abbiamo fatto in passato, Australia e Regno Unito sono nazioni che combatteranno insieme. Ci addestriamo insieme, ed esercitandoci insieme ed essendo più pronti a combattere, mettiamo in atto una migliore capacità di dissuasione”.

Fra alcuni aspetti peculiari, sfaccettature del tema principale che riguardava la difesa delle coste australiane ed azioni di occupazione e mantenimento delle isole limitrofe, pensando evidentemente all’ipotesi di un’aggressione cinese, c’è stato anzitutto il tempestivo dispiegamento su Christmas Island di un sistema lanciarazzi pesante M-142 Himars dell’US Army, ivi trasportato da un aereo da trasporto strategico C-17 Globemaster III dell’aviazione canadese, in un tipo di missione definito “Hirain”, ovvero “Himars Rapid Infiltration”, in modo da sperimentare la rapida attivazione di un avamposto di difesa antinave con munizioni di precisione che facciano da sbarramento nei confronti di una flotta nemica.
L’esercito australiano, dal canto suo, ha sperimentato per la prima volta da uno dei suoi primi Himars, ricevuti pochi mesi prima, nel marzo 2025, dagli Stati Uniti, il lancio dal poligono di Mount Bundey del suo primo missile PrSM da 300 km di gittata, ma estendibili a 500 km sulla base dei perfezionamenti previsti dal costruttore Lockheed Martin secondo uno schema progettuale di architettura aperta.
Ciò rappresenta per il governo di Canberra un notevole rafforzamento, permettendo un’interdizione avanzata, a distanza di qualche centinaio di chilometri dalle coste, di un potenziale aggressore navale mediante un vettore molto più veloce dei velivoli pilotati. In quest’ottica vanno viste anche le prove di fuoco che l’esercito giapponese ha condotto dalla costa australiana, al poligono Beecroft di Jarvis Bay, sparando con una rampa autocarrata almeno tre esemplari del missile antinave Mitsubishi Type-12 SSM (Surface to Ship Missile), che ha una portata base di 200 km, ma che Tokyo intende migliorare in future versioni a 400, 900 e fino a un massimo di 1500 chilometri.

Al proposito, proprio come deterrente verso la Cina, è emerso un mese più tardi che il Giappone intende schierare presto la versione potenziata del Type-12 in tre basi da cui il missile potrà eventualmente spazzare le coste cinesi e l’ampio tratto di mare antistante.
Ricordando che il giornale Asahi Shimbun ha diramato le intenzioni del Ministero della Difesa di Tokyo il 29 luglio, Newsweek ha pubblicato il 30 luglio una mappa che mostra come i missili giapponesi potrebbero colpire aree importanti della Cina Orientale come Shanghai, Nanchino e Qingdao, dalle loro programmate tre basi di rischieramento, ovvero Kengun e Yufuin, rispettivamente nelle prefetture di Kumamoto e Oita, nell’isola del Kyushu, e Katsuren, sull’isola di Okinawa. Secondo le fonti giapponesi, i missili della Mitsubishi dovrebbero esservi dispiegati entro l’attuale “anno fiscale”, che termina il 31 marzo 2026.
L’enfasi sui razzi e missili a breve raggio nelle grandi manovre interalleate in Australia indica quanto, sulla base delle esperienze della guerra in Ucraina, questo tipo di armi venga considerato prezioso non solo per una classica guerra continentale, ma anche nell’ipotesi di un conflitto aeronavale nel Pacifico, dove, in aggiunta agli ordigni antinave imbarcati su navi e sottomarini, i vettori lanciabili da autocarri dislocati su coste e isole possono offrire una valida integrazione, per di più col vantaggio di piattaforme terrestri, ancorché piccole, “inaffondabili” su cui le batterie ruotate possono cambiare posizione ed eventualmente ripararsi al coperto dopo una salva di colpi. Anche questo aiuta a sbarrare il passo alla crescente marea della flotta cinese, che numericamente ormai supera 700 unità, fra grandi e minuscole, di superficie e subacquee, acquistando sempre più esperienza addestrativa sia nell’aviazione imbarcata sia nelle operazioni anfibie.

Sull’importanza assegnata al contrasto della potenza cinese per via missilistica, si segnala anche, il 16 giugno 2025 la presentazione da parte dell’esercito giapponese del prototipo del primo missile ipersonico del Sol Levante.
Sono state pubblicate infatti immagini del veicolo lanciatore, un camion 8×8, con due tubi di lancio, riprese durante l’esercitazione Fuji Firepower tenutasi a Gotemba, nella prefettura di Shizuoka, in quei giorni.
Il Giappone s’aggiunge così al club di nazioni, come Russia, Cina e USA, dotate di vettori la cui velocità superi di almeno 5 volte quella del suono, ovvero Mach 5.
Il sistema che Tokyo sta approntando si chiama HVGP, da Hyper Velocity Gliding Projectile, ed è stato realizzato dalla Mitsubishi e dall’agenzia ATLA (Advanced Technology and Logistics Agency), o Boei Sobi-cho in giapponese, un ramo del Ministero della Difesa di Tokyo per l’acquisizione di armamenti avanzati, un po’ corrispettivo della DARPA americana.
Come dice il nome inglese, sarebbe un “proiettile planante a iper-velocità”, che nell’originale giapponese è detto “Tosyoboeiyo Kosoku Kakkudan. Lungo 8 metri, è lanciabile da un autocarro a 8 ruote che porta due “canister” erigibili, ciascuno contenente un HVGP.
Accelerato da un motore a razzo fino a quota stratosferica, sgancia il primo stadio esaurito, poi la testata prosegue verso il bersaglio con una lunga planata ipersonica e con correzioni di rotta. Il principio della testata planante ipersonica è il medesimo dell’Avangard russo e del Dark Eagle americano e permette attacchi fulminei rendendo più difficile l’intercettazione dalle difese antimissile. Non è stata divulgata la velocità precisa, ma si dice solo che è superiore a Mach 5, cioè 6400 km/h.
La precisione è assicurata da un sistema di guida satellitare integrato a giroscopi, mentre per l’avvicinamento finale si sfrutterebbe anche un sensore all’infrarosso. La prima versione dell’HVGP, Block 1, ha una gittata compresa fra 300 e 500, forse estendibili a 900 km, che permette una difesa costiera avanzata nei confronti della flotta cinese.

Infatti il missile è pensato per distruggere sia obbiettivi navali, sia bersagli terrestri. In particolare, avrebbe submunizioni perforanti adatte a sfondare gli spessi ponti di una grande portaerei.
La versione base dell’HVGP è stata collaudata con l’aiuto logistico degli Stati Uniti, che ne hanno ospitato i primi lanci di prova in un poligono della California fra agosto 2024 e gennaio 2025.
L’arma dovrebbe entrare in servizio nel 2026 con reggimenti dell’esercito giapponese stanziati nel Kyushu e nell’Hokkaido, la più meridionale e la più settentrionale delle 4 grandi isole metropolitane del Giappone, in modo da fare da deterrente verso le forze navali cinesi, sul versante Sud, ma anche verso quelle russe, a Nord, provenienti dalla base di Vladivostok.
Più avanti, attorno al 2030, arriverebbero versioni potenziate dell’HVGP, Block 2, con gittata portata a 2000 e poi 3000 km, in cui la testata planante verrà perfezionata con la tecnologia “waverider” studiata dagli americani, che consente al veicolo ipersonico, letteralmente, di “cavalcare” la sua stessa onda d’urto sonica. Con le versioni potenziate, il Giappone potrà colpire basi navali e aeree della costa cinese e anche parte dell’entroterra.
Top Gun “mandarini”
Fra gli episodi più significativi delle scorse settimane c’è stato l’intenso ciclo operativo condotto tra la fine di maggio e la fine di giugno 2025 dalle due portaerei cinesi attualmente pienamente operative, la Liaoning e la Shandong, che per la prima volta hanno operato insieme nel Pacifico Occidentale, rasentando le acque di isole sotto sovranità giapponese e facendo effettuare, nell’arco di vari giorni, ai piloti dei loro aerei imbarcati un totale di 1120 decolli, e relativi appontaggi.
In particolare, secondo un rapporto divulgato il 24 giugno dal Ministero della Difesa di Tokyo, le portaerei cinesi si sono avvicinate a territori soggetti al Giappone, dopo che da giorni erano monitorate dalle forze aeronavali nipponiche e alleate.

La Liaoning avrebbe iniziato la sua crociera addestrativa il 25 maggio, facendo decollare i suoi caccia dapprima nel Mar Cinese Orientale e poi risalendo via via verso Nord.
Alla guida di una squadra di scorta composta dall’incrociatore Nanchang, di classe Type 055/Renhai, dal cacciatorpediniere Qiqihar, di classe Type 052D, e da una nave logistica, ha attraversato lo stretto di Miyako, il varco largo 250 km nell’arcipelago delle Ryukyu che si apre tra l’isola di Miyako e quella di Okinawa, entrambe giapponesi.
Poi è discesa al largo delle Filippine per fare rotta dal 30 maggio verso Nordest nella zona dell’isola Marcus. E’ stata avvistata il 7 giugno nelle acque a Est di Iwo Jima, l’isola vulcanica nipponica già teatro nel 1945 di una delle più sanguinose battaglie tra i soldati del Mikado e i Marines statunitensi.
Poi ha proseguito fino a un punto, in aperto oceano, a 300 km a Sudovest del territorio nipponico più orientale, l’isola di Minamitorishima, in un’area compresa nella Zona Economica Esclusiva di Tokyo. Poi dall’8 giugno ha invertito la rotta ed è tornata verso Ovest, avvicinandosi all’altra portaerei, la Shandong. Fino al 19 giugno, gli aerei della Liaoning hanno operato 700 decolli e appontaggi e questa crociera ha segnato per la prima volta il superamento, da parte di una portaerei cinese, della cosiddetta “seconda catena di isole”, vista da Pechino come una potenziale barriera alla sua proiezione sul mare e i cui aspetti geopolitici approfondiremo tra poco.
Nel frattempo, dal 7 giugno, la squadra della portaerei Shandong, composta dall’incrociatore Zunyi, classe Type 055/Renhai, dal cacciatorpediniere Zhanjiang, classe Type 052D, e dalle due fregate Yuncheng ed Hengshui di classe Type 054A, è passata dallo stretto di Bashi, fra Taiwan e le Filippine. La formazione s’è spinta entro il 9 giugno in un punto a meno di 1000 km a Sud delle isole metropolitane del Giappone, a Est delle piccole isole Daito, non senza suscitare preoccupazione.

Anche perché il pilota di un caccia Shenyang J-15 Feisha (“Squalo Volante”), aereo imbarcato che, come ben noto, i cinesi hanno derivato dalla serie russa dei Sukhoi Su-27/33, s’è “divertito” a inseguire per oltre mezz’ora, nella mattinata del 7 giugno, un ricognitore giapponese a turboelica Lockheed P-3C Orion tenendosi a soli 45 metri di distanza dietro la sua coda.
Poi, nel pomeriggio dell’8 giugno, un altro “Top Gun” cinese ai comandi di un J-15 ha tagliato la strada a un ulteriore P-3C nipponico, sebbene in tal caso mantenendo una distanza di almeno 900 metri.
Di fronte alle bravate dei piloti dell’aviazione navale cinese, che ricordano simili spericolate intercettazioni di aerei della NATO da parte dei piloti da caccia russi sopra il Baltico e il Mar Nero, il capo di Stato Maggiore delle forze armate giapponesi, generale Yoshida Yoshihide, ha commentato il 12 giugno che “l’anormale approccio dell’aereo cinese poteva cagionare una collisione accidentale. Implementeremo una sorveglianza ancor più stretta”.

Peraltro, l’episodio ha riportato al ricordo di una tragedia occorsa ben 24 anni fa. Era infatti il 1° aprile 2001 quando un caccia intercettore cinese, nei cieli vicino all’isola di Hainan, si avvicinò così tanto a un EP-3 Aries II della US Navy, versione da spionaggio elettronico del P-3 Orion, da cozzare contro l’aereo americano. L’EP-3, gravemente danneggiato ma con l’equipaggio salvo, fece un atterraggio d’emergenza su Hainan, dove i cinesi lo trattennero alcuni giorni, ma il caccia cinese precipitò, con la morte del pilota, tenente Wang Wei.
La Shandong e le sue unità si scorta hanno navigato seguendo una rotta vagamene circolare in senso orario attorno all’isola Okinotorishima, il territorio giapponese più meridionale, poi, dopo aver stazionato fra 18 e 20 giugno, in un area ristretta a Nordest dell’isola filippina di Luzon, erano ormai instradate il 22 giugno per il ritorno alla base in Cina.
Dal 9 al 22 giugno gli aviatori della Shandong hanno effettuato 420 decolli e appontaggi. Le crociere coordinate delle due portaerei cinesi, secondo il portavoce della Marina di Pechino, capitano Wang Xuemeng, avevano lo scopo di “testare le loro capacità di protezione e di operazioni congiunte in mare aperto”.
Chiaramente le capacità dell’aviazione imbarcata cinese sono ancora inferiori a quelle della corrispettiva Naval Aviation statunitense, dato che, per efficienza tecnica ed esperienza operativa, una portaerei americana è in grado di sfoderare una forza complessiva maggiore di una cinese. Il programma delle portaerei di Pechino, tuttavia, è in costante sviluppo e si pensa che possa arrivare perfino a 6 unità operative dopo il 2030.

Attualmente, oltre alla Liaoning e alla Shandong, operative rispettivamente dal 2012 e dal 2019, è in procinto di entrare il servizio la terza, la Fujian, varata nel 2022 e completata nel 2024, quando ha iniziato le prove di mare attualmente in corso. Questa terza portaerei cinese, secondo quanto scriveva il 17 giugno scorso il South China Morning Post, potrebbe entrare in servizio “per la fine del 2025”.
E’ invece in costruzione solo dal 2024, nel cantiere di Dalian, la quarta portaerei, per ora nota solo come Type 004, che diverrà la prima cinese con propulsione nucleare, oltre che presunta capoclasse di una serie di 3-4 gemelle previste negli anni successivi.
Il programma di portaerei volto ad assicurare appoggio aereo ravvicinato in operazioni di occupazione di isole o coste e di confronto con flotte nemiche, è una delle pietre angolari della generale strategia con cui la Cina intende aprirsi la strada al mare aperto in caso di guerra e assicurarsi, presto o tardi, la capacità effettiva di prendere Taiwan.
Taiwan nel mirino
Di fronte alle frequenti manovre aeronavali cinesi nelle acque attorno all’isola di Taiwan, che il governo di Pechino minaccia sempre, presto o tardi, di invadere e occupare, le forze armate di Taipei si tengono sempre all’erta, tanto fa aver monitorato strettamente i sopra citati movimenti delle portaerei Liaoning e Shandong.
Oltre ad aver intensificato i rapporti militari con gli Stati Uniti, dopo l’avvento nel gennaio 2025 della nuova amministrazione di Donald Trump, hanno dimostrato la loro prontezza ridando nuovo fiato alle esercitazioni annuali Han Kuang, che in questo 2025 si sono tenute dal 9 al 19 luglio.

Le manovre taiwanesi, che esamineremo fra poco, hanno fatto seguito a un crescendo di pressioni cinesi fra cui, il 2 aprile, le esercitazioni Strait Thunder 2025-A, o “Tuono dello Stretto”, che seguivano di pochi giorni un viaggio del segretario alla Difesa USA Pete Hegseth negli avamposti americani nel Pacifico.
E’ stato così nel segno di una doppia sfida, a Taipei e anche a Washington, che le forze aeronavali di Pechino hanno in quell’occasione, secondo il portavoce del Comando Militare Orientale cinese, colonnello Shi Yi, operato per dissuadere i taiwanesi dal progredire verso un’indipendenza formale, secondo la dottrina dell’Unica Cina, provando le capacità di “blocco navale, espulsione (inteso di eventuali forze americane e alleate in soccorso, n.d.r.) e attacco a obbiettivi chiave sull’isola”.
Oltre a numerosi tiri in mare con munizioni vere, si sono simulati attacchi alle infrastrutture civili ed energetiche dell’isola. Pechino ha schierato 20 navi militari, fra cui la portaerei Shandong, e ben 76 aerei da guerra, tra cui bombardieri pesanti Xian H-6K (come noto, derivazione cinese, relativamente evoluta, del vecchio bombardiere sovietico Tupolev Tu-16).
Sia i bombardieri, sia le navi classe Type 055 hanno provato anche il nuovo missile ipersonico antinave YJ-21, ormai considerato operativo e destinato soprattutto ad affondare le portaerei americane, e in genere le unità maggiori della US Navy, qualora affiancassero Taipei. E’ un ordigno lungo circa 8 metri, con raggio d’azione di 1,500 km che sfreccia fra Mach 6 e Mach 10, da 6 a 10 volte la velocità del suono, ovvero da 7000 a 12.000 km/h.

Da un punto di vista operativo, la strategia cinese, per quanto non specificata ufficialmente, per ovvi motivi, contemplerebbe un blocco navale tutt’intorno all’isola, per affamare il nemico, preparando nel contempo un dispiegamento di forze in grado di contrastare un soccorso aeronavale americano e alleato, la speranza a cui si affida Taipei e che giustifica la preparazione di una capacità di resistenza armata sufficiente, almeno alcune settimane, se non mesi, a dar tempo ai paesi amici di intervenire con una massa bastante alla dimensioni della battaglia.
I cinesi hanno rafforzato enormemente la componente anfibia della loro flotta, che attualmente conta un totale di 81 unità, fra maggiori e minori.
Fra le più recenti, le 8 navi da sbarco classe Type-71A, da 25.000 tonnellate, entrate in servizio fra il 2007 e il 2020, mentre fra 2026 e 2027 si prevede l’entrata in linea della prima unità della nuova classe Type-076 di portaelicotteri anfibie, la Sichuan, varata nel 2024 ai cantieri di Shanghai, attualmente in fase di completamento, un colosso da 50.000 tonnellate in grado di portare 1000 soldati, decine di elicotteri e anche due hovercraft da sbarco Yuyi alloggiati nella stiva interna.
Peraltro, ci si domanda se, oltre a navi da sbarco, le classiche “ro-ro” (roll in-roll out, stile traghetti) e a hovercraft, i “Marines” cinesi non intendano affidarsi nel prossimo futuro anche ai cosiddetti ekranoplani, alias “schermoplani”, dalla parola russa per “schermo”, ekran, o detti in inglese anche WIG, da “wings-in-ground”, sorta di incrocio fra un idrovolante e un veicolo marittimo, in quanto sono in sostanza idrovolanti a effetto suolo, mezzi che ebbero interessanti risvolti militari in Unione Sovietica.

Dallo scorso 30 giugno sono state infatti diffuse foto di un ekranoplano cinese in sperimentazione, battezzato per ora Bohai Sea Monster, che appare come un idrovolante a reazione, con ala alta e impostazione a scafo centrale, quattro turboreattori in posizione dorsale sopra l’ala e una coda con timoni verticali a V che reggono un piano orizzontale. Le dimensioni non sono state divulgate e dalle foto sembrerebbero limitate, non più di una ventina di metri.
E’ possibile che il “mostro marino di Bohai”, così chiamato da golfo in cui viene collaudato, non lontano da Pechino, possa essere un prototipo da cui i cinesi intendano poi ricavare velivoli assai più grandi.
E’ noto che fra 1966 e 1987 i sovietici realizzarono vari ekranoplani sperimentali, a getto e a turboelica, come il KM, detto “Mostro del Mar Caspio”, l’Orlyonok e il Lun, con pesi che andavano dalle 150 alle 500 tonnellate, paragonabili a piccole unità navali, ma con velocità di tipo aeronautico, sui 500 km/h, rese possibili dal volo in “effetto suolo” radente per pochi metri sopra la superficie marina.
Per ironia della sorte, proprio mentre si aveva conoscenza del prototipo cinese Bohai Sea Monster, negli USA l’agenzia DARPA interrompeva un programma di sviluppo, iniziato nel 2022, per un ekranoplano americano, il grosso Liberty Lifter, in realtà un idrovolante gigante in grado di alzarsi fino a 3000 m di quota, ma che sfruttando il volo radente in effetto suolo avrebbe potuto prolungare la sua autonomia fino a ben 12.000 km, potendo trasportare un carico, in soldati, armi o munizioni, pari a 90 tonnellate.
Un progetto che, se andato in porto, avrebbe dato corpo a un prototipo attorno al 2027-2028 e che, qualora ripescato dal Pentagono, potrebbe ancora assicurare in futuro agli Stati Uniti una capacità aggiuntiva di dispiegamento rapido per via aerea di truppe, proprio nello scacchiere del Pacifico, col vantaggio di poter ammarare presso isole e atolli privi di adeguate piste.
Chiaramente, avere i mezzi e addestrarsi non basta a dare garanzie di successo.

La Cina, di fatto, non ha esperienza di combattimento in vere e proprie guerre dal lontano 1979, quando tentò senza successo di piegare il vicino, ma agguerrito Vietnam, forte della “fresca” esperienza del lungo conflitto da pochi anni concluso con il massimo nemico possibile, ovvero l’America. I cinesi, probabilmente, si sentono ancora insicuri per il fatto di non essere “allenati” alle guerre, a differenza di USA e Russia che, senza contare i decenni precedenti, anche solo dal 1991 a oggi, sono stati periodicamente impegnati in estesi conflitti fra Iraq, Cecenia, Afghanistan, Georgia e oggi Ucraina.
Proprio sul fronte ucraino, secondo quanto dichiarato il 10 aprile scorso dal presidente Volodymir Zelensky, sarebbero impegnati in combattimento a fianco dei russi almeno 155, forse 163, militari cinesi, due dei quali catturati nei giorni precedenti dalle truppe di Kiev.
La Cina ha negato tutto, ma è plausibile che, come già la Corea del Nord, su scala molto più vasta, nell’affiancare i russi nel Kursk, favorisca che propri militari accumulino un’esperienza di guerra moderna reale, da “travasare” poi nelle accademie militari e nelle scuole degli ufficiali cinesi.
L’isola-istrice
Le valutazioni sulla reale volontà cinese di attaccare “l’isola ribelle”, come viene ufficialmente definita Taiwan dal regime comunista di Pechino, sono molto contrastanti, poiché non è ben chiaro quanto ci sia di bluff in una minaccia militare che esiste concretamente, ma che costerebbe alte perdite, in uomini e mezzi. In proporzione alle sue piccole dimensioni, pari a un’area di circa un decimo di quella italiana e a una popolazione di 23 milioni di abitanti, l’isola è infatti un ben armato istrice, spesso attuante prove di mobilitazione permanente.

Il 25 maggio un rapporto della Defense Intelligence Agency, l’agenzia d’informazioni delle forze armate USA, sosteneva che “la Cina continuerà a rimandare la conquista di Taiwan fino a raggiungere una soluzione negoziata poiché in caso di azione militare le perdite supererebbero i benefici”.
Il 31 maggio, a margine del vertice sulla sicurezza regionale Shangri-La tenutosi a Singapore, il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth ha ritenuto apertamente “imminente la minaccia della Cina a Taiwan”, aggiungendo che “Pechino userà la forza militare per mutare gli equilibri di potenza nel Pacifico”. In genere, gran parte degli analisti tende ad accreditare l’ipotesi del Pentagono secondo cui la Cina potrebbe essere pronta ad attaccare l’isola “ribelle” a partire dal 2027.

Tuttavia, la tradizionale importanza data all’approccio indiretto dalla strategia cinese, in omaggio all’eredità dell’antico maestro Sun Zi (o Sun Tzu), vissuto attorno al 500 avanti Cristo, rende più plausibile un lento lavorio politico ed economico, senza porsi il problema di una rapida vittoria. Secondo tale interpretazione, la Cina attaccherebbe platealmente, quasi con riluttanza, soltanto se la guerra ad alta intensità risultasse inevitabile a causa del fallimento di strategie “morbide” di lunghissimo periodo.
Certo, per Pechino è importante fare sempre la faccia feroce e non a caso il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha detto che l’Esercito Popolare di Liberazione “è sempre pronto a perseguire la completa riunificazione della Cina, impegnandosi nel contrastare tentativi separatisti di indipendenza di Taiwan, nonché interferenze di forze esterne”.

Dong ne ha parlato il 1° agosto a una cerimonia in cui si celebrava il 98° anniversario della fondazione dell’attuale esercito comunista cinese, che nel 1927, ai tempi di Mao Zedong, era ancora un’armata partigiana. Gli facevano da uditori, oltre a un folto gruppo di funzionari, anche Liu Zhenli e Zhang Shengmin, due importanti membri della Commissione Militare Centrale, il massimo organo di coordinamento fra vertice politico e vertice militare in Cina, il cui capo supremo è il presidente Xi Jinping. Il ministro ha inoltre rammentato che le forze armate si stanno già preparando alle grandi parate previste in tutto il paese il prossimo 3 settembre, per ricordare l’80° anniversario della vittoria sul Giappone, nel 1945.
Di fronte a queste minacce, il governo di Taipei si prepara costantemente per scoraggiare una eventuale aggressione. Il 15 maggio il Congresso USA ha confermato che sono arrivati nell’isola ben 500 consiglieri militari americani, per migliorare l’addestramento delle truppe taiwanesi. Le quali, peraltro, hanno ricevuto dall’America, e stanno tuttora collaudando, lanciarazzi campali Himars uguali a quelli forniti all’Ucraina.

Proprio il conflitto russo-ucraino, si dice, potrebbe, da un lato rappresentare un precedente che incoraggi Pechino al colpo di mano, ma dall’altro lato infondere fiducia in Taipei portando l’esempio della strenua resistenza di Kiev. Senza contare che, a differenza del caso ucraino, le difficoltà di un’invasione sono raddoppiate dal fatto che Taiwan è un’isola separata dal continente
Il 3 luglio, mentre Taiwan preannunciava le esercitazioni Han Kuang, le forze aeronavali cinesi attuavano una delle loro tipiche azioni di intimidazione, inviando nelle acque e nei cieli dello stretto di Formosa 9 navi da guerra, fra cui alcune unità da sbarco, e 41 aerei da combattimento, 30 dei quali hanno volato fino a introdursi della Zona di Identificazione e Difesa aerea dell’isola. Il presidente taiwanese Lai Ching Te affermava in quei giorni: “Di fatto con la Cina c’è già una guerra senza il fumo dei cannoni. L’isola è un paese e se la Cina ci annette, non si fermerà”.

Finalmente, il 9 luglio, sono iniziate le manovre Han Kuang, durate fino al 19 luglio. Hanno mobilitano 22.000 riservisti per una vasta gamma d’operazioni: “Difesa aerea, fuoco di precisione aereo e navale contro i gruppi da sbarco cinesi e contrattacco terrestre contro le teste di ponte dei marines cinesi”. Si sono impiegati droni marittimi per la difesa costiera, i lanciarazzi Himars.
La difesa aerea ha fatto sfoggio del missile indigeno Tien Chien, o “spada del cielo”, con raggio d’azione di 100 km, mentre la flotta si sta arricchendo con i nuovi sottomarini classe Hai Kun, il primo dei quali è stato varato nel 2023. L’aviazione taiwanese si rinnova con l’ultima versione dell’F-16 americano, F-16V Viper, e col jet nazionale T-5 Yongying, addestratore utilizzabile come caccia leggero. Studiata l’esperienza dell’Ucraina i generali di Taipei hanno pianificato la simulazione di attacchi cinesi contro i centri di comando.

Si sono in tal modo allenati a diradare le loro forze sul territorio, ripristinare le comunicazioni in situazioni d’emergenza e contrastare la cyberguerra cinese sulle reti telematiche. Ciò fa presupporre che anche nel caso in cui sferrino massicci attacchi aerei e missilistici, i cinesi debbano fare i conti con una certa preparazione taiwanese alla resilienza e alla ridondanza, in modo da ammortizzare notevolmente le spallate nemiche.
Parte del programma delle manovre Han Kuang riguardava d’altronde la difesa civile, la riparazione di infrastrutture bombardate, la difesa delle città e lo sviluppo di un sistema di messaggistica d’allerta sui telefonini della popolazione per segnalare attacchi o per altre comunicazioni d’emergenza. Innovazioni apertamente ispirate all’esperienza dell’Ucraina.

Legato alla questione della difesa di Taiwan, si ipotizza da alcune settimane che gli Stati Uniti possano destinare alle forze di Taipei almeno una parte dei loro aerei d’attacco corazzati Fairchild A-10 Thunderbolt II, meglio noti fra i piloti come “Warthog” (“Facocero”) specializzati nella lotta ai carri armati e, in senso più ampio, nell’appoggio tattico a bassa quota.
Un aereo risalente alla Guerra Fredda, come si sa in servizio dal 1976, ma ancora tenuto in efficienza dall’USAF in 162 esemplari, che però dovrebbero essere dismessi nel 2026 per motivi di costi.

Si noti che in tre anni di guerra in Ucraina l’ipotesi di dare gli A-10 alle forze di Kiev non è stata mai presa in seria considerazione, a riprova che, in fondo, ciò che preoccupa davvero Washington, specialmente con Trump, è la Cina e non la Russia.
Catene lungo i mari
Taiwan è solo un capitolo del complessivo dilemma strategico cinese, ovvero lanciarsi in una politica navale così ambiziosa da completare la trasformazione della propria flotta da “marina da acque verdi”, cioè in sostanza costiera, a “marina da acque azzurre”, cioè pienamente oceanica. Si tratta di qualcosa di relativamente inusuale nella millenaria storia della Cina, che è sempre stata tradizionalmente una civiltà continentale piuttosto isolata.
Di fatto, la Cina fu una potenza oceanica solo nel XV secolo, all’epoca della dinastia Ming. Dal 1405 al 1422 l’ammiraglio Zheng He guidò sette spedizioni oceaniche con giunche giganti fino all’India, all’Africa e forse all’Australia. Ma la casta mandarina volle interrompere i contatti oltremare per non turbare la stabilità sociale.
La Cina preferì vigilare sul fronte delle steppe, dove i mongoli non sempre erano arginati dalla Grande Muraglia. Dopo il 1500 furono così i galeoni europei ad acquisire il dominio dei mari asiatici colmando il vuoto strategico lasciato da una Cina ripiegata su sè stessa. Più tardi, quando nel XIX secolo iniziò l’era delle corazzate a vapore, la dinastia manciù dei Qing tentò di costituire una flotta moderna, annientata però nel 1894 dai giapponesi.

Col comunismo di Mao Zedong, nel 1949 la flotta cinese rinacque come Marina Popolare di Liberazione, avente come obbiettivo primario la conquista di Taiwan. Dopo il 1990, il prepotente sviluppo economico della Cina, favorito anche, per ironia della sorte, da pesanti investimenti industriali delle multinazionali occidentali, ne ampliò l’orizzonte geopolitico. Negli ultimi decenni l’espansione della flotta militare e di quella mercantile sono andate di pari passo, man mano che per la Cina odierna diventava vitale controllare e difendere le rotte di approvvigionamento di materie prime ed energia, specie le rotte delle petroliere e dei cargo da l’esportazione, colmi di prodotti Made in China. La costa cinese è però chiusa da una doppia catena di isole, controllate da alleati degli Stati Uniti o presidiate da basi americane.
La prima catena di isole si snoda dall’isola giapponese di Kyushu a Taiwan, Filippine e Borneo. La seconda catena di isole inizia invece dalla maggiore isola del Giappone, Honshu (o Hondo), e passa dalle Ogasawara, dalle Marianne, dove si trova la grande base USA di Guam, e arriva fin giù alla Nuova Guinea.
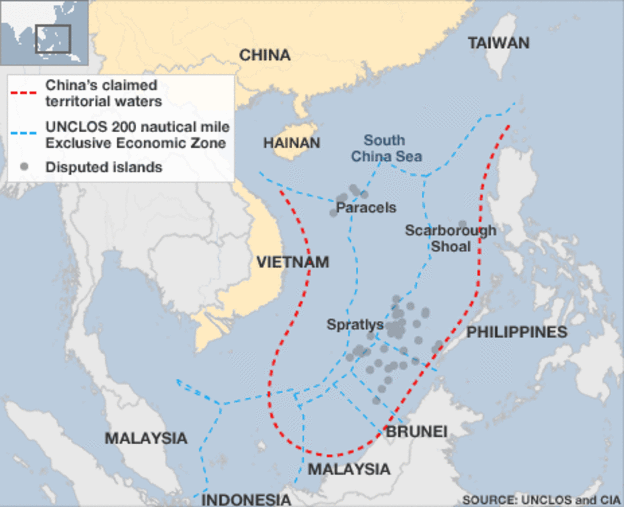
Più a Sud, a chiudere le catene di isole contribuisce la mole del continente australiano, mentre a Ovest, i passaggi verso l’Oceano Indiano, e le rotte del petrolio e del commercio verso il Medio Oriente, e, più in là, Suez e l’Europa, sono condizionati dalle isole della Sonda e dalla presenza dell’India, media potenza non certo amica della Cina, sebbene la comune amicizia con la Russia le tenga, un po’ forzatamente, insieme nel gruppo BRICS.
In quel settore del Mar Cinese Meridionale, porta per l’Oceano Indiano i cinesi rivendicano da sempre la cosiddetta “lingua di bue”, dal profilo degli arcipelaghi che si protendono verso l’Indonesia.
Le catene di isole controllate da paesi avversari renderebbero molto pericolose in caso di conflitto le operazioni di proiezione aeronavale cinese. Per spezzare tale assedio virtuale, i cinesi hanno, a partire dal 2015, installato basi navali, radar e aeroporti per bombardieri negli arcipelaghi delle Spratly e delle Paracel, nel Mar Cinese Meridionale, da dove minacciano gli stretti della Malacca e della Sonda. Fra i cardini della loro strategia abbiamo visto la costruzione di un numero crescente di portaerei, nonché il rafforzamento della componente sottomarina. Saranno il fulcro delle squadre che in caso di guerra si apriranno la via, combattendo aspramente, oltre le due catene di isole, guadagnando l’oceano aperto.
La geopolitica navale della Cina è simile, per molti aspetti, quella giapponese della Seconda Guerra Mondiale. Pechino deve proteggere le sue importazioni marittime, specie di petrolio, e nel contempo insidiare quelle degli alleati locali dell’America, come il Giappone, Taiwan e la Corea del Sud.
Ma deve anche assicurarsi, in caso di guerra, il controllo degli arcipelaghi prospicienti la sua costa orientale. Con le sue attuali, e prossime, portaerei, la Cina può anzitutto garantirsi la superiorità aerea locale nello stretto di Taiwan nel caso di uno sbarco sull’isola.

Ma può anche proteggere corpi di spedizione destinati a occupare isole strategiche per frantumare il catenaccio Australia-Indonesia-Filippine-Giappone. Inoltre, utilizzando come basi avanzate le isole Spratly e Paracel, la forza aeronavale cinese, insieme ai sommergibili, può insidiare il traffico navale che passa dagli stretti della Malacca e della Sonda, bloccando il flusso di petroliere dirette verso Giappone e Sud Corea.
La Cina stessa si è tutelata tramite una via alternativa per le importazioni provenienti dall’Oceano Indiano, aprendo sulla costa dell’alleato Pakistan il porto di Gwadar, come sbocco di un corridoio ferroviario e stradale che passa dall’entroterra dei due paesi.
Sindrome d’accerchiamento
La prospettiva cinese di sentirsi, in qualche modo, accerchiati sul versante del mare è rafforzata anche dal fatto che tra le nazioni ostili, allineate agli americani, ci sono le Filippine, stato-arcipelagico per antonomasia che, geostrategicamente, costituisce un po’ il contraltare meridionale del Giappone nella sua funzione di barriera.
Nella primavera del 2025 i timori di Pechino, che già contende a Manila varie isolette con perenne confronto tra le motovedette delle rispettive Guardie Costiere, sono stati rafforzati da un lungo ciclo di manovre militari congiunte tra USA e Filippine.

Dal 24 marzo al 14 aprile s’è svolta una prima fase di esercitazioni con impegno complessivo di 5.000 soldati, tra americani e filippini, consacrata il 28 e 29 marzo dalla visita a Manila del capo del Pentagono Hegseth, come tappa di un più ampio tour in Asia che lo ha portato in quei giorni anche alle Hawaii, in Giappone e a Guam per ispezionare le maggiori basi militari americane dell’area.
Il vicecapo di stato maggiore dell’US Army nel Pacifico, generale Jeffrey Van Antwerp, ha spiegato in quell’occasione che durante le manovre “non verranno fatte prove di fuoco del lanciamissili Typhon”, che nel 2024 era stato schierato sperimentalmente sull’isola di Luzon, e che l’esercito filippino vorrebbe comprare.
Il Typhon può lanciare sia missili antiaerei SM-6 sia missili da crociera Tomahawk con gittata di 1600 km e gli americani per ora non vogliono aumentare la tensione. Trump ha affermato: “Non vogliamo una guerra con la Cina, ma siamo preparati”.
Nel frattempo, sempre a fine marzo, il South China Morning Post, uno dei maggiori giornali cinesi, ha riportato la Marina Cinese ha presentato un nuovo dispositivo per “tranciare i più robusti cavi di telecomunicazioni sottomarini”, fino a profondità di 4000 metri. L’apparato, sviluppato dall’istituto China Ship Scientific Research Centre, può essere montato sui batiscafi cinesi abissali Fendouzhe, con equipaggio di 3 uomini, e sui droni subacquei Haidou. Un annuncio a effetto, calcolato nel pieno della tensione per le manovre filippino-americane per contribuire alla deterrenza.
Poco dopo, si sono tenute sul territorio di Manila, manovre ancor più ampie, le Balikatan, dal 21 aprile al 9 maggio, che comprendevano ben 10.000 soldati USA, più 6000 soldati di Filippine, Australia e Giappone, nonché piccole rappresentanze di Canada, Gran Bretagna, Francia e Sud Corea.

Le Filippine, peraltro, hanno comprato armi israeliane come il sistema antiaereo Spyder e il missile navale Spike, entrambi della Rafael, il missile sudcoreano C-Star e quello francese Mistral-3.
Nel corso delle Balikatan è stato confermato l’impiego dei lanciamissili Typhon, tanto che Pechino ha reagito mandando la portaerei Shandong a navigare a Nord di Luzon, quasi a frapporsi rispetto a Taiwan. Americani e filippini si sono esercitati inoltre nella difesa antiaerea abbattendo droni-bersaglio, ma anche nelle operazioni anti-nave, implicitamente pensando alla flotta cinese, col sistema missilistico antinave NMESIS.
I cinesi, in parte stanno reagendo intensificando rapporti commerciali e militari con alcuni paesi dell’area in modo da attuare una sorta di “controassedio” che apra utili varchi nei catenacci di contenimento. Tra gli esempi, le manovre “Blue Strike 2025”, che le forze di Pechino hanno attuato dal 26 marzo al 2 aprile insieme alla Thailandia, con schieramento di 11 navi al largo della provincia cinese del Guangdong con tema “antiterrorismo, attacco marittimo e guerra subacquea”.
Poi, il 15 maggio, la Cina ha confermato la sua influenza sulla Cambogia con grandi esercitazioni militari congiunte in quella nazione, la Golden Dragon 2025. Vi hanno partecipato, fino al 28 maggio, 900 soldati cinesi e 1300 militari cambogiani.
Una nave militare cinese è approdata alla base navale cambogiana di Ream e i cinesi hanno sperimentato perfino “cani robot militari”. La Cambogia era filo-Pechino dai tempi dei Khmer Rossi di Pol Pot, nel 1975, ed è sempre più legata ai cinesi, che ne possiedono circa il 35% del debito estero. La marina cambogiana riceverà presto nuove navi di fattura cinese, inoltre si sospetta, anche se Pechino per ora lo nega, che la base di Ream diventerà la prima base navale cinese nel Sudest asiatico.
L’influenza della Cina è stata preziosa, insieme alla mediazione di USA e Malesia, per far giungere Cambogia e Thailandia a un cessate il fuoco dopo gli scontri di frontiera verificatisi fra i due paesi dal 24 al 28 luglio 2025, ma quel cessate il fuoco resta fragilissimo e imperfetto. E dimostra come i cinesi in realtà non possano considerare veri alleati paesi tra loro così ostili, tanto da minare fin dal principio ogni ipotesi di una seria e stabile coalizione di stati asiatici capeggiati dalla Cina.

Idem se si considera la storica notizia delle prime esercitazioni militari congiunte fra Cina e Vietnam, storici rivali fin dai secoli passati, oltre che nella guerra del 1979 e, anche di recente, in disputa per alcune delle isole Spratly. Il fatto che un numero esiguo di soldati cinesi e vietnamiti, appena 140 in totale, si siano addestrati dal 21 al 30 luglio nella base di Jianglong Chongzuo, nella regione cinese del Guangxi Zhuang, con “attività di ricognizione, guerra in montagna e uso di droni”, sembra, al momento, più una vetrina politica e un messaggio agli Stati Uniti in piena tempesta dei dazi, che una vera svolta.
La Cina, quindi, pare al momento ancora incapace di andare al di là dello sviluppo di relazioni bilaterali sostanzialmente buone, se considerate separatamente per paese, ma insufficienti a creare anche solo un barlume di una stabile alleanza collettiva.
Pechino deve quindi ancora contare soprattutto sulle sue forze e una garanzia sicura di deterrenza continua a risiedere nel suo arsenale nucleare, che sta crescendo anche più in fretta del previsto. Già il 25 maggio scorso, la Defense Intelligence Agency americana confermava le stime di Washington secondo cui i cinesi avrebbero ormai 600 testate nucleari, contro le 300 da essi ammesse fino a pochi anni fa, e che potrebbero arrivare a 1000 entro il 2030.
Poi, il 17 giugno, il noto istituto svedese SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) di Stoccolma ha divulgato un più preciso rapporto, ricavato soppesando dati da varie fonti, come il Pentagono, la Federation of American Scientists o il Bulletin of Atomic Scientists, confermando che i cinesi, non solo avrebbero 600 ordigni nucleari, ma che si sarebbero stabilizzato su un inquietante ritmo di crescita di 100 testate all’anno.
L’accelerazione dell’aumento delle atomiche di Pechino è tale che esse sarebbero raddoppiate negli ultimi sette anni.
La Cina collaudò la sua prima atomica a fissione nel 1964 e già nel 1966 testò un’esplosione a fusione termonucleare, ovvero la bomba H. Condusse test atomici reali fino al 1996 in un poligono nell’arido deserto di Lop Nor. Ma per anni il suo arsenale crebbe lentamente, restando inferiore anche a quelli di Francia e Gran Bretagna, oltre che ovviamente a quelli di Russia e America. Ancora nel 2003 l’arsenale atomico cinese contava 235 testate ed entro il 2018 era cresciuto molto lentamente fino a 280 ordigni.

Poi, ecco l’impennata. Nel 2023 i cinesi avevano 410 testate, già salite a 500 nel 2024 e alle 600 del 2025. Un ritmo, come precisato dal SIPRI, effettivamente di ben cento ordigni all’anno che accrediterebbe le stime del Dipartimento della Difesa americano secondo cui la Cina arriverebbe a schierare “1000 testate nucleari entro il 2030 e ben 1500 nel 2035”.
Secondo l’esperto del SIPRI Hans Kristensen, la Cina procede con “aggiornamento industriale, dalle fabbriche agli impianti di riprocessamento e ai centri di simulazione usati per sviluppare nuove armi”. Aggiunge comunque che la Cina è certo il paese che ha la crescita più rapida, ma tutte le potenze nucleari si stanno rafforzando, a cominciare dagli USA, tanto che “l’era della riduzione delle atomiche, che durava dalla fine della Guerra Fredda, sta finendo”.
Pechino ha accolto il rapporto del SIPRI con un secco “no comment”. Nessun trattato sul disarmo la lega alle altre potenze, a differenza ad esempio del patto New START sulle testate strategiche in vigore fra USA e Russia, che pure scadrà nel febbraio 2026. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, s’è limitato a ricordare che “la dottrina nucleare cinese sancisce il rifiuto del primo uso” e che “la Cina ha sempre aderito alla strategia nucleare di autodifesa, ha sempre mantenuto le sue forze nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale e non ha partecipato alla corsa agli armamenti”.

Dal canto suo, l’analista cinese Zhang Junshe ha osservato che, in effetti, mentre la dottrina del non-primo uso delle armi nucleari è ufficiale in Cina “altre potenze non hanno mai fatto tali promesse”, specie gli USA, che non hanno mai escluso la possibilità di un loro “primo colpo” nucleare e che, del resto, sono stati anche il primo paese a farne uso, nell’agosto 1945 su Hiroshima e Nagasaki per far arrendere il Giappone. E, sia detto per correttezza, sicuri della totale impunità, ben sapendo gli americani che i giapponesi non avrebbero potuto attuare alcuna ritorsione proporzionale!
Le dimensioni dell’arsenale cinese sarebbero confermate dal completamento dei 350 nuovi silos di lancio sotterranei per missili intercontinentali fotografati dai satelliti americani in tre zone desertiche del paese, a Yumen, nel Gansu, ad Hami, nello Xinjiang, e a Ordos, nella Mongolia Interna.

Vero è che una parte di tali silos potrebbero essere falsi, come esca. Ricorderemo che fra i missili più potenti in dotazione alle forze nucleari cinesi spicca il Dong Feng DF-41, con gittata di ben 15.000 km e in grado di portare fino a 10 testate di potenza, cadauna, di 475 kilotoni (40 volte Hiroshima). Il DF-41 può essere lanciato sia da silos fisso, sia da autocarro o da vagone ferroviario.
Ma fra i vettori dei loro ordigni atomici, i cinesi stanno preparando anche il nuovo bombardiere “invisibile” ai radar Xian H-20, molto simile alle “ali volanti” americane B-2 e B-21. Aereo potenzialmente ambizioso, potendo volare fin oltre la seconda catena di isole, ma il cui sviluppo, per la stessa ammissione dei militari cinesi, sta procedendo con maggior ritardo del previsto.
Foto: Casa Bianca, US DoD, PACOM, Xinhua, Governo Australiano, Forze Armate Giapponesi e Ministero Difesa Taiwan
Leggi anche:
I convertiplani Osprey giapponesi a Camp Saga per la Brigata d’intervento rapido
Taiwan: una polveriera che potrebbe rimodellare gli equilibri globali
La flotta cinese mostra i muscoli, a Taiwan arrivano gli Abrams
Mobilitazione popolare e società di sicurezza: Taiwan si prepara all’invasione

Mirko MolteniVedi tutti gli articoli
Nato nel 1974 in Brianza, giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e collabora col quotidiano “Libero” e con varie riviste. Per le edizioni Odoya ha scritto nel 2012 “L'aviazione italiana 1940-1945”, primo di vari libri. Sempre per Odoya: “Un secolo di battaglie aeree”, “Storia dei grandi esploratori”, “Le ali di Icaro” e “Dossier Caporetto”. Per Greco e Greco: “Furia celtica”. Nel 2018, ecco per Newton Compton la sua enciclopedica “Storia dei servizi segreti”, su intelligence e spie dall’antichità fino a oggi.