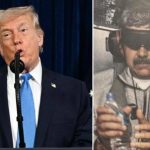La vera partita è tra Stati Uniti e Russia

L’accodamento degli Stati Uniti all’attacco militare di Israele contro l’Iran, non cambia nella sostanza quella sorta di offensiva diplomatica che gli Stati Uniti hanno sferrato negli ultimi mesi, con l’inizio dell’amministrazione di Donald Trump, è rivolta soprattutto a tentare di superare la crisi con la Russia, aggravatasi sempre più dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, anche per cercare di sottrarre Mosca all’influenza di Pechino.
E il principio seguito da Trump e dal suo staff appare sempre più quello di un approccio complessivo dei problemi fra Russia e Occidente, di cui la questione ucraina è solo uno degli snodi. Washington cerca di dare ascolto al costante ritornello della diplomazia russa, secondo cui la via per la pace passa dalla risoluzione delle “cause profonde del conflitto”.
Lo sbilanciamento dei rapporti di forza tra NATO e Russia, con l’espansione a Est dell’alleanza, a cui è poi seguita, sull’onda del conflitto, la recentissima adesione di Svezia e Finlandia al patto atlantico, è certo fra le primissime preoccupazioni di Mosca, la cui aggressività può calare solo in cambio di rassicurazioni strategiche.
Non facili dato che, alla sostanziale esclusione di un possibile ingresso dell’Ucraina nella NATO non s’è accompagnata la cessazione del rischio che consistenti truppe dei paesi dell’alleanza vengano dislocate su territorio ucraino, camuffate da “peacekeepers” dei paesi “volenterosi”, eventualità che servirebbe solo ad aumentare ulteriormente la tensione con la Russia. Fra i temi maggiori c’è inoltre quello dei missili a medio raggio, che statunitensi e russi sono tornati a sviluppare negli ultimi anni a seguito dello smantellamento nel 2019 del Trattato INF, da cui Trump stesso, durante il suo primo mandato, fece ritirare gli Stati Uniti reputandolo “un accordo non buono” perché lasciava fuori la Cina, che infatti ha potuto creare da molti anni un’ingente flotta di vettori a medio raggio.
Interessi reciproci
La notte sul 22 giugno 2025 il presidente americano Donald Trump ha rotto gli indugi, ordinando un attacco combinato statunitense sulle strutture nucleari iraniane di Fordow, Natanz e Isfahan, accodando così gli Stati Uniti alle operazioni di guerra scatenate da Israele dal 13 giugno contro la ex-Persia, proprio mentre erano ancora in programma trattative sul programma nucleare iraniano fra Teheran e Washington.
Dietro il rischio di un’escalation nel Golfo Persico incombe sempre l’ombra dei rapporti con la Russia, che da anni è un alleato dell’Iran, così come la Cina. La Casa Bianca rischia nel rendere più difficile quella normalizzazione di rapporti col Cremlino in un momento così delicato. Vero è che il presidente Vladimir Putin, pur condannando l’offensiva contro l’Iran, è stato, almeno finora, relativamente cauto. Gli americani hanno attaccato i centri nucleari iraniani con sei bombardieri pesanti Northrop B-2 Spirit decollati direttamente dalla loro base di Whiteman, nel Missouri, e giunti sull’Iran dopo ripetuti rifornimenti in volo che, dalle prime indiscrezioni, sarebbero avvenute nell’Atlantico a nord della Azzorre, sopra Spagna o Grecia e sopra il Medio Oriente.

Hanno sganciato sulle installazioni sotterranee di Fordow un totale di 12 bombe ad alta penetrazione GBU-57 MOP, cioè due da ogni aereo, mentre gli altri obbiettivi sono stati colpiti da salve di 30 missili da crociera Tomahawk sparati da sottomarini della US Navy. L’Iran ha poi dichiarato che il sito di Fordow non avrebbe subito gravi danni e che, soprattutto, l’uranio già arricchito era stato messo al sicuro in precedenza in luoghi segreti, forse con lo stesso aiuto russo. L’operazione americana era stata preparata il 21 giugno con lo spostamento, a scopo di inganno, di altri B-2 Spirit sulla base Andersen dell’isola di Guam, per dare a intendere un possibile attacco all’Iran proveniente da Est, dalla rotta sull’Oceano Indiano, anziché da Ovest.
Fra le reazioni internazionali, quelle più attese sono da parte della Russia, che, se da un lato può consolarsi almeno sperando che una simile guerra nel Golfo possa far passare in secondo piano la guerra in Ucraina, talché l’Occidente abbia ben più da preoccuparsi di petrolio e gas che dei destini di Kiev, dall’altro non approva il martellamento senza sosta dell’amico Iran. Il 22 giugno l’agenzia russa Novosti ha diffuso un’intervista in cui il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov s’è espresso molto chiaramente: “Se ogni Paese è autorizzato ad interpretare il diritto all’autodifesa, previsto dalla Carta dell’Onu, in modo tale da dire, ‘decido per conto mio quando usare il mio diritto’, allora non ci sarà più un ordine mondiale, ma il caos completo”.

Va anche tenuto conto del fatto che Mosca, anche negli ultimi tempi, ha sempre cercato di non scontrarsi frontalmente con Israele, adottando una linea cauta dettata anche dall’imprevedibilità dello stato ebraico, che del resto dispone di un arsenale nucleare cospicuo, stimato fra 90 e 200 testate, forse di più, anche con vettori a lungo raggio come i missili Gerico 3 che tengono sotto tiro la maggior parte dei continenti abitati.
L’unica cosa certa, in questo caos, è che le classi dirigenti dei paesi dell’Unione Europea si sono confermate totalmente imprevidente e precipitose nel rigettare dopo il 2022 le forniture di gas e petrolio dalla Russia, sull’onda emotiva della guerra in Ucraina, per aumentare semplicemente la loro dipendenza dagli idrocarburi di un Medio Oriente che sta per esplodere, con in più la possibile aggravante di un blocco dello stretto di Hormuz al passaggio in oceano aperto delle petroliere salpate dal Golfo Persico, che portano almeno il 20 % del greggio mondiale.
Mal ne incolga agli europei, che del resto sono condannati a rimanere al margine mentre i destini del loro continente verranno, come sempre dal 1945 a oggi, decisi da Stati Uniti e Russia. E’ per questo che il nocciolo della stabilità mondiale passa ancora dalla linea rossa Mosca-Washington, e lo sanno benissimo anche gli americani.

Non deve stupire che il 12 giugno 2025 il segretario di Stato americano Marco Rubio abbia indirizzato un messaggio di “auguri al popolo russo in occasione della Giornata della Russia”, ovvero la festa nazionale che ricorda la prima autoproclamazione di “sovranità statale” della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, sotto la presidenza di Boris Eltsin ancora nell’ambito della moribonda URSS il 12 giugno 1990, divenuta festa nazionale dal 1992, una volta scioltasi definitivamente l’Unione Sovietica. Rubio ha chiosato: “Cogliamo l’occasione per riaffermare la volontà degli Stati Uniti di collaborare in modo costruttivo con la Federazione Russa per arrivare a una pace duratura tra Russia e Ucraina. Ci auguriamo che la pace favorisca relazioni più vantaggiose tra i nostri due Paesi”.
E’ il sintomo della volontà di normalizzazione dei rapporti fra le due massime potenze nucleari, che l’amministrazione di Donald Trump ha posto come priorità, mettendo in secondo piano il sostegno all’Ucraina.
Un paio di giorni dopo, il 14 giugno, proprio mentre iniziava la nuova guerra, stavolta diretta, fra Israele e Iran, Trump ha ricevuto la telefonata del presidente russo Vladimir Putin, col pretesto ufficiale degli auguri di compleanno per i 79 anni del presidente statunitense, ma chiaramente legata ai pesanti dossier sul tavolo. Il colloquio è durato 50 minuti e, a detta di Trump, non si è parlato moltissimo della specifica questione della guerra in Ucraina, sebbene sia stato confermato che si procede con gli scambi di prigionieri e che Putin si è detto “disponibile a nuove trattative con Kiev dopo il 22 giugno”.
Era chiaro che il senso della conversazione era soprattutto il proseguire il riavvicinamento Mosca-Washington. Nella comune preoccupazione per l’esplodere delle ostilità fra Israele e Iran, comunque, Putin, vicino al regime di Teheran tanto da averne importato i famosi droni Shahed, pure prodotti su licenza ad Alabuga, nel Tatarstan, utilizzati in massa contro gli ucraini, ha espresso la disponibilità a tentare di mediare fra il premier ebraico Benjamin Netanyahu e gli ayatollah. Opera che però al momento sembra improbabile.

La svolta epocale, rispetto alla precedente amministrazione di Joe Biden, è stata colta appieno da Mosca, dove, pur guardinghi si tende timidamente la mano.
Così, ad esempio, sull’onda delle ricorrenze per il traguardo dei 25 anni di potere del presidente Vladimir Putin alla guida della Russia sono stati diffusi il 18 maggio 2025 dai media di Mosca ampi stralci di un’intervista a tutto campo in cui lo “zar” ha tirato le fila dei principali nodi della trama strategica in cui è imbrigliato il paese.
Ha affrontato direttamente il tema della cosiddetta “operazione militare speciale” ovvero la guerra in Ucraina declinata secondo il vocabolario del Cremlino, facendo capire che le truppe di Mosca non deporranno le armi finché necessario, non avendo problemi di lungo periodo data la mobilitazione dell’economia russa in funzione dello sforzo bellico: “Abbiamo forze e mezzi sufficienti per portare a termine ciò che è stato avviato nel 2022 con il risultato di cui la Russia ha bisogno.
E questo risultato sta eliminando le cause di questa crisi, creando le condizioni per una pace duratura e garantendo la sicurezza dello Stato russo”. E’ sempre ribadito, da Putin come da tutto il governo russo, che quella ucraina non è una questione a sé stante, avulsa da un contesto più ampio, talché semplicisticamente se ne possa addossare l’intera responsabilità a chi ha aperto il fuoco nel febbraio 2022, bensì un sintomo di una generale insicurezza strategica del mastodontico paese-continente che occupa l’Eurasia Settentrionale.
Ecco perché Putin rimarca che “vogliamo eliminare le cause del conflitto” e prosegue: “Vogliamo salvaguardare gli interessi del nostro popolo nei territori di cui abbiamo sempre parlato, quelli i cui abitanti considerano il russo la loro lingua madre e la Russia la loro patria”.
E’, in poche frasi, la ricapitolazione di ciò che Mosca, come centro di un sistema imperiale sostanzialmente coerente nei secoli, come interessi geopolitici, nonostante il trapasso fra l’epoca zarista e quella sovietica, ha dovuto subire, per gradi, a partire dallo scioglimento dell’Unione Sovietica nel dicembre 1991. Ovvero anzitutto l’instabilità del proverbiale “estero vicino”, la cintura limitrofa di stati ex-sovietici, fra cui l’Ucraina, ospitanti grosse minoranze russe e russofone, poi l’avanzata verso Oriente dei confini della NATO, che ha inglobato anche alcuni di questi stati ex-sovietici, quelli baltici, e che potenzialmente avrebbe potuto aggiungere alla lista l’Ucraina e la Georgia.
Inoltre la crisi di alcuni sistemi di sicurezza internazionale, ereditati dalla Guerra Fredda, in particolare nel campo del controllo degli armamenti strategici, specialmente l’uscita unilaterale degli Stati Uniti nel 2002 dal trattato ABM, che limitava le difese antimissile garantendo un effetto di deterrenza, e nel 2019 dal trattato INF, che vietava i missili a raggio medio e intermedio in Europa (gli “euromissili” come li avevano battezzati stampa e telegiornali negli anni Ottanta).
Per giunta, oltre alle interferenze occidentali per mezzo delle varie “rivoluzioni colorate” in alcune di queste nazioni cuscinetto, i tentativi dei russi di difendere un proprio perimetro di sicurezza egemonico, come la guerra in Georgia del 2008 e più tardi nel 2014, in conseguenza della rivolta di piazza Maidan a Kiev, l’appoggio ai ribelli filorussi del Donbass e l’annessione unilaterale della Crimea, sono stati aprioristicamente criminalizzati, portando fin da allora alle prime sanzioni e all’espulsione della Russia dal G8 (ritornato G7, come era stato fino al 1998) fingendo di ignorarne le profonde cause.
E ciò nonostante Putin stesso avesse lanciato un ben preciso avvertimento fin dalla Conferenza per la Sicurezza di Monaco del 2007.
Ora, invece, la svolta sovranista di Trump, rispetto alla precedente amministrazione USA “dem-liberal” di Joe Biden, ha convinto il presidente russo che, almeno in parte, si può tornare a trattare con Washington su un piano di parità, facendo balenare la convenienza che avrebbero anche gli americani a una sorta di compromesso tra potenze egemoni.
Ecco perché Putin, proseguendo nella citata intervista, ha anche fatto riferimento a una reciprocità di interessi: “Gli americani, il popolo americano e la leadership americana, compreso il presidente, hanno i propri interessi nazionali. E noi li trattiamo con rispetto, dando per scontato che saremo trattati allo stesso modo”.

Da gennaio 2025, dal suo insediamento, Trump ha apertamente espresso rivendicazioni territoriali sulla Groenlandia, il che lo porrebbe in diretto contrasto con l’Unione Europea, su Panama e perfino sul Canada. Una presa d’atto, da parte del leader statunitense, del fatto che la guerra russo-ucraina segna di fatto il ritorno del pragmatismo geopolitico che ha sempre segnato le relazioni internazionali e del fatto che, dopotutto, la forza conta.
Quasi un ritorno alla politica del “big stick” del suo illustre predecessore Theodore “Teddy” Roosevelt, a capo della Casa Bianca dal 1901 al 1909. Alla faccia dei legalismi propugnati in sede ONU e UE, a cui lo stesso Trump sembra piuttosto insofferente, e che sempre più spesso faticano ad affrontare il risorgere, per così dire, della Storia come sempre è stata.
Fra imperi ci si intende, insomma, a patto che ognuno dei due non oltrepassi certe linee rosse. Ecco perché Putin si richiama al rispetto degli interessi reciproci cercando di fatto, anche se non ufficialmente, una complicità con Trump.
Del resto, lo scorso 3 giugno indiscrezioni del giornale americano “Politico” hanno dato a intendere che gli Stati Uniti si apprestino, in tempi brevi, a “spostare” la Groenlandia dalla sfera di competenza dell’US European Command, il comando europeo delle forze armate statunitensi, a quella dell’US Northern Command, il comando metropolitano relativo al Nordamerica.

In pratica significherebbe che il Pentagono considera di fatto la Groenlandia già “annessa” agli Stati Uniti o comunque più pertinente allo scacchiere del Nordamerica che a quello europeo, nonostante l’isola sia sotto la sovranità della Danimarca, ma rivendicata da Trump come avamposto militare utile specialmente per la difesa antimissile, oltre che per monitorare le acque e lo spazio aereo dell’Artico.
Questa iniziativa, osserva “Politico” faciliterebbe l’integrazione della base radar spaziale di Pituffik (ex-base di Thule, nel Nord della Groenlandia) nel sistema di scudo antimissile nordamericano Golden Dome annunciato come protezione futura da tutti gli ordigni, balistici, spaziali o ipersonici sviluppati dalle potenze avversarie.
Che il bastione artico sia rivolto ovviamente verso la Russia, comunque, nulla toglie alla percepita necessità di trovare un modus vivendi con Mosca. E in ciò l’attuale amministrazione americana è conscia del fatto che una maggiore sicurezza comporta una saggia miscela di precauzioni militari e di aperture diplomatiche.
Telefonata amichevole
Il giorno dopo l’intervista a Putin, il 19 maggio, è andata in scena la lunga telefonata diretta tra i presidenti americano e russo, che non ha portato finora a passi concreti nella risoluzione del conflitto russo-ucraino, ma probabilmente perché non era questo, in verità, il suo scopo principale.
E’ vero che il miliardario-presidente aveva in precedenza sentito anche il collega ucraino Volodymir Zelensky, ma la conferma della sua accondiscendenza verso il capo del Cremlino sembra data dal fatto che Washington ha avvallato la proposta russa di un memorandum che cerchi di conciliare le proposte russe e quelle ucraina, prima di giungere a un cessate il fuoco.
Tutto l’inverso di ciò che ha sempre chiesto Kiev, cioè una tregua di almeno 30 giorni come presupposto, e non conseguenza, di negoziati. Al termine delle circa 2 ore e mezza di colloquio telefonico, Trump ha riassunto: “Penso sia andata molto bene. La Russia e l’Ucraina inizieranno immediatamente le trattative verso un cessate il fuoco e, ancora più importante, per la fine della guerra”.
E ha poi spiegato: “Ho chiesto a Putin: ‘Quando la finiremo con questo spargimento si sangue, con questo bagno di sangue?. E’ un bagno di sangue e credo che lui voglia concluderlo”.
E riandando a quanto aveva dichiarato anche nei giorni precedenti, “Vi dirò, ci sono dei grossi ego coinvolti ma credo che qualcosa accadrà. E, se non accadrà, mi sfilerò e loro dovranno andare avanti”.
Ancora una volta, ecco il segnale trumpiano che la contesa Mosca-Kiev è ritenuta un sottoprodotto secondario di una concorrenza geopolitica fra russi e americani che egli intende risolvere preparando, col tempo, un attesissimo faccia a faccia. E che Zelensky è solo un comprimario relativo a un settore limitato della scacchiera globale.

All’amministrazione attualmente insediata alla Casa Bianca interessa certo poter spegnere il focolaio ucraino, ma partendo dal presupposto, pragmatico, che lo scopo principale deve essere smorzare la tensione USA-Russia che nella stagione di Joe Biden era montata a livelli ormai intollerabili.
Pertanto a “The Donald” è in sostanza andato bene quanto riferito da Putin sulla telefonata: “La Russia e l’Ucraina devono dimostrare la massima volontà di arrivare alla pace e trovare quei compromessi che vadano bene a entrambe le parti. La Russia proporrà ed è pronta a collaborare con la parte ucraina su un memorandum riguardante un possibile futuro trattato di pace, definendo diverse posizioni. Come, ad esempio, i principi di risoluzione, la tempistica di un possibile accordo di pace e così via, incluso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo qualora vengano raggiunti gli accordi pertinenti”.
Che Mosca possa fare, relativamente, con suo comodo, lo ha precisato il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov: “Non c’è una scadenza e non può essercene una. È chiaro che tutti vogliono farlo il più rapidamente possibile, ma il diavolo si nasconde nei dettagli, ovviamente. Sia la Russia che l’Ucraina redigeranno i loro progetti. Le parti si scambieranno queste proposte. Poi, si impegneranno in contatti complessi per elaborare un testo unico”.
E il 20 maggio ha aggiunto: “Sono in corso contatti tra russi e ucraini i contatti sono stati effettivamente ristabiliti, il che è molto importante in questa fase”. Il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha inoltre previsto “in futuro un incontro diretto Trump-Putin che dovrà essere preparato con cura”.
Dal canto suo, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha affermato nelle stesse ore che “stiamo attendendo le condizioni dei russi”, che pure sono già di fatto note e contemplano soprattutto il divieto all’Ucraina di entrare nella NATO e il riconoscimento dell’annessione non solo della Crimea, ma anche delle regioni del Sudest ucraino che fin da settembre 2022, sull’onda dell’avanzata iniziale, i russi hanno considerato proprie per diritto di conquista, ovvero Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, per quanto ancora non integralmente occupate al momento attuale.
Il futuro incontro faccia a faccia Trump-Putin presumibilmente verterà assai più sui rispettivi rapporti di forza che sull’Ucraina in quanto tale, il cui fronte di guerra ipoteticamente congelato come nuova frontiera verrà considerato valido in senso strumentale al ristabilire un modus vivendi fra le due potenze.

Già il 15 maggio il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov aveva fatto presente che “un potenziale incontro Trump-Putin non è legato ai colloqui di pace in Ucraina”.
In tal senso, l’accordo sui giacimenti minerari siglato fra ucraini e americani lo scorso 1° maggio, e definito frettolosamente “delle terre rare”, anche se riguarda uranio, titanio, ferro, carbone, litio, petrolio, gas, e ben poco, come lo scandio, di quei 17 metalli rari vitali per l’industria elettronica, pare una misura voluta da Washington per indorare a Kiev la pillola di un compromesso in gestazione, ancora da definire, ma che rappresenterà la più realistica conclusione del conflitto, a meno che non si voglia calcare la mano sull’escalation.
E’ anche vero che nelle ultime settimane, di fronte all’intransigenza di entrambe le parti, più giustificata per la verità da parte russa per il semplice bilancio della situazione militare, che da a Mosca una posizione oggettivamente più forte, ha fatto dire più volte al presidente statunitense che l’America potrebbe lavarsene le mani.
Se il 15 maggio, mentre delegati russi e ucraini s’apprestavano a incontrarsi a Istanbul per quello che è rimasto un primo approccio, Trump aveva detto che “non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”, il 20 maggio ha invece chiosato: “Ci sono dei grossi ego coinvolti, ma credo che qualcosa accadrà. E, se non accadrà, mi sfilerò e loro dovranno andare avanti”.
S’è anche mostrato freddo di fronte all’ipotesi di nuove sanzioni alla Russia, sulla scia del 17° pacchetto appena approvato dall’Unione Europea. Affermazioni corroborate da un articolo uscito lo stesso giorno sul New York Times, che sulla base di confidenze di “sei funzionari governativi” ha scritto che di fatto il presidente americano avrebbe già deciso di tirarsi fuori dalla questione ucraina pur di conseguire la normalizzazione dei rapporti, anche commerciali, fra Stati Uniti e Russia.
La svolta trumpiana ha segnato una frattura con quegli alleati europei, eccetto l’Italia, che seguitano a parlare di un possibile schieramento di “truppe di pace” UE in Ucraina, senza riflettere sul fatto che dei veri peacekeepers dovrebbero essere rappresentanti di paesi neutrali, il che non si può dire della maggior parte delle nazioni d’Europa, che hanno fornito a Kiev armi e munizioni.
E’ il paradosso dei cosiddetti “volenterosi”, capeggiati da Francia, Gran Bretagna e Germania, ma a cui l’Italia, saggiamente, ha evitato di accodarsi. A “pompare” Kiev è insomma l’Unione Europea, che spiazzata dalle iniziative americane tenta di imporsi con un’irrealistica intransigenza, tanto che la l’Alto commissario UE agli Esteri, Kaja Kallas ha ribadito a inizio maggio che “nessun paese UE riconoscerà mai la Crimea territorio russo”.
L’UE vuole inoltre “una vittoria totale per Kiev” lontanissima dalla realtà. Brucia, alle classi dirigenti del continente europeo, o almeno a gran parte di esse, l’essersi allineate per tre anni alle direttive della precedente amministrazione americana, quella di Biden, per poi ritrovarsi, con Trump alla Casa Bianca, nella difficile posizione, di fronte alle proprie opinioni pubbliche, di non poter fare retromarcia, per non far pensare a una sudditanza, e ostentare una sovranità che di fatto resta strategicamente limitata, dato che è l’America che seguita a essere il fulcro della NATO.
Per rafforzare l’assertività europea si sono susseguite mosse a effetto, come l’annuncio da parte del nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz che il 27 maggio ha aperto alla consegna all’Ucraina dei missili da crociera avio-lanciati Taurus (nella foto sotto) KEPD-350, prodotti in collaborazione dal ramo tedesco della MBDA e dalla svedese SAAB e finora negati dal suo predecessore Olaf Scholz.

Armi, i Taurus, con 500 chilometri di gittata, della stessa classe dei similari SCALP/Storm Shadow già forniti a partire dal 2023 da Francia e Gran Bretagna, ma che verosimilmente non potranno cambiare la bilancia generale del conflitto, anzitutto per la loro prevedibile esiguità numerica, costando quasi 1 milione di euro ciascuno, e probabilmente disponibili nell’ordine delle decine o di un centinaio, laddove invece, per compromettere gravemente le retrovie russe a ridosso dell’Ucraina, sarebbe necessario lanciarne a massa nell’ordine dei 500 alla settimana!
Ciò fa ulteriormente capire come il sostegno europeo a Kiev, al netto delle migliori intenzioni, sia condannato da un’insufficienza materiale ed economica a monte del processo e venga in pratica sopravvalutato per questioni di immagine politica.
La posta in gioco
Ora, le crescenti aperture americane nei confronti della Russia, all’insegna della volontà di normalizzazione, condita dalla prospettiva di comuni affari economici, come intuibile dalla ventilata partecipazione di aziende americane alla riattivazione dei gasdotti baltici North Stream e dalla dichiarata disponibilità di Mosca a fornire proprie “terre rare”, queste sì, in senso letterale, ai colossi informatici USA della Silicon Valley, hanno fatto per certi aspetti pensare a una sorta di nascente “alleanza” Mosca-Washington diretta a tenere l’Europa soggiogata. Impressione rafforzata dalla contesa USA-UE sui dazi, non ultime le affermazioni di Trump del 23 maggio relative a tariffe del 50% sui prodotti europei in ingresso in America a partire da giugno, che hanno anche causato perturbazioni sui mercati finanziari.
E’ qualcosa che ricorda vagamente gli schieramenti della Seconda Guerra Mondiale e che rimanda al pensiero di uno dei geopolitici statunitensi più influenti. Parliamo di Nicholas Spykman, che in piena guerra diede sostanza formale al problema strategico degli USA che si trovavano a fronteggiare la minaccia del Patto Tripartito fra Germania, Italia e Giappone.

Egli elaborò la base della strategia del “contenimento” nei suoi libri “America’s Strategy in the World Politics”, del 1942, e “The Geography of Peace”, uscito postumo nel 1944, a cura della sua allieva Helen Nicoll, essendo l’autore morto prematuramente di cancro il 26 giugno 1943, a 50 anni non ancora compiuti.
Il suo pensiero costituì la logica evoluzione della precedente dottrina Monroe, che fin dal 1823 caratterizzava l’approccio degli Stati Uniti al mondo esterno, identificando la propria area egemonica nel Nuovo Mondo e lanciando ammonimenti alle potenze del Vecchio Mondo affinché se ne stessero alla larga.
Nell’aprile 1917 l’intervento americano nella Prima Guerra Mondiale costituì già un preavviso del mutamento futuro, dato che la classe dirigente di Washington, e in particolare l’allora presidente Woodrow Wilson, iniziarono a pensare che per garantire la sicurezza degli Stati Uniti, per svariate ragioni, dai crediti con le nazioni dell’Intesa alla guerra sottomarina indiscriminata tedesca al telegramma Zimmermann che ventilava un’alleanza Germania-Messico, si doveva contribuire attivamente in Europa alla conclusione del conflitto. L’intrusione americana nella politica europea fu però allora percepita come un episodio eccezionale, tanto che gli Stati Uniti affiancarono l’Intesa come “potenza associata” senza aderirvi e che dal 1920 si richiusero nell’isolazionismo non entrando nemmeno nella Società delle Nazioni che pure era farina del sacco di Wilson.
Quando però, dopo vent’anni, Europa e Asia Orientale tornarono epicentro di una tempesta pericolosa anche per gli Stati Uniti, a Washington si capì che stavolta l’impegno oltremare avrebbe dovuto essere molto duraturo, nell’ottica, di fatto, di una sorta di “difesa avanzata” del Nordamerica.
Nel 1942 Spykman diede così corpo logico a queste istanze. Egli notò che l’emisfero delle due Americhe è “circondato” dal Vecchio Mondo da tre lati, ovvero da Est, cioè dalle coste dell’Europa Occidentale e dell’Africa, da Ovest ossia dall’Asia Orientale, e infine da Nord, ovvero dall’Eurasia artica.
Arguì che per gli USA la sicurezza derivasse dalla garanzia che nessun pericolo arrivasse da quelle coste.
Era la fascia peninsulare eurasiatica, quella che il geopolitico scozzese Halford Mackinder, nel 1904, aveva chiamato “Inner Crescent”, “Mezzaluna Interna”, ma che Spykman ribattezzò “Rimland”, “Terra Margine”. Per Spykman era il Rimland, e non l’Heartland continentale, invulnerabile agli attacchi anfibi, occupato dalla Russia, il maggior pericolo per le potenze marittime anglosassoni, ribaltando la prospettiva di Mackinder. Nella Seconda Guerra Mondiale, di cui lo studioso non vide la fine, l’Heartland/URSS era alleato degli anglo-americani nell’impedire a Germania e Giappone di controllare il Rimland.
Dal 1945, con l’Armata Rossa occupante l’Europa Orientale, nonché con l’avanzata dei comunisti in Cina, sorse il rischio che il blocco sovietico controllasse penisole e isole dell’Eurasia, usandole come ponte per gli oceani. Ma il blocco comunista s’incrinò nel 1960 con la frattura URSS-Cina, che spinse infine gli Stati Uniti ad allearsi di fatto con la Cina di Mao Zedong nel 1972 per rinchiudere i sovietici nel loro spazio.
Dopo il 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’indebolimento della Russia, per gli Stati Uniti tornò cruciale impedire che Russia e Unione Europea costituissero un unico blocco eurasiatico con accesso illimitato all’Oceano Atlantico. Se per decenni avevano prevalso direttive prettamente mackinderiane, gli eventi degli ultimi anni sembrano aver portato l’amministrazione Trump a rispolverare, almeno in parte, il verbo di Spykman, adattandolo alla situazione attuale.
Si tratta di condizionare l’Unione Europea, tenendola subordinata agli Stati Uniti e cercando di evitare una possibile sua comunanza di interessi con la Cina. Ma anche di cercare di allontanare la Russia dalla Cina offrendo un compromesso, sulla base dei reciproci interessi già evocati da Putin, che assicuri a Mosca e Washington sufficienti garanzie bilaterali.
E’ come se gli Stati Uniti vogliano, in sostanza, riposizionarsi in modo equidistante (o quasi), fra Europa e Russia, da un lato per impedire la saldatura fra Mosca e il Rimland occidentale, dall’altro “usare”, per così dire, la Russia come spauracchio (più o meno consapevole) per mantenere la centralità degli USA in ambito NATO con propositi di difesa comune, ma anche, velatamente, di controllo americano sulle nazioni dell’Europa Occidentale affinché non vengano tentate da una strada strategica indipendente da quella statunitense, il che, unita alla concorrenza commerciale già esistente con l’UE, potrebbe portare a crescenti conflitti Europa-America.

E’ anche in tale ottica che si segnalano le ripetute rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia, il cui controllo, come avamposto USA, era raccomandato già da Spykman.
Più netta e chiara è invece la situazione in Asia, dove il Rimland è in gran parte da tempo aggiogato agli Stati Uniti tramite le alleanze con gli stati insulari e peninsulari, per esempio Giappone, Corea del Sud o Taiwan, che fanno da catenaccio nei confronti della Cina, non più utile alleato di Washington dopo la fine del pericolo sovietico, la cui espansione verso il Pacifico rappresenta la proiezione di quella parte di Rimland asiatico (come anche la Corea del Nord) rimasto concorrente dell’America.
Una fragile bilancia
Il faro della nuova politica statunitense, in omaggio allo slogan “MAGA”, Make America Great Again, della squadra di Trump, sembra quindi il prolungare l’egemonia globale USA, iniziata nel 1945, ponendosi al centro del mondo, come del resto Spykman stesso aveva posto l’America “accerchiata” dall’avvolgimento geografico del Vecchio Mondo, e tenendo a bada, dividendoli, i possibili avversari alternando con ciascuno bastone e carota in una pletora di azioni e reazioni bilaterali condotte per “linee interne”.
In una prospettiva del genere anche l’Unione Europea, almeno sul versante economico-produttivo, vede accresciuto il suo ruolo di concorrente degli Stati Uniti. Ecco perché il cercare di fatto un’equidistanza fra Mosca e l’asse Kiev-UE si configura per Washington come un “giocare” russi contro europei da una posizione d forza proponendosi come arbitro supremo. Con lo scopo nemmeno secondario di far balenare a Mosca un compromesso che la sottragga almeno in parte all’influenza di Pechino.
Il gioco di Trump lo si nota bene osservando come egli dispensi stoccate ben calcolate a entrambe le parti. Fra le occasioni più recenti, il 26 maggio il presidente statunitense ha reagito ai mugugni di Zelensky, che poche ore prima si era lamentato del “silenzio USA” sul fatto che i russi proseguono l’offensiva. Trump, da un lato ha apparentemente accontentato il presidente ucraino ammonendo il russo: “Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa.
È completamente impazzito. Ho sempre detto che voleva tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta della Russia”.

Asserendo che Putin vuole tutta l’Ucraina, tuttavia, illazione a tutt’oggi non provata né rivendicata dai russi, Trump alza unilateralmente l’asta del negoziato perché poi, se la Russia si dovesse accontentare, delle dichiarate regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, potrebbe presentare un successo diplomatico nell’averne moderato gli appetiti. Il rischio di “caduta della Russia”, tuttavia, ha il sapore della dialettica, perché è assai più facile che sia l’Ucraina, più piccola, con meno risorse e dall’intero territorio sotto tiro, a crollare di schianto, che non l’inverso.
Ma Trump ne ha avute anche per il presidente ucraino, poiché in sostanza gli ha intimato di tapparsi la bocca: “Il presidente Zelensky non sta facendo un favore al suo Paese parlando in quel modo. Tutto ciò che esce dalla sua bocca causa problemi, non mi piace, ed è meglio che la smetta”.
E poi, per rimarcare l’equidistanza, Trump ha rammentato: “Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. E’ la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di ‘Trump’. Io sto solo cercando di spegnere gli orribili incendi appiccati da una grave incompetenza e dall’odio”.
La Casa Bianca e il Congresso sanno che la normalizzazione dei rapporti fra Stati Uniti e Russia urge, poiché il pericolo di uno scontro non è scongiurato e resterà alto, forse tornando a crescere, man mano che la guerra in Ucraina continuerà e che molti alleati della NATO terranno alta la tensione.

Il 14 maggio, il generale Gregory Guillot, comandante dell’US Northern Command e del North American Aerospace Defense Command (NORAD), quindi particolarmente concentrato sui temi della difesa del continente nordamericano, ha fatto alla Commissione Forze armate del Senato USA un rapporto di questo tenore: “Ci sono diverse strade plausibili con cui la guerra russo-ucraina potrebbe degenerare in un conflitto diretto con gli Stati Uniti”.
Perciò gli Stati Uniti hanno proposto di riprendere i contatti con Mosca tramite il consiglio NATO-Russia. Il che sarebbe utile per cercare di sganciare la Russia dagli altri avversari dell’America. Guillot ha anche rilevato che i “continui rischi di escalation con la Cina nello stretto di Taiwan condizioneranno almeno una generazione” e che “nel complesso, anche se Cina, Russia, Iran e Nord Corea non vogliono uno scontro militare con l’America, essi potrebbero tentare di capitalizzare la sensazione di decadenza dell’Occidente e sfidare la potenza USA, il che può portare a errori di valutazione”.
La relazione del comandante del NORAD è arrivata proprio mentre russi e ucraini si accingevano a inviare rispettive delegazioni a Istanbul per il primo, stentato, approccio del 16 maggio, che per il momento ha portato solo all’avvenuto scambio di 1000 prigionieri per parte, avvenuto a scaglioni tra 23 e 25 maggio. Ancora lontana è la “quadra” che Russia e Ucraina dovrebbero cercare con la ventilata bozza di un memorandum comune e del resto Trump aveva già ammesso nei giorni di Istanbul che “solo io e Putin possiamo risolvere il problema”.
Dal canto suo, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha invitato, il 23 maggio, a non illudersi che le aperture trumpiane stiano risolvendo i problemi fra Mosca e Washington, per quanto siano un segnale incoraggiante.
“E’ cruciale – ha osservato il capo della diplomazia russa – non soccombere alle illusioni, restare realistici e rendersi conto che ci sono state numerosi esempi che hanno visto gli Stati Uniti invertire drasticamente la loro posizione”. Rievocando il vertice con il segretario di Stato americano Marco Rubio a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2025, Lavrov ha riconosciuto che con quell’iniziativa s’è avviato un percorso di normalizzazione, che vede gli Stati Uniti, oggi, diversamente dalla stagione di Biden, concedere che anche la Russia abbia i suoi legittimi interessi nazionali.

E pur descrivendo il quadro attuale come “un ritorno alla normalità”, avverte che la cautela è d’obbligo, dati i nodi in sospeso, specie negli equilibri in fatto di armamenti strategici.
E’ per questo che l’improvviso raid di droni ucraini, partiti da camion introdotti clandestinamente in territorio russo dal servizio segreto ucraino SBU, su quattro basi dell’aviazione strategica russa, il 1° giugno, ha suscitato l’ira del presidente americano, che ha lamentato di non essere stato avvertito da Kiev, mentre è probabile ne fossero a conoscenza, fornendo appoggio, altri alleati, come la Gran Bretagna.
Anche se la portata degli attacchi dei droni ai bombardieri Tupolev Tu-95 e Tu-22M3 parcheggiati sulle piste di Belaya, Dyagilevo, Ivanovo Severny e Olenya è stata ridimensionata, dagli iniziali “41 bombardieri distrutti”, secondo Kiev, a probabilmente 10-13 fra danneggiati e distrutti, che gli ucraini abbiano colpito una parte del deterrente nucleare russo, nel senso dei vettori aerei a lungo raggio, interferendo con una materia regolata direttamente fra Mosca e Washington con il trattato New START non può che aver aumentato l’irritazione della Casa Bianca.
In particolare, secondo The Atlantic, da fonti identificate in tre funzionari dell’amministrazione e un consigliere esterno della Casa Bianca, “dopo l’attacco di domenica, che ha colpito una serie di aeroporti militari russi, il presidente Trump ha espresso privatamente la sua frustrazione per il fatto che l’attacco potrebbe aggravare il conflitto”.
E poi: “Trump ha definito Zelensky un cattivo soggetto e una testa calda, ha affermato il consigliere esterno, qualcuno che potrebbe spingere il mondo verso la Terza Guerra Mondiale”. Intanto, il 4 giugno, un analista americano, l’ex-ufficiale della US Navy Jack Posobiec, ha ipotizzato che nell’attacco dei droni ucraini alle basi dei bombardieri russi abbia avuto un ruolo anche la passata amministrazione Biden, se è vero che la complessa operazione è stata preparata a partire da un anno e mezzo fa, e che sia in qualche modo implicato il quartier generale americano di Wiesbaden, in Germania, nel definirne gli obbiettivi.
Quando poi, fra 6 e 7 giugno, è giunta una prima potente ritorsione russa per le incursioni sulle basi strategiche, il presidente USA ha subito commentato: “Spero la guerra non diventi nucleare”.
Giungendo a essere comprensivo, quasi a scusare, i raid di droni e missili russi su Kiev come la ritorsione comprensibile di una grande potenza: “Gli ucraini hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto (il raid di droni ucraini sulle basi di bombardieri russi, n.d.r.) ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”. Come dire che, se fosse stato neo panni di Putin, avrebbe fatto lo stesso.
La panoplia della tensione
In data 24 maggio 2025 il portavoce dell’Aeronautica ucraina, Yuriy Inhat, segnalava come i russi, sulla base delle esperienze tattiche maturate nel conflitto, abbiano recentemente migliorato la dinamica di volo dei missili balistici a corto raggio Iskander-M rendendone più difficile l’intercettazione da parte dei missili antiaerei di fattura occidentale, specialmente i Patriot americani, consegnati a Kiev.

“Abbiamo informazioni secondo cui i balistici nemici Iskander-M sono stati modernizzati. Ogni missile rilascia ora esche-radar nella fase finale della traiettoria. Si tratta di abbattere le esche-radar, che ogni missile rilascia all’avvicinamento al bersaglio. Di conseguenza, i Patriot, potrebbero non funzionare con la stessa efficacia”.
Inhat ha inoltre aggiunto che una difficoltà aggiuntiva è che gli Iskander-M manovrano mettendo in difficoltà i sistemi Patriot nel calcolo della traiettoria del missile da colpire.
Questo è solo un esempio di come l’allarme per le ricadute del conflitto ucraino sul miglioramento della panoplia russa, specialmente missilistica, induca gli Stati Uniti a essere sempre cauti nelle aperture verso la Russia, interpretandole soprattutto come un percorso per arrivare ad assetti stabili che smorzino la tensione sul teatro europeo in modo da evitare il rischio di futuri ingaggi su due fronti, contando la perdurante crisi con la Cina per Taiwan e il Pacifico.
La storia della crescente spaccatura fra USA e Russia negli equilibri fra gli armamenti potenziali vettori di ordigni nucleari è ben nota.

Per ricapitolarla brevemente, anzitutto nel 2002 gli americani, allora sotto la presidenza di Gerorge Walker Bush, si ritirarono unilateralmente dal trattato ABM che fin dal 1972 limitava le reciproche difese antimissile per assicurare una cospicua deterrenza ed evitare che una delle parti cadesse nell’illusione di poter attaccare impunemente l’avversario contando su uno “scudo spaziale”. Decaduto il trattato ABM, anche i russi si ritennero liberi di sviluppare i propri sistemi antimissile senza limiti, oltre ai mezzi per neutralizzare quelli americani, rivelati da Putin a partire dal 2018.
Dai sistemi di bombardamento orbitale frazionato, con testate che, portate ad esempio dall’intercontinentale RS-28 Sarmat, aggirano la Terra con un’orbita parziale, al missile a motore nucleare Burevestnik, capace di attaccare da direzioni inaspettate dopo giorni di volo, fino al sottomarino-drone Status-6 Poseidon, la cui esplosione termonucleare presso le coste USA potrebbe devastare vasti tratti di litorale con uno tsunami.
Sul versante di quelli che negli anni Ottanta erano chiamati “euromissili”, vietati dal trattato INF del 1987, per la fascia di raggio medio e intermedio da 500 a 5500 km, la diffidenza crebbe fin dall’epoca di Barack Obama, con i progetti annunciati nel 2014 per le basi americane dell’Aegis Ashore, la difesa antimissile Aegis sulla terraferma europea, da situarsi a Deveselu, in Romania, e a Redzikowo, in Polonia.
Basi infine divenute operative nel 2016, Deveselu, e nel 2024, Redzikowo, e che fin dalla loro costruzione alimentarono nei russi la paura che i moduli di lancio “canister” Mk.41 per gli antiaerei SM-3, potessero nascondere missili da crociera Tomahawk a testata nucleare, violando l’INF.

Parimenti gli americani accusarono, sotto Obama e anche sotto il primo mandato di Trump, i russi di contravvenire al medesimo trattato con lo sviluppo del missile da crociera Novator 9M729, o SSC-8, su cui ancora si sa poco, nonostante sia in servizio dal 2018, che Mosca sostiene di gittata inferiore a 500 km, mentre Washington ribatte superi 2000 km.
Ciò unito al fatto che Trump e l’allora segretario di Stato Mike Pompeo giudicarono “non buono” lNF in quanto eredità della Guerra Fredda USA-URSS che lasciava fuori la Cina e la sua enorme flotta di missili a medio raggio, molti puntati su Taiwan, portò gli Stati Uniti a ritirarsi dal trattato INF nell’agosto 2019. La decadenza di questo ulteriore trattato ha cagionato il ritorno del pericolo insito in missili a medio raggio, spesso ipersonici, la cui eccessiva vicinanza alle rispettive frontiere e i cui ridottissimi tempi di volo, con conseguenti tempi di valutazione e reazione, da parte dei vertici politici e dei comandi militari, compressi in pochissimi minuti, aumentano a livelli intollerabili l’eventualità di una guerra scoppiata per errore.
Gli americani hanno negli ultimi anni via via progettato e immesso in servizio vari sistemi missilistici a medio raggio. Nel 2023 sono divenuti operativi con l’US Army il missile ipersonico LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, da rampa mobile autocarrata, con gittata di 2700 km e velocità non dichiarata, ma “superiore a Mach 5”, cioè oltre 6000 km/h, e anche il sistema lanciamissili Typhon, che è in grado indifferentemente di lanciare missili antiaerei SM-6 e missili da crociera a testata nucleare Tomahawk.
Sistemi che sono già stati schierati in Europa e Asia per esercitazioni nel 2024, ma che dal 2026 verrebbero dislocati in permanenza in Germania. Al margine inferiore della categoria a medio raggio c’è poi il missile tattico PrSM, Precision Strike Missile, che si aggirerebbe sui 500 km e sarebbe un po’ il corrispettivo USA dell’Iskander.
I russi a loro volta hanno fatto debuttare a sorpresa, proprio nella guerra d’Ucraina, il loro nuovissimo missile Oreshnik, derivato dell’RS-26 Rubezh, con gittata variamente stimata fra 1800 e 3000 km e velocità terminale di ben Mach 10, cioè 12.000 km/h. Impiegato per la prima volta nel novembre 2024 in un attacco su Dnipro, l’Oreshnik porta sei testate a bersaglio indipendente che, nella versione convenzionale, si suddividono esse stesse in submunizioni, ma potrebbero essere parimenti rimpiazzate da altrettante testate nucleari.
Sia Trump, sia Putin sanno che nell’arco dei prossimi mesi bisognerà in qualche modo riprendere a parlare del dossier sulle armi a medio raggio, che sul ristretto territorio del continente europeo possono rappresentare una vera dinamite.
Ma sanno anche che hanno tempo fino a febbraio 2026 per decidere se rinnovare ed estendere ulteriormente il trattato New START che limita armi nucleari strategiche e relativi vettori, a circa 1.550 testate e 700-800 vettori per parte, tra missili intercontinentali, bombardieri a lungo raggio e sottomarini.

Un trattato che, firmato nell’aprile 2010 a Praga dagli allora presidenti Dimitri Medvedev e Barack Obama (nella foto sopra), è entrato in vigore nel febbraio 2011 con durata decennale. Il primo rinnovo del New START, nel febbraio 2021, fu concordato da Putin con l’appena insediato Joe Biden, ma per soli cinque anni. Il New START scadrà il 5 febbraio 2026 ed entro quella data l’amministrazione Trump intende completare la pur difficile normalizzazione con la Russia.
Ma non sarà facile. Già nel 2020, col pretesto della pandemia Covid-19, le ispezioni reciproche nelle basi nucleari vennero sospese e mai più riprese.
Lo scoppio della guerra in Ucraina ha poi aggravato il già plumbeo clima, portando il 21 febbraio 2023 Putin a sospendere unilateralmente l’applicazione del trattato da parte russa, pur garantendo che Mosca non ne sarebbe uscita, né che avrebbe aumentato il numero delle testate nucleari strategiche e dei vettori.
Sul filo del rasoio
Nel quadro di una guerra che prosegue ancora dopo più di tre anni e di un attrito Russia-NATO che non accenna a diminuire, un “assaggio” di ciò che c’è sul tavolo fra Mosca e Washington è stato dato il 13 marzo 2025 dal Washington Post, che ha pubblicato indiscrezioni su un “piano segreto” sviluppato da un istituto vicino al servizio segreto russo FSB e “intercettato da un servizio segreto di un paese europeo”, piano che contempla le condizioni di massima della Russia per un cessate il fuoco.
L’intelligence russa reputa che “una pacifica soluzione del conflitto non sia possibile prima del 2026”. Il piano studiato dall’FSB osteggia ovviamente truppe di peacekeeping occidentali in territorio ucraino e non si limita a chiedere la sovranità russa sui territori finora occupati, bensì anche su due “zone cuscinetto” a protezione dei confini della Russia.
Una di queste fasce di sicurezza si avrebbe sui confini con le regioni russe di Bryansk e Belgorod, l’altra, nel Sud, sarebbe una “fascia smilitarizzata” che comprenda Odessa, il maggior sbocco sul mare dell’Ucraina. Fra le condizioni di pace individuate dall’FSB ci sarebbe anche un cambio di regime a Kiev, e vi è contemplata anche la citata offerta agli USA di minerali e terre rare russi.

Un punto molto cruciale del piano prevede da parte della Russia la proposta di non schierare in Bielorussia e sui confini con l’Unione Europea i nuovi missili a medio raggio Oreshnik, in cambio del non dispiegamento in Europa di sistemi similari americani, come il Dark Eagle o il Typhon.
Anche di questi argomenti hanno evidentemente parlato, sotto stretto riserbo, Putin e Trump, nonché l’inviato americano Steve Witkoff nei suoi rendez-vous coi russi a Riad e Mosca, oltre agli stessi capi dei maggiori servizi d’intelligence, cioè il capo dei servizi segreti esterni russi, SVR, Sergej Narishkin, e il capo della CIA John Ratcliffe, che secondo Mosca hanno avuto lo scorso 24 aprile una telefonata “costruttiva”.
Lo stesso giorno, l’ex-ministro della Difesa russo, e attuale segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Sergej Shoigu ha spiegato una lunga intervista all’agenzia TASS che “siamo pronti al dialogo con gli USA sulla stabilità strategica, ma solo se saranno contemplati tutti i fattori che hanno un impatto sulla sicurezza, come l’espansione della NATO, la costruzione di un sistema di difesa missilistico globale e lo schieramento di missili a corto e medio raggio”.
Ha aggiunto Shoigu: “L’attuale crisi nel controllo delle armi strategiche e del disarmo è diretta conseguenza della politica spericolata della precedente amministrazione USA”.
Ma il più pesante monito dell’ex-ministro della Difesa russo è stato questo: “Nel novembre 2024 sono state apportate modifiche ai Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare, in base alle quali la Russia si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione. Monitoriamo i preparativi militari dei Paesi europei e nel caso in cui Stati stranieri commettano azioni ostili che rappresentino una minaccia a sovranità e integrità territoriale della Federazione, riteniamo legittimo adottare misure simmetriche e asimmetriche necessarie per reprimere tali azioni e impedirne la ripetizione”.

Questo in quanto “la deterrenza nucleare viene attuata nei confronti di Stati e coalizioni militari (NATO, n.d.r.) che considerano la Russia un potenziale nemico e possiedono armi di distruzione di massa o un significativo potenziale di combattimento di forze multiuso”.
In questo clima, il giornale inglese Telegraph ha riferito il 6 maggio che la Gran Bretagna si prepara a un possibile attacco russo, anche nucleare, rispolverando piani segreti di protezione delle infrastrutture strategiche e dei posti di comandi militare ad alti livelli.
E negli Stati Uniti, già impegnati in un vasto programma di rinnovamento del proprio arsenale nucleare, come base per poi ritrattare una comune stabilità insieme alla Russia, man mano che i tempi matureranno, è stato dato risalto a nuove iniziative, come l’ultima versione della celebre bomba termonucleare aerotrasportata B61.
B61-13 e Golden Dome
E’ la B61-13, il cui primo esemplare completato è stato presentato il 19 maggio negli stabilimenti Pantex di Amarillo, in Texas, dove “nascono” le testate nucleari americane. Stando al Segretario all’Energia Chris Wright, il cui dipartimento ha la competenza sullo sviluppo industriale delle testate nucleari, la nuova versione della bomba è stata realizzata con quasi un anno di anticipo sul programma, intuibilmente accelerato di fronte alle evoluzioni internazionali, dato che Wright ha apertamente citato “l’urgenza che ci troviamo ad affrontare per rafforzare la deterrenza in una nuova era instabile”.
La B61-13 (nella foto sotto testata su un F-35A) è una variante di tipo eminentemente strategico, con potenza massima stimata fra 340 e 360 kilotoni, e impiego previsto solo dalle stive dei bombardieri strategici “stealth” Northrop B-2 Spirit e B-21 Raider, tanto che l’entità della produzione dovrebbe limitarsi a “poche dozzine di esemplari”. Oltre a vantare una guida terminale per colpire con la massima precisione gli obbiettivi, la B61-13 è accreditata di una notevole capacità di perforazione sotterranea per centrare bunker a grande profondità.

Appena il giorno dopo, il 20 maggio, il presidente Trump ha sbandierato l’avvio del programma di sviluppo del cosiddetto Golden Dome, la “Cupola d’Oro”, che dovrebbe garantire, nelle intenzioni di Washington, una protezione antimissile integrale del Nordamerica, il cui nome si richiama all’Iron Dome israeliano, di cui si avrebbe l’ambizione di “pantografare” su scala continentale la protezione integrale di un territorio nazionale piccolo e “facile” come quello di Israele.
Trump ne aveva accennato già in gennaio, ma ora è stato più preciso, parlando di un investimento iniziale di 25 miliardi di dollari, che aumenteranno a ben 175 miliardi nell’arco di tre anni.
A differenza dell’attuale difesa antimissile nordamericana, fondata, per la fase di mezza corsa dei missili nemici, sugli intercettori GBI di base a Fort Greely, in Alaska, e a Vandenberg, in California, il programma Golden Dome, che secondo Trump potrebbe essere pronto già nel 2029, ma che stime più caute degli esperti del CSIS (Center for Strategic and International Studies) collocano più plausibilmente nel 2035, dovrebbe constare di “intercettori basati nello spazio”, ossia satelliti in orbita in grado di rilevare e colpire, forse con armi a raggi laser o particelle o onde ad alta energia, una pletora di minacce, dai tradizionali missili intercontinentali alle testate plananti ipersoniche sul tipo del sistema russo Avangard, ai missili da crociera, anche ipersonici, di nuova generazione.
Trump sta mobilitando a tale scopo una cordata industriale che sarebbe guidata da Lockheed Martin, ma con fortissima partecipazione della SpaceX di Elon Musk, probabilmente anche per sfruttare la pervasività della rete di satelliti Starlink per supportare il sistema difensivo dal punto di vista della condivisione dei dati in tempo reale.

E’ ancora presto per dire se il Golden Dome si rivelerà una replica delle “guerre stellari” annunciate nel 1983 da Ronald Reagan col programma SDI, Strategic Defense Initiative, rivelatosi un bluff per convincere l’Unione Sovietica che gli Stati Uniti sarebbero divenuti invulnerabili a un attacco atomico. Di certo, potrebbe rappresentare il culmine per l’ossessione dell’America per il sogno di una difesa antimissile senza limiti, già esplicitato dallo stracciare nel 2002 il trattato ABM.
Che però porta anche alla già citata illusione di poter fermare ogni ordigno nucleare diretto verso il Nordamerica, facendo credere a Washington di poter, eventualmente, attaccare per prima senza timore di devastanti rappresaglie.
Comunque, il 6 giugno, il viceministro della Difesa russo Sergei Ryabkov ha ammonito gli Stati Uniti: “Il progetto americano Golden Dome trasforma lo spazio in un’arena di confronto armato”.
Vero è che il Golden Dome potrebbe essere sfruttato dalla Casa Bianca come spauracchio in sede di negoziati con la Russia per ottenere una generale riscrittura dei trattati sugli armamenti strategici, contando che a febbraio 2026 andrà rinnovato il New START, in scadenza, che limita le testate strategiche e i loro vettori.
Il fatto che Trump sostenga che il Golden Dome possa essere pronto “entro il 2029”, cioè entro il termine del suo mandato presidenziale, in tempi quindi stranamente ristretti per un progetto così complesso, anche a tener conto che si utilizzerebbero tecnologie già maturate per Starlink, potrebbe deporre a favore di un uso “diplomatico” del dossier Golden Dome, che quindi potrebbe essere, almeno per il momento, una “tigre di carta” come il vecchio SDI di Reagan.
La deterrenza è comunque a rischio e ai ricorrenti test russi di missili intercontinentali a testata nucleare hanno risposto gli Stati Uniti lo scorso 22 maggio lanciando da Vandenberg un Minuteman III che ha colpito con la sua testata inerte l’area bersaglio nell’atollo di Kwajalein, nelle Isole Marshall, dopo una parabola di 6700 chilometri.
Tutti segnali che indicano come il rapporto fra USA e Russia sia a un bivio. Sia a Mosca, sia a Washington si sente infatti l’urgenza di archiviare gli ultimi anni di tensioni volente, piaccia o meno all’Unione Europea, che non ha un peso strategico sufficiente a imporsi su un tavolo simile, e addivenire a una nuova stagione di patti, prima che la finestra di opportunità apertasi con il cambio di amministrazione alla Casa Bianca cominci a richiudersi in caso di equivoci, malintesi o voluta malafede, condannando il mondo a una stagione di neo-Guerra Fredda che potrebbe diventare cronica.
Il tempo stringe
Su quanto possa durare la fase di transizione che può segnare la possibilità di accordi globali fra USA e Russia, di cui lo scacchiere ucraino sarebbe solo uno dei temi in discussione, non ci si possono fare illusioni. Non sarà lunga e le crescenti esternazioni di Trump, che a fine maggio più volte ha lanciato segnali di impazienza nei confronti di Putin, indicano che certamente la pazienza degli Stati Uniti ha un limite.
Pur sapendo che in questo momento storico la priorità assoluta dovrebbe essere isolare la Cina, o almeno allentare il legame Mosca-Pechino offrendo riconoscimenti e stabilità in Europa alla Russia, accogliendo in parte la percezione del Cremlino, non sfuggono agli americani i pericoli insiti nella mobilitazione militare russa, che potrebbe implementare ancor di più le minacce già palesi negli anni scorsi con la nuova generazione di armi strategiche e ipersoniche svelate da Putin nel 2018.
A tal proposito, è significativo il rapporto divulgato il 24 maggio dalla DIA, la Defense Intelligence Agency, il cui direttore, il generale dell’US Air Force Jeffrey Kruse, in carica ai vertici della DIA da febbraio 2024 e che già dal 2016 al 2019 aveva guidato il ramo intelligence dell’US Indo-Pacific Command, ha consegnato alla Commissione Forze Armate della Camera USA una dettagliata rassegna delle minacce globali con cui gli USA si debbono misurare nel corso del 2025.
Sono le 45 pagine del “2025 Worldwide Threat Assessment”, che a proposito della Russia mettono in guardia anzitutto Washington sul fatto che la guerra in Ucraina viene considerata vitale per gli interessi di Mosca e dunque ogni tentativo di normalizzazione dovrà passare da lì.
“Il presidente russo Vladimir Putin considera la guerra in Ucraina una lotta esistenziale contro l’Occidente che determinerà il posto della Russia nel mondo, la conservazione del potere di Putin e la sua eredità storica. Putin rimane fiducioso nella vittoria finale della Russia in Ucraina ed è pronto a ricorrere alla forza militare almeno attraverso l’intero 2025”. Il traguardo sarebbe sempre completare la conquista delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson.
Il rapporto è molto chiaro però nell’affermare che la Russia non pensa di aggredire la NATO, trattandosi di una mossa catastrofica: “A dispetto degli aiuti occidentali all’Ucraina, la Russia quasi certamente cerca di evitare un conflitto diretto con la NATO poiché sa che non può vincere un confronto convenzionale con l’alleanza. Comunque Mosca rimane pienamente capace di impiegare tecniche asimmetriche contro gli Stati Uniti e gli alleati, incluse le campagne di cyberguerra e di informazione e dispone di una capacità di minaccia esistenziale con le sue forze nucleari strategiche in grado di raggiungere il territorio nazionale USA”.
Si evidenzia che le forze convenzionali russe sono impegnate soprattutto nel conflitto ucraino e pertanto la loro capacità di minacciare direttamente la NATO è “degradata”, mentre la mobilitazione industriale sembra rivolta soprattutto a “sostenere lo sforzo bellico rimpiazzando l’equipaggiamento esistente anziché sviluppare armi nuove, con l’eccezione dei sottomarini”.
Inoltre, la DIA stima che la spesa militare russa per il 2025 toccherà circa 150 miliardi di dollari, con un aumento del 19%, al netto dell’inflazione, rispetto al 2024, equivalendo “circa al 40% del bilancio federale russo”. Uno specifico passo evidenzia l’accresciuto ruolo della Marina Russa nello scacchiere globale: “La Marina Russa quasi certamente servirà come il primo strumento di proiezione della potenza globale della Russia nel prossimo anno. Ha dislocato unità navali in America Latina e schierato nella regione un sottomarino nucleare per la prima volta dalla caduta dell’Unione Sovietica. Ha anche condotto in settembre scorso l’esercitazione globale multi-flotta Okean 2024. Ha inoltre dispiegato nel Pacifico nuovi sottomarini lanciamissili balistici e da crociera e da attacco”.
La DIA osserva un logoramento dell’aviazione russa a causa del suo “sovraimpiego” in Ucraina, ma riconosce che le forze aeree di Mosca si sono dimostrate efficaci nel conflitto, anche sfoderando nuove tattiche come l’uso esteso delle bombe plananti.
Si rammenta il programma di armi spaziali russe, fra cui “una che porta un ordigno nucleare”, e lo sviluppo di “armi controspaziali non nucleari” fra cui sistemi laser e missili lanciati da terra.
Sul versante delle forze nucleari, “la Russia sta espandendo le sue capacità” con nuovi sistemi “inclusi missili aria-aria”, usando la “retorica nucleare” come “deterrenza verso il percepito coinvolgimento dell’Occidente in Ucraina”. Inquietante è poi l’accenno alla prosecuzione di “programmi di guerra chimica e batteriologica”, di cui farebbe parte una “quarta generazione di gas nervini”.

Sul versante geopolitico, infine, il rapporto segnala la “destabilizzazione russa” in aree come l’Africa, e nello specifico le nazioni della fascia del Sahel, dove “Mosca può competere con l’Occidente a prezzo di investimenti relativamente bassi”.
La DIA dimentica però, in tal caso, che l’espansione dell’influenza russa in Africa è in gran parte frutto della crescente disaffezione di popolazioni e governi locali nei confronti della precedente potenza egemone, la Francia, che dopo decenni di eredità postcoloniale è stata costretta via via ad arretrare le sue posizioni.
La Russia, in sostanza, viene ancora considerata pienamente dagli Stati Uniti una minaccia, certo ancora la principale in termini tecnologico-nucleari-spaziali, pur tallonata dalla Cina. Ma trattandosi di un impero con cui, fin dai tempi sovietici, Washington ha una lunga tradizione di dialogo, è anche potenzialmente la più “gestibile” delle minacce, a differenza della Cina e di altre realtà, come Iran o Corea del Nord, percepiti sempre come mondi altri, con cui il negoziato può essere reso più arduo da pregressi storici e culturali molto più diversificati.
Essendo inoltre la Russia divenuta sempre più negli ultimi anni, come epicentro del gruppo di nazioni emergenti BRICS e non solo, un punto di riferimento per tutti gli avversari dell’America, ben si capisce come Washington, direttamente o indirettamente, stia tentando di tutto per un nuovo patto di sicurezza bilaterale con Mosca, che avrebbe effetti a cascata indebolendo il fronte avverso. I prossimi mesi saranno quindi ancor più cruciali per stabilire, in base alla volontà di entrambi i governi, che direzione prenderà il mondo.
Foto: Casa Bianca, TASS,, Ministero Esteri Russo, Presidenza Ucraina, Saab, US DoD, ISW, Tasnim e Lockheed Martin.

Mirko MolteniVedi tutti gli articoli
Nato nel 1974 in Brianza, giornalista e saggista di storia aeronautica e militare, è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e collabora col quotidiano “Libero” e con varie riviste. Per le edizioni Odoya ha scritto nel 2012 “L'aviazione italiana 1940-1945”, primo di vari libri. Sempre per Odoya: “Un secolo di battaglie aeree”, “Storia dei grandi esploratori”, “Le ali di Icaro” e “Dossier Caporetto”. Per Greco e Greco: “Furia celtica”. Nel 2018, ecco per Newton Compton la sua enciclopedica “Storia dei servizi segreti”, su intelligence e spie dall’antichità fino a oggi.