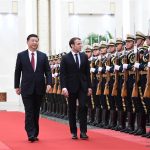Il rapporto dell’ONU su Gaza tra diritto internazionale, dottrina militare e sfide geopolitiche

Il rapporto A/HRC/60/CRP.3, presentato al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, sta suscitato un dibattito di sicura rilevanza giuridica e politica, con profili anche sugli aspetti militari, destinato comunque ad altre polemiche: la sfida è se servirà a salvare la popolazione civile palestinese quando le incognite sono ancora incombenti sul suo futuro, sull’intero scenario mediorientale, e non solo.
Il documento formula accuse precise a carico di Israele, sostenendo che le operazioni militari a Gaza abbiano comportato condotte in cui si configurerebbero i tratti di extermination, intentio necandi, dolus specialis genocidario, concetti giuridici che trovano radice nella giurisprudenza dei tribunali internazionali postbellici e negli articoli della Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.
Non si tratta quindi di un lessico generico, ma di espressioni tecniche con implicazioni dirette sul piano della responsabilità internazionale degli Stati e dei singoli comandanti. Si parla di uccisioni sistematiche, di inflizione di gravi danni fisici e psicologici, di condizioni di vita imposte che rendono impossibile la sopravvivenza, fino alla distruzione delle strutture sanitarie e dei presidi per la salute riproduttiva. È l’articolo II della Convenzione sul genocidio che viene evocato, punto per punto.

La Commissione aggiunge un elemento decisivo: le dichiarazioni pubbliche di leader e comandanti israeliani, che parlano di “distruzione totale” o di “annientamento” dei palestinesi di Gaza. Per i commissari queste frasi non sono retorica bellica, ma tasselli che compongono la prova dell’intentio necandi, cioè la volontà di distruggere il gruppo. Secondo la Commissione, le pratiche di guerra adottate da Israele corrispondono alla creazione deliberata di “condizioni di vita intollerabili”, che configurano l’ipotesi genocidaria quando combinate con dichiarazioni pubbliche di “distruzione totale” o “annientamento” della popolazione palestinese.
Il testo non parla genericamente di retorica bellica, ma evoca esplicitamente lo “special intent”, l’“intent to destroy” o addirittura l’“intent to annihilate”, categorie che nella giurisprudenza del Ruanda e di Srebrenica hanno rappresentato gli indizi più forti di volontà genocidaria.
Il rapporto mette in evidenza non solo l’elevatissimo numero di vittime civili – con stime (ancora da riscontrare compiutamente) di organismi ONU che parlano oggi di oltre 70.000 morti – ma anche l’impatto devastante sulle infrastrutture vitali: ospedali, scuole, impianti idrici ed energetici. A rafforzare il quadro accusatorio sono richiamati principi fondamentali del diritto bellico: l’articolo 48 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977) che impone la distinzione tra obiettivi civili e militari; l’articolo 51, che proibisce attacchi indiscriminati e sproporzionati; l’articolo 54, che tutela beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

Tale formulazione è destinata a riverberarsi nei lavori della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e della Corte Penale Internazionale (CPI), aprendo scenari complessi di responsabilità individuali e statali. Precedenti rapporti ONU, come quello su Darfur (2005) o sul conflitto in ex-Jugoslavia negli anni ’90, pur avendo sollevato resistenze politiche, hanno avuto l’effetto di accelerare processi giudiziari e di legittimare l’azione della giustizia internazionale. Tuttavia, occorre sottolineare che la valenza del rapporto odierno, pur altamente rilevante, va contestualizzata: si tratta di un documento che offre un quadro interpretativo e probatorio, ma che necessiterà di ulteriori verifiche giuridiche e procedurali per tradursi in effetti vincolanti.
La cornice militare: dottrina, manuali e limiti operativi
Sul piano operativo, le accuse del rapporto vengono confrontate con le dottrine militari di riferimento. Il US Department of Defense Law of War Manual (2016) stabilisce con chiarezza che “gli attacchi devono essere diretti esclusivamente contro obiettivi militari e non devono essere sproporzionati rispetto al vantaggio militare concreto e diretto atteso”. Si tratta di un principio cardine della moderna legge di guerra, volto a ridurre al minimo le vittime civili, pur nel contesto della necessità militare.
Dal lato israeliano, il Codice etico delle Israel Defense Forces (IDF), noto come Ruach Tzahal, sancisce la “purity of arms”: i militari sono tenuti a usare la forza solo nella misura necessaria, mantenendo l’umanità anche nei confronti del nemico. Lo stesso manuale operativo israeliano, aggiornato dopo le guerre di Libano e le operazioni a Gaza del 2008-2014, insiste sulla necessità di “limitare danni collaterali” e “garantire proporzionalità” negli attacchi in aree urbane.

Tuttavia, la difficoltà operativa è accentuata dalla strategia di Hamas, che secondo le intelligence occidentali e i rapporti NATO utilizza infrastrutture civili come scudi: depositi di armi in scuole, tunnel sotto ospedali, lanci di razzi da aree densamente abitate. È qui che si colloca il cuore della controversia: Israele rivendica il diritto alla difesa contro un attore che pratica il terrorismo e che, nelle parole di numerosi analisti militari, “si mimetizza nella popolazione civile”. In questo quadro si inseriscono le valutazioni di figure come il generale David Petraeus, ex comandante delle forze USA in Iraq e Afghanistan, che ha sottolineato come le IDF operino in un contesto operativo “tra i più difficili al mondo”, ma ha al contempo ammonito che “la percezione internazionale di sproporzione può avere effetti strategici devastanti, anche se le operazioni rispettano i parametri militari interni”.
Gli istituti di difesa occidentali — dal Royal United Services Institute (RUSI) di Londra all’International Institute for Strategic Studies (IISS) — convergono nel rilevare che l’elevato numero di civili morti mina la legittimità politica delle operazioni israeliane, indipendentemente dalle giustificazioni militari. Alcuni studi, come quelli della rivista Lancet, hanno evidenziato che la portata delle vittime civili rischia di configurare non solo un disastro umanitario, ma anche un “precedente destabilizzante per il diritto internazionale umanitario”, in quanto potrebbe erodere la forza normativa delle Convenzioni di Ginevra.
Impatti geopolitici, posizioni statali e nuove linee di frattura
L’impatto del rapporto ONU non si esaurisce sul piano giuridico-militare, ma si traduce in nuove linee di divisione geopolitica. Gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, hanno ribadito il sostegno alla sicurezza di Israele, pur con segnali di pragmatismo legati ai negoziati regionali: il senatore Marco Rubio ha svolto un ruolo di mediatore, sottolineando la necessità di “non abbandonare i civili palestinesi alla disperazione, ma al tempo stesso di non legittimare Hamas come interlocutore politico”.

L’Unione Europea appare divisa: da un lato Paesi come Spagna e Irlanda spingono per un riconoscimento formale delle accuse e hanno aperto alla possibilità di sanzioni mirate contro ufficiali israeliani; dall’altro, Francia e Germania insistono su un approccio più prudente, mentre l’Italia cerca una linea di equilibrio tra sostegno umanitario e rapporti strategici con Israele. La Commissione europea, nelle ultime settimane, ha ventilato la possibilità di anticipare sanzioni nel settore degli armamenti e della cooperazione tecnologica.
Sul fronte internazionale, Russia e Cina sfruttano il dossier per accusare l’Occidente di doppi standard, mentre la Turchia ha adottato una retorica di forte condanna, chiedendo la sospensione di ogni cooperazione militare con Israele. Nei Paesi arabi, il dibattito è altrettanto acceso: Egitto, Qatar e Giordania si muovono tra la pressione delle opinioni pubbliche e la necessità di evitare un’escalation incontrollata. Particolarmente significativa è la posizione del Cairo: l’Egitto rifiuta con fermezza di ospitare grandi flussi di rifugiati palestinesi, sostenendo che ciò equivarrebbe a “un trasferimento forzato della popolazione e a una vittoria indiretta di Hamas e Israele a scapito della causa palestinese”.
Questo punto apre uno scenario cruciale: chi si farà carico di un eventuale esodo palestinese che, secondo alcune proiezioni ONU, potrebbe interessare tra i 2 e i 3 milioni di persone? Le conseguenze non riguarderebbero solo il Medio Oriente, ma anche il Mediterraneo e l’Europa, con il rischio di nuovi flussi migratori di massa, tensioni politiche interne e destabilizzazione delle relazioni con i partner regionali.
Precedenti storici, limiti dei rapporti ONU e prospettive future
Il valore del rapporto A/HRC/60/CRP.3 va compreso anche alla luce dei precedenti. Dopo la Seconda guerra mondiale, i rapporti delle Nazioni Unite sui conflitti in Corea, Vietnam, Ruanda, ex-Jugoslavia e Darfur hanno avuto un peso variabile. Alcuni, come quelli sul genocidio ruandese, hanno contribuito alla creazione di tribunali ad hoc e a condanne effettive; altri, come quelli sul Vietnam, sono rimasti confinati a denunce politiche senza conseguenze giuridiche vincolanti. Questo dimostra come la portata dei rapporti ONU dipenda non solo dalla forza delle prove raccolte, ma anche dal contesto politico e dagli equilibri di potere nel Consiglio di Sicurezza.

Il rapporto su Gaza si colloca dunque in una dimensione ancora da verificare: è certamente tra i più rilevanti dell’ultimo decennio sul piano del diritto internazionale e potrebbe rafforzare l’azione della CPI, ma il suo impatto dipenderà dalla capacità della comunità internazionale di tradurlo in iniziative concrete.
Sul piano militare, rimane il dilemma irrisolto: come conciliare il diritto alla difesa di Israele con la necessità inderogabile di proteggere la popolazione civile palestinese. I manuali militari statunitensi e israeliani, come visto, prescrivono chiaramente la distinzione e la proporzionalità; eppure, il campo di battaglia urbano di Gaza, reso ancora più complesso dall’uso strumentale dei civili da parte di Hamas, porta a risultati che appaiono contraddittori rispetto a quei principi.
Conclusioni: scenari realistici e sfide aperte
Le prospettive future sono complesse e aperte a scenari multipli. È probabile che il rapporto ONU venga utilizzato come base giuridica per intensificare i procedimenti davanti alla CPI e come leva politica in seno al Consiglio di Sicurezza, anche se il veto statunitense continuerà a rappresentare un ostacolo a risoluzioni vincolanti. Sul terreno, la prosecuzione delle operazioni israeliane e la resilienza di Hamas indicano che non vi sarà una soluzione immediata.

Sul piano regionale, il rifiuto dell’Egitto di farsi carico di masse di rifugiati palestinesi sottolinea un nodo cruciale: l’eventuale grande esodo non troverebbe facilmente sbocchi e rischierebbe di spostare l’instabilità dal Medio Oriente al Mediterraneo, fino a coinvolgere direttamente l’Europa. La gestione di un tale scenario richiederebbe un coordinamento internazionale senza precedenti, con forti implicazioni in termini di sicurezza, politica migratoria ed equilibri energetici.
In definitiva, il rapporto ONU A/HRC/60/CRP.3 rappresenta un banco di prova per il diritto internazionale e per le capacità della comunità internazionale di affrontare le sfide geopolitiche, giuridiche e militari di un conflitto che non è più solo regionale, ma è sempre di più destinato a ridefinire gli equilibri globali.
Foto IDF
Leggi anche:
Fallire la guerra asimmetrica: Israele, Hamas, ed il prezzo della perdita dei principi

Maurizio Delli SantiVedi tutti gli articoli
Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Docente a contratto presso l'Università Niccolò Cusano, in Diritto Internazionale Penale/Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e Controterrorismo, è autore di varie pubblicazioni, tra cui "L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici", Aracne, 2015. Collabora con diverse testate italiane ed europee.